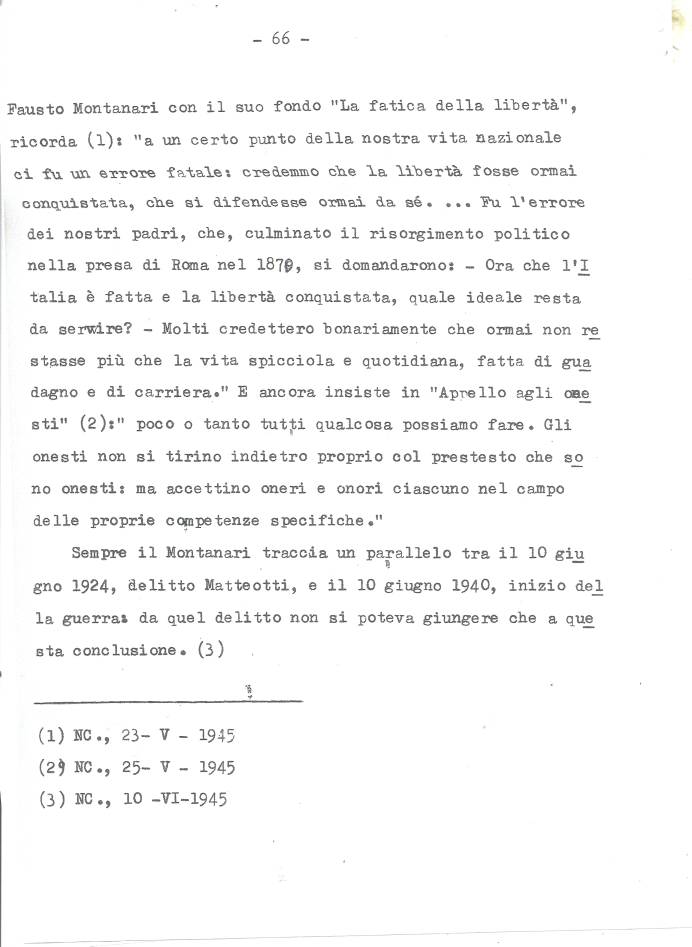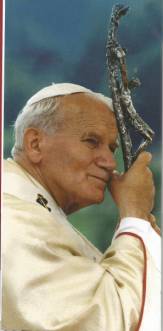INDICE
1)
Clara
Rubbi Longo, I Rubbi - Storia di una Famiglia (2017, Ecig)
2)
Paolo
Antognetti, Il passato ritorna (2019, Jaimar Editore)
3)
Claudio
Papini, Marx 1968 – IV – Filosofia e ideologia in Marx (De Ferrari Editore)
4)
Giglio
Reduzzi, Rudimenti di Economia (autopubblicato)
5)
Claudio
Papini, -Traduzione e introduzione de Daniel Massé, L’Apocalisse e il Regno di Dio -
- L’Apocalisse, unico
vangelo cristiano nel II secolo, Apuleio, Luciano. (De Ferrari Editore)
6)
Paolo
Rumiz, Il filo infinito - Viaggio tra i monasteri alle radici d’Europa (2019,
La Repubblica)
7)
Monica
Bulay, Mostra al Ducale di Genova (2008), Intervista di Maria Luisa
Bressani
8)
Guido
Barbazza, Il Genovese Volante, (2020 Il Canneto Editore)
-
Rewind (2012, De Ferrari)
-
Genova
e Trieste
9) Il
cardinale Giuseppe Siri e la Storia di Genova, in Tesi di Maria Luisa Bressani
per la SSCS (1993/94)
Clara Rubbi Longo
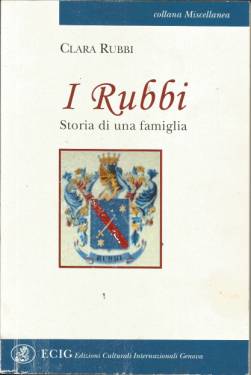
In questo suo
ventiquattresimo libro “I Rubbi” (Ecig Edizioni), storia della sua famiglia, ci sono parole molto significative che
la mamma dell'Autrice, Ninetta
Pecorella sposa di Bruno Rubbi, disse a lei, la primogenita delle famiglia. Non
voleva che l’aiutasse in cucina, né che imparasse a cucire lei che sapeva fare
autentici capolavori con uncinetto, ago e filo, e una volta le disse: “Clara non devi far altro che quello per cui sei nata,
‘leggere, studiare, scrivere’”.
Parole tanto più importanti
in quel tempo se suo nonno materno, il commendatore Cosimo, affermava: “Le
donne troppo istruite non trovano marito. Non fatela studiare”. E suo padre non
era da meno: “Al massimo potrà fare la maestra, se proprio vuole studiare”. Così
l’intelligente mamma Ninetta la iscrisse al Liceo-Ginnasio Cristoforo Colombo,
falsificando la firma paterna che allora era richiesta e quindi indispensabile.
Clara Rubbi ha conseguito
due lauree, per molti anni è stata docente di lettere in vari Licei della
città, critico teatrale, iscritta all’Ordine dei giornalisti della Liguria,
presidente del Lyceum Club di Genova e insignita nel 2013 dell’onorificenza di
“Commendatore al merito della Repubblica Italiana”.
Come scrittrice ha avuto
moltissimi premi: il Bancarella, il Bancarellino, il Premio della Regione
Liguria, il Premio Carrara.
La foto seguente testimonia
una di queste premiazioni.
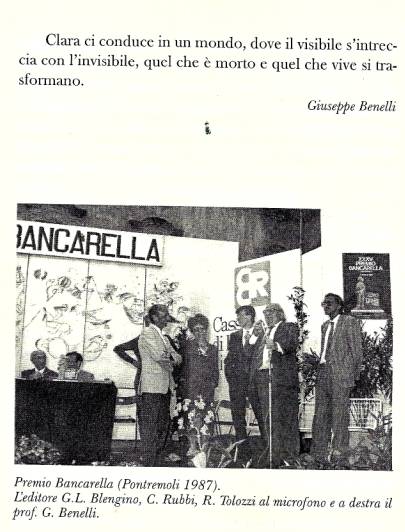
Foto tanto più importante
perché il primo da destra è Giuseppe Benelli che ha firmato l’Introduzione al
libro. In quarta di copertina Clara ha inserito queste parole del Professore:
“Ad una certa età il bisogno di ‘consegnare’ il proprio mondo affettivo si fa
più impellente, quasi ci fosse la necessità di segnare sulla carta figure che
hanno accompagnato e determinato la
nostra vita".
Dall’Introduzione di Benelli, che secondo me è impareggiabile
critico per sensibilità e cultura, mi ha colpito questo giudizio sulla
narrazione di Clara: “Con incantevole levità racconta
il mondo dei suoi affetti, i riti familiari, l’amore e la morte, quasi fossero
l’alternarsi delle stagioni”.
Il microcosmo dell’autrice
si allarga attraverso i personaggi, la madre che ho già ricordato ma anche la
suocera, donna Ida, al cui corteo funebre, in segno di rispetto e affetto, i
negozianti abbassano a metà le serrande dei negozi. Su tutti nella prima parte
del libro svetta il ritratto del padre. Figlio di contadini, orfano a otto
anni, un uomo che si fa da sé, biondo e bello e con gli occhi azzurri. Così
determinato a sposare la sua Antonietta (Ninetta) che per ottenerne la mano dal severo suocero Cosimo gli fornirà
la storia di famiglia, avuta tramite l’Araldica di Firenze e raccolta in un
volume pagato salatamene. Anzi Bruno
nel primo colloquio con lui (quando ancora non aveva commissionato la ricerca
sui suoi avi) gli dirà di sapere per certo che a Budapest esiste un grande
libro con i nomi delle famiglie nobili di tutta Europa, posto su un leggìo in
piazza, nella parte alta della città.
In breve la storia di famiglia
risale al 2019 quando i Rubbi erano già presenti a Bergamo. Nel 1552 la
famiglia fu aggregata al Consiglio dei Nobili che governavano la città. Tra i
discendenti don Antonio Rubbi, morto in fama di santo (interessantissima la
ricerca storica che lo riguarda) e un raffinato letterato Andrea Rubbi,
professore di teologia e poeta vissuta tra Sette/Ottocento, canonico di Santa
Maria Maggiore. A Venezia esistevano altri nobili di nome Rubbi, altri
cardinali a Bologna…
Però, dopo aver consultato
il libro dell’Araldica, Bruno fa uno strano sogno: vede la sua Ninetta in abito
da sposa ma si trova anche a duellare con un alter ego nella salita che lo
porta al castello di famiglia perché gli piovono addosso sassi da tutte le
parti. A duellare sono il Bruno popolano, ribelle al potere del conte (e quindi
tra i lanciatori di sassi) e il Bruno nobile, il conte che voleva veder morto
il figlio del popolo… Bruno sarà antifascista convinto. Una volta cercò di
salvare un impiegato dell’Ansaldo che abitava nel suo stesso Palazzo in via
Ambrogio Spinola da due fascisti in borghese venuti a prelevarlo. Non ci riuscì
e quell’uomo, Salvatore, figura nell’elenco dei Martiri del Turchino.
Torno alla sapiente
Introduzione di Benelli quando cita, da subito, parole di Shakespeare: “L'amore
non /muta con le sue brevi ore e settimane/ l’amore resiste fino alla soglia
del Giudizio”. Commenta il Professore: “Come a dire che i soli amori che
contano sono quelli infiniti, quelli che tendono un ponte tra il tempo e
l’eternità". E se Clara ha avuto l'esempio dell’amore dei genitori, Bruno
e Ninetta, a sua volta avrà un amore saldo, durato tutta la vita di sposi. A 15
anni al Liceo-Ginnasio Colombo s’innamora del suo professore Vincenzo Longo e
se si dice che le figlie padrizzano questi rassomiglia a suo padre perché come
lui è biondo, azzurro d’occhi e alto. Anche da parte del Professore si sviluppa
l’amore, ma lo manifesterà solo dopo il conseguimento da parte di Clara della
prima laurea, quando sarà lui ad accompagnarla nel cammino per la seconda.
Il finale del libro è
proprio tutto dedicato al marito Vincenzo, morto d'infarto la sera del 2
gennaio 2009. Da parte di lui restano per lei una dolce poesia e le parole di
questa lettera che un po’ la riassumono: "Sei stata della mia vita
l'Angelo custode in terra, correggendo ogni giorno le mie più vistose pigrizie,
dando ispirazione e nutrimento a quello che c'era in me di buono".
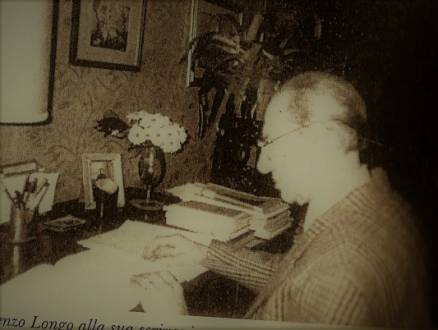
(Il Prof. Vincenzo Longo
alla sua scrivania)
Clara
è convinta - (ed ha raccolto testimonianze al riguardo e approfondito
l’argomento) che al termine della vita ci vengano incontro i nostri cari
per guidarci verso la luce. Così, a sua volta, chiude il suo racconto con parole
rivolte al marito: “Amore mio ritorna da me, vieni ancora ad accompagnarmi per
le strade della città che percorro da sola”.
Questa solitudine pur se
riempita con tante attività (il Lyceum, lo scriver libri interessanti, l'essere
riuscita a far istituire un “Premio Vincenzo Longo” e l’aver ottenuta per lui
l’intitolazione della scalinata che, guardando di fronte il Liceo D’Oria, è
sulla sua destra) mi ha riportato alla mente la poesia che Natalia Ginzburg
dedicò in morte al marito Leone:
"Sollevasti il lenzuolo per guardare il
suo viso,
ti chinasti a
baciarlo con un gesto consueto.
Ma era l’ultima volta.
E le mani eran quelle
Che
spezzavano il pane e versavano il vino...
Oggi ancora nel
tempo che passa sollevi il lenzuolo
A guardare
il suo viso per l'ultima volta.
Se cammini per
strada nessuno ti è accanto
Se hai paura
nessuno ti prende la mano
E non è tua
la strada, non è tua la città”.
E’il
senso alto di una comunione di spirito e cuore tra due persone.
Un aneddoto: Al Lyceum prima del Natale 2019 c’è stata la
presentazione del libro di Clara Rubbi da parte di Elisabetta di Palo.
La presentatrice, cara amica
della scrittrice, le ha chiesto perché non abbia inserito in questa storia di
famiglia anche alcuni episodi divertenti di cui lei era al corrente.
Ne cito due per
farvi sorridere.
Al Liceo-Ginnasio Colombo
dove Clara s’innamorò del Professore Vincenzo Longo che poi diventò suo marito
c’era un collega di questo, il Professor Tarditi un
po’ tanto sordo.
1) Un giorno ad un allievo che aveva chiesto di andare in
bagno aveva fatto segno di sì con la mano ed un altro, subito dopo, dal fondo
della classe, gli chiese: “Professore posso andare a letto con sua moglie?”
(era la goliardia nascente in quegli anni lontani che poi ebbe specie a Genova
divertenti sviluppi: qualcuno iscritto all'Università non studiava ma pensava
solo alla rappresentazione che avveniva ogni anno nei pubblici teatri e si chiamava Baistrocchi). E il Tarditi (che
forse aveva anche sentito ma intelligentemente fece finta di niente): “Aspetti
che c'è già un altro" (e alludeva al poter andare in bagno).
2) Secondo
episodio raccontato da Clara stessa.
Nel libro un capitoletto è
intitolato “Attenti alle compagne!". Il padre di Clara infatti era
comunista e partecipava agli incontri serali che il Partito organizzava per
catechizzare gli iscritti e le loro famiglie.
IL padre Bruno allora sulla quarantina era rimasto magro bello fiero e
le “compagne" se lo mangiavano con gli occhi. In quelle interminabili
riunioni di Partito si parlava anche di “amore libero" e per le donne del
“diritto a gestire il proprio sesso”. Ninetta, saggia mamma di Clara, lo
accompagnava sempre costretta a sorbirsi quelle interminabili riunioni pur di
non lasciarlo solo in balia delle compagne che se lo prendevano –disinvolte-
sottobraccio.
Noi in Italia vicinissimi al
Vaticano, siamo cresciuti con un particolar riguardo al culto della famiglia,
della religione, del timor di Dio, e pur se oggi i partiti hanno questioni più
urgenti da dirimere, possiamo chiederci se “la conquista dei diritti" non
sia stata spesso una decadenza di valori cristiani. Penso a Nilde Jotti, amante
di Palmiro Togliatti che non lasciò mai la moglie e questa sopportava il peso
della loro figlia handicappata, penso alle famiglie arcobaleno, ai gay pride,
alla pedofilia che ha rovinato ragazzini innocenti, penso a Bibbiano e alla
bambina strappata ai genitori per darla ad una coppia di lesbiche. Vi sembrano
diritti “civili?".
Sono contenta per me stessa
di pensarla diversamente e di scandalizzarmi
per costumi troppo liberi pur se mai ho discriminato. Amo per le fanciulle in fiore quel concetto del dolce Stil
Novo, della donna angelicata, credo che mai e poi mai si debba dar scandalo ad
un bambino o rovinare la sua innocenza. E questo non vuol dire discriminare.
Paolo Antognetti
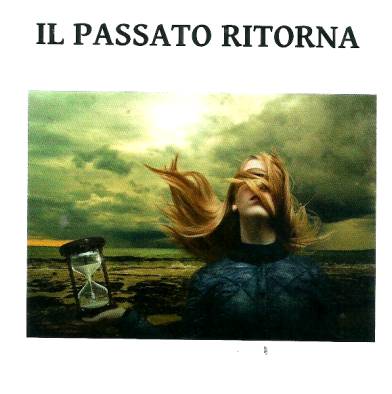
Paolo Antognetti,
appena laureato in Ingegneria, alla Facoltà di Genova, stava per essere
cooptato nella nascente Silicon Valley dove si cercavano i migliori cervelli,
ma preferì seguire la carriera universitaria in Italia. Più tardi si trasferì
in Svizzera dove divenne Imprenditore.
Figlio unico ha
voluto quattro figli e, per ora, ha un
nipote.
Ama scrivere e
ritiene che sia stato Piero Raimondi, suo professore di Lettere al D’Oria di
Genova, ad inoculargli questo “germe” o meglio “seme”, perché fecondo di
frutti.
I frutti: “L’arte
di vivere a lungo", Ed. Mediterranee (1966), e poi con Jaimar editore ha
pubblicato “Le radici del futuro” (2014), “L'isola sacra" (2017),
“Matrimonio nel Deserto” (2019).
Da ultimo – per
ora - e sempre con Jaimar “Il passato ritorna" (2019), un thriller
moderno, in cui il giallo si è più che mai noir.
Di alcuni
giudizi, riportati da Antognetti all’interno di copertina, ne scelgo uno molto
conotativo: “I temi portanti de ‘Il passato ritorna’ sono una summa dei problemi con cui la razza umana si trova a
confrontarsi da migliaia di anni: potere, sesso, denaro.”
A me è sembrato
folgorante il personaggio Jasmina, “dal
fascino orientale, dagli occhi scuri tipo mille e una notte”. Queste le parole
con cui la ricorda l’onorevole Enrico Giannini, il politico su cui la
ventiquattrenne di Marrakesh, emigrata in Italia da quando aveva tre anni, ha
svolto la sua tesi di laurea in Scienze Politiche.
Una Jasmina “fiammeggiante”,
non solo perché è bella ma perché ha continuato gli studi all'Università (e suo
padre non ne era per niente convinto) e con la laurea si era piazzata in quel “trenta percento” di italiani con diploma universitario.
E’ fidanzata con Michele,
compagno di studi, e la sera della laurea con altri laureati si ritrovano tutti
al lago per festeggiare. Quando Jasmina vuol tornare a casa il fidanzato non
l’accompagna, tanto più che l’auto della ragazza è in un posteggio vicino. Lui
si ferma ancora con gli amici forse anche per consolare l'amico dall’infanzia
Alessio, che ha mancato il diploma. Non è riuscito a laurearsi e lo sente come
un fallimento.
Lei, Jasmina, si addentra
nel breve percorso attraverso il bosco per raggiungere il parcheggio, ma una
voce, nel buio, le chiede “Scusi signorina, avrebbe mica una sigaretta?”
Il racconto si fa
agghiacciante: la paura di Jasmina diventa terrore, pur se vuol ostentare
coraggio, la sua corsa disperata, l’altro che l’agguanta, lo stupro. Lei, salva
per miracolo, non camminerà più, rimane sfigurata e le danno una pensione
d’invalidità. Lei non ha voluto tener legato a sé il fidanzato, ma anni dopo
gli scrive una lettera. Lo fa quando capisce di non poterne più di una vita in
cui l’unica consolazione sono quei “vecchi quaderni di scuola in cui scriveva
poesie” e che mai ha buttato. Lo stupratore le ha portato via la vita e lei ha
cercato di risollevarsi senza riuscirci ritornando con il pensiero sempre al
prima, quando aveva il mondo davanti.
Nell’ultima lettera a
Michele, anni dopo il fatto, ricorda: “… quando uscivo di casa con mio padre
che spingeva la mia carrozzina ero sempre e comunque quella ‘puttanella’ di
studentessa…” Gli dice anche: “Per non parlare poi della pietà, la cosa più
difficile per me da accettare”. Ma la giovane marocchina non ce l’ha fatta più
quando nel 2011 è intervenuta la prescrizione per il suo stupro. E non ha visto
la giustizia realizzarsi, non ha mai saputo chi le aveva fatto quel male così
grande che è perfino considerato “crimine di guerra" (pensate alle
marocchinate… e ciò è stata storia, la nostra storia!).
Questa è stata la sventurata
ma splendida Jasmina!
Quel primo capitolo con la
sua fuga disperata mi ha fatto pensare che Paolo Antognetti, mio compagno di
liceo, sempre ricco d’aplomb, sempre intelligente e studioso, sia diventato un
bieco killer tanto è realistico il suo racconto, anzi un killer seriale perché
c’è nel libro un altro episodio di violenza su una giovane ragazza.
Invece è quell’arte di
narrare che si matura scrivendo, un dono ricevuto ma da far risplendere.
Il libro è affollato di
personaggi: Il padre di Jasmina, un islamico che non ha mai approvato la vita
da normale studentessa occidentale della figlia; il mancato laureato, Alessio
Vinci, poi presentatore Tv, noto ed amato tanto da voler fare il salto in
politica. Così esordisce come candidato alla guida della Regione Lombardia:
“Amici, sono profondamente convinto che se Panorama mi ha classificato negli
ultimi due anni di fila tra le top-cinque personalità preferite dai lettori del
Nord Italia, vuol dire che so parlare alla gente, che so capirla, e penso che a
sua volta la gente mi capisce molto bene, perché uso il loro linguaggio. A
tutti quelli che mi accusano di facile populismo, pongo questa semplice
domanda: Non è forse populismo la volontà di capire il popolo, i suoi desideri,
le sue paure?”
Parole che ho messo in
corsivo per far risaltare come questo noir sia un libro di attualità: ho
segnalato solo uno spunto, ma incontriamo “la macchina del fango”, le
"fake news", la “prescrizione", il “problema dei migranti",
l' “odio razziale", la "Ghb o droga dello stupro", il dramma
della tossicodipendenza. Tutti temi d’attualità come nel libro s’incontrano
cenni alle vicende della stimata Casa Editrice Hoepli o si nominano nostri vini
pregiati dal Brunello di Montalcino, annata 2009, al Prosecco…
Con sapiente arte del
narrare il racconto alterna capitoli, che riguardano il momento antico dello
stupro con inizio delle indagini, a capitoli di un tempo molto posteriore: uno
scandalo per pedofilia montato per stroncare la carriera politica di Alessio,
la ripresa delle indagini. E c’è un personaggio pulito: il commissario Mori che
indaga fin dall’inizio ma che deve smettere perché ordini superiori gli tolgono
l’indagine. Ha però la soddisfazione di vedere il caso risolto vent’anni dopo,
anche se non da lui. Illuminanti del suo carattere queste sue parole di quando
voleva proseguire l’inchiesta contro il parere dei suoi capi: “Ho un giuramento
da rispettare, la mia parola vale pur qualcosa, se anche la Polizia mi sembra
aver perso l’onore, non intendo svendere il mio”.
Quanto alla politica, a
fronte di tanti nostri scoramenti di elettori, appare significativo il duro
giudizio dello scrittore ed Ingegnere-Professore-Imprenditore (qualifiche che
gli danno titolo per parlare con ragione): “C’è un altro lavoro che premia
altrettanto l’imbecillità, che permette
a un cretinetto qualsiasi di diventare un capo basta che sappia
affascinare le persone?” Parole messe in bocca all’onorevole Giannini, quello
su cui Jasmina aveva scritto la sua tesi e con cui aveva anche avuto una breve
relazione, per cui un tempo era stato il maggior sospetto dell’indagine del
commissario Mori.
Tanti i personaggi abbietti
di questo noir ma vale una considerazione più generale: “L’incredibile banalità
del male può stravolgere e distruggere vite”.
Il lettore che
voglia meglio documentarsi può farlo sul sito www.antognetti.it
Ancora una
piccola notazione sulla copertina: questa immagine misteriosa piace così tanto
ad Antognetti che vorrebbe metterla come cover - quasi sigla personale - nel
ripubblicare i quattro romanzi che ha edito con Jaimar.
(Di Antognetti
ho già recensito L’Isola sacra (v. la pagina Gemme ritrovate di www.marialuisabressani.it)
CLAUDIO PAPINI
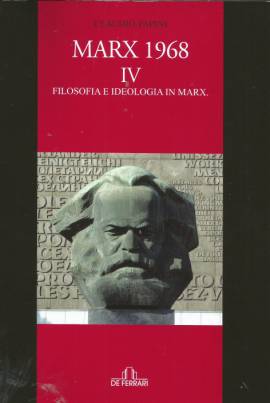
Questo quarto
libro del professor Claudio Papini dedicato a Marx inizia con una carrellata di filosofi contemporanei a Marx o che
lo precedettero e gli furono di ispirazione o di sua critica ed è tutto imperniato su ciò che distingue
ideologia da filosofia.
Cerco di
ricostruire il filo logico del discorso del professore e pur se un tempo si
criticava – giustamente – che le recensioni fossero più un assolo personale di
chi scriveva su un libro e si
pavoneggiava, spesso non riportando che in minima parte ciò che nel libro c’era
davvero, ora non vorrei incorrere nell’errore contrario: ciò che scrive e pensa
il prof. Papini è così esatto e a largo raggio nel tempo che vorrei citare solo
parole sue. In pratica il mio sunteggiare il suo testo Marx 1968 IV - Filosofia
e ideologia in Marx (De Ferrari,Genova,2019) rischierebbe di diventare un
esercizio di copiatura o "un fare pedissequamente le bucce" a ciò che
ha scritto, ma ci provo perché stimola la mia intelligenza ormai messa troppo a
riposo.
Parto da una
riflessione di Hegel dato che ad ogni capitolo del libro come nei precedenti
tre dedicati a Marx, Papini inserisce sempre qualche citazione illuminante per
ciò che sta per dirci
Da Hegel,
dunque: “Se la
riflessione… riguarda il presente come cosa vana,essa si ritrova nel vuoto e
poiché soltanto nel presente v’è la realtà, essa è soltanto vanità. La
filosofia al contrario garantisce il giudizio che nulla è reale se non l’idea”.
Un punto mi pare
fondamentale nelle tematiche marxiane messe in luce da Papini: “La cosiddetta
ricerca della verità è porsi sul piano intellettuale nella Libertà”.
(E noi siamo stati allevati
scolasticamente a concetti come questo: “Libertà ch'è si cara come sa chi per
lei vita rifiuta…”).
Ma l’esercizio intellettuale
della libertà ha sempre un presupposto: “Una situazione di Libertà politica cioè l’esistenza di una società almeno
policentrica”. Concetto questo che ci è arrivato attraverso "i
classici", quelli che ci fanno studiare da sempre nel nostro ordinamento
scolastico ma anche quelli di altri Paesi che inseguiamo per capire un po’ di
più di noi e dell’essere.
A questi primi concetti,
libertà e libertà politica, si affianca inevitabilmente quello di Dittatura perché è “essa che – pur nel disagio morale
che comporta – garantisce una specifica omogeneità. Nella dittatura il partito
e lo Stato sono connessi in un dominio
burocratico ed ideologico”, e queste
sono tutte osservazioni di Papini.
Però questo altro concetto
fondante che viene introdotto, lo Stato, viene diversamente interpretato: 1) un
marxista come Lenin vorrebbe eliminarlo in quanto espressione degli interessi
della borghesia; 2) Stalin invece lo considera la migliore celebrazione della
statualità socialista.
Se si passa alla Verifica - cioè a ciò che interessa la vita della gente - si
arriva al concetto di Mercato.
Il Mercato borghese è
espressione di libera concorrenza, il Mercato socialista è frutto di un alto
grado di pianificazione autoritaria.
Lo Stato - tornando ad Hegel - è un prodotto delle Società giunte ad un determinato grado di sviluppo.
La Chiesa si pone come contraltare allo Stato: è una
scelta istituzionale che “solo dopo un lungo processo
storico è venuta rarefacendo le attitudini specificamente politiche senza mai
abbandonarle del tutto”.
Tra Stato e Chiesa l'Universale Borghese in Italia è sempre stato una
realtà presente ma incompiuta e se facciamo riferimento al "nostro"
Pirandello (nostro per modo di dire dato che la sua fama e i suoi scritti hanno
travalicato i confini) per lui "i conservatori e i borghesi" sono i
veri personaggi in cerca d'autore.
Dopo questa apparente
divagazione che in realtà è stato un allargare la sua osservazione a tutto
campo, a 360°, Papini ritorna al compito della
Filosofia che è non tanto dire la Verità quanto tornare ad essere la Verità.
E qui l'Autore rivela tutto il suo “poetico" idealismo.
C’è anche un altro rapporto
da lui considerato, quello fra uomo e natura, infatti leggere un libro di
Papini è come essere trasportati in un viaggio di scoperta di noi e
dell’esistere.
Desidero però rilevare un
altro aspetto che rende molto interessante Claudio Papini: la sua “critica”.
Infatti critica Marx quando
“questi scalza il primato della coscienza per trasferirlo ad un fare
strumentale guidato preliminarmente da un modello ideale di ciò che si vuole
realizzare”. “L’uomo è l’animale che fabbrica utensili”, dice Marx, ma Papini osserva: “Siamo di fronte ad una riduzione
ingiustificata di quella che è la dimensione culturale in tutti i suoi
aspetti per l’uomo e del principio che la fonda, cioè la produzione di utensili
per il lavoro. L’organizzazione della produzione non è che una parte
dell’attività mentale e pratica; anzi viene a porsi come un momento
discriminante visto che anche le società animali organizzano la loro
autoconservazione e si servono di utensili seppur rozzi”.
In nota (n.115, p.100) cita
Mumford, categorico nel negare l’importanza primaria degli utensili, anzi
Papini afferma ancora: “Considerare l’uomo un animale che si serve di utensili
significa trascurare i capitoli più importanti della storia umana…l’uomo è soprattutto un animale produttore di pensiero”.
Si serve ancora di parole di
Mumford sul concetto del termine greco tέχνη “che non
distingue tra la produzione industriale
e le arti belle e simboliche; e per quasi tutta la storia dell’uomo questi due aspetti furono inseparabili,
rispettando l’uno le condizioni e le funzioni oggettive, rispondendo l’altro a
necessità soggettive” (v. Il mito della macchina di Mumford a p. 21).
Cita Marx nel suo rapporto
con Hegel quando dice (I capitolo del Capitale): “I modesti, presuntuosi e
mediocri epigoni che dominano la Germania trattano Hegel come un cane
morto”. E continua in questa sua
appassionata difesa di concetti in cui crede, tessendo rapporti tra la società
borghese, le sue contraddizioni, da cui consegue una filosofia della storia per arrivare al concetto di Lavoro, che come già precedentemente quello di Mercato, è
cosa che interessa gli uomini tutti, cioè ogni Società.
Di Marx accoglie queste
parole: “Il mio punto di vista che concepisce lo sviluppo della formazione
economica delle società come processo di storia naturale, può meno che mai
rendere il singolo responsabile di rapporti dei quali esso rimane socialmente
creatura, per quanto soggettivamente possa elevarsi”.
Tralasciando Marx, oggetto e
soggetto di questo studio di Papini, voglio anche ricordare per il suo
brillante spirito di critica queste sue parole a proposito di Mussolini, su cui
tuttora si dibatte e sempre – purtroppo! – per fazioni ideologiche.
“Vilfredo Pareto (nel suo ultimo articolo scritto su
Gerarchia-luglio 1923) aveva invitato Mussolini a non gettare l’Italia nella
spire del Vaticano, e questo avevano già detto con accenti diversi nel periodo
in cui erano avviate le trattative che portarono alla firma dei Patti
lateranensi (11 febbraio 1929) sia Croce che Gentile,
Giolitti, Julius Evola.
Come è noto il Duce dell’Italia fascista fece ben diversamente.
Difficile condividere la sua scelta, ma nello steso tempo difficile,
politicamente, dargli torto. E’ evidente che anch’egli, nonostante la
rivoluzione fascista, anch’egli avvertiva debolezze intrinseche nell’assetto
etico-politico del Paese e ricorreva al
supporto ecclesiastico, coinvolgendo la Chiesa (destinata a rivelarsi un
collante meno forte di quel che egli immaginava, viste le contraddizioni
intrinseche all’istituzione ecclesiastica).
Un bel libro, questo del
professor Papini, che purtroppo ho percorso a “colpi d’accetta”, ma su cui è
bene meditare.
Sembra di uscirne migliori
nel senso che aiuta a capire fatti della storia e persone controverse (e sempre
per opposte fazioni) come Marx o anche Mussolini.
(Mi piace ora inserire
questo saggio sull’Economia perché dopo Marx e la discussione su Stato, Mercato
ecc., a tanti anni di distanza, nel nostro tempo, queste considerazioni
rappresentano molto bene la modifica di tanti concetti.
Poi al Saggio farò seguire
un mio breve commento)
Giglio Reduzzi
RUDIMENTI DI
ECONOMIA
(Auto-pubblicato nel gennaio del
2020
nella speranza che qualcuno lo legga)
Se
mai i miei nipoti mi chiedessero di spiegare loro cos’è l’economia (cosa che si
guardano bene dal fare), mi sforzerei di usare un linguaggio semplice e
parlerei loro nei seguenti termini:
1. l’economia è l’arte di
ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.
2. Allo Stato compete
fare le cose che, richiedendo un grande impegno organizzativo e finanziario, il
singolo non può fare. Tipo strade, scuole, prigioni ed ospedali.
3. Perché lo Stato possa
fare quelle cose è necessario che i cittadini gli diano i mezzi per
realizzarle.
Ciascuno nei limiti delle
proprie possibilità. Questi “mezzi” si chiamano imposte e/o tasse.
4. Evadere le tasse è un
crimine. Salvo che un cittadino rinunci in partenza ad usufruire dei servizi
forniti dallo Stato.
Cosa che può fare solo
espatriando. Una volta per sempre. Non che faccia dentro e fuori secondo la
convenienza.
5. Perché al punto 3 si
dice che ciascun cittadino deve pagare le tasse “nei limiti delle proprie possibilità?
Semplice: perché la
ricchezza si trova distribuita tra i cittadini in modo diseguale.
Poveri
e ricchi sono sempre esistiti. Nessuno è mai riuscito ad abolire del tutto la
povertà.
6. Tentare di ridurre le
distanze tra ricchi e poveri costituisce l’assillo costante dei partiti
politici cosiddetti di sinistra (comunisti, socialisti, ecc.), mentre i partiti
di destra sono più interessati a creare ricchezza.
7. Questa può essere
creata solo da aziende che nascono dalla libera iniziativa dei singoli
cittadini o piccoli gruppi dei medesimi.
8. Lo Stato deve
limitarsi a creare le condizioni perché queste iniziative crescano e
prosperino.
Non può occuparsene
direttamente, perché i servizi in cui è impegnato, oltre ad essere di grandi
dimensioni, sono generalmente slegati dalle leggi dell’economia, in quanto
rivolti più al fine (per esempio assicurare la salute dei cittadini) che ai
mezzi utilizzati per raggiungerlo.
Dunque, in questo caso,
lo scopo deve essere conseguito a
qualunque costo, mentre, come abbiamo visto, l’economia prevede che il
fine venga raggiunto con il minimo sforzo.
9. Quali sono le
condizioni che lo Stato deve garantire al cittadino, italiano o straniero, che
desidera impiantare una fabbrica in Italia?
Le condizioni sono che
gli vengano garantiti:
a) Il libero accesso alle
infrastrutture esistenti, eventualmente migliorandole,
b) La libertà d’impresa (cioè la
libertà di scegliere a suo piacimento il miglior modo di combinare materie
prime e manodopera),
c) Una struttura statale non ostile
(meglio se amica). In particolare, un giusto e rapido processo
nell’eventualità che
l’imprenditore incappi in una lite
giudiziaria,
d) Un’equa tassazione dei profitti
nascenti dalla sua iniziativa.
Si tratta, come è facile
vedere, di condizioni minime che, se mancano, rendono l’impresa impossibile.
Specie se a mancare ce
n’è più di una.
Prendiamo, per esempio,
il requisito della libertà d’impresa.
Se ad un imprenditore
viene imposto di assumere 10 lavoratori, in luogo dei 5 che lui aveva stimato
essergli necessari (magari suggerendogli anche i nomi), è chiaro che lui
desisterà dal suo progetto produttivo.
E’ per questa ragione che
gli imprenditori stanno alla larga dalle aree a forte presenza mafiosa.
Se queste sono le regole,
allora possiamo passare ad analizzare la situazione italiana.
La situazione italiana
Come tutti sanno, stiamo
attraversando un momentaccio. E non solo in campo economico.
Ma, rimanendo in questo
settore, notiamo che è iniziato da tempo un processo di de-industrializzazione.
Nel senso che le aziende,
comprese le più note, o chiudono o delocalizzano. Cioè vanno altrove. Le ragioni?
Evidentemente sono venute
meno alcune delle condizioni che abbiamo ritenuto essenziali per uno sviluppo
positivo dell’economia.
Questo processo di
de-industrializzazione ci colpisce particolarmente per il fatto che esso si sta
verificando molto rapidamente ed è in contraddizione con il processo inverso
che avevamo sperimentato nell’immediato dopoguerra (anni ’40 e ’50).
Allora l’Italia era
ridotta ad un cumulo di macerie e tutti avvertirono la necessità di ricostruire
il Paese.
Si fecero un sacco di
infrastrutture e si crearono un gran numero di aziende.
Si parlò addirittura di
miracolo economico, anche se avrei qualche esitazione a definirlo tale, per il
fatto che:
a) A protezione delle aziende italiane, il governo
aveva creato una fitta rete di barriere doganali che rendeva economicamente
vantaggioso il made in Italy anche
se prodotto a costi maggiori. (Non a caso, quando fu tolto lo scudo dei dazi
doganali, molte aziende andarono a gambe all’aria);
b) Non esisteva alcuna sensibilità ambientale,
per cui si produceva senza riguardo all’inquinamento che si provocava
(cementifici, acciaierie, industrie
chimiche);
c) Nel lodevole intento di assicurare
un impiego (e quindi un reddito) a tutti, lo Stato non esitò a sconfinare in
terreni che non gli
erano propri (fino a produrre
panettoni) e, soprattutto, a gonfiare oltre misura i suoi organici.
Ora, come dicevo prima, è
iniziato un periodo di de-industrializzazione.
Alcune aziende chiudono
ed altre delocalizzano.
Le ragioni sono sotto gli
occhi di tutti: i dazi sono spariti ed è aumentata la sensibilità ecologica.
Cioè sono mutate le
condizioni “al contorno” in cui si era sviluppato il cosiddetto miracolo
economico.
Tra le aziende che hanno
chiuso ci sono aziende, come la Necchi e l’Olivetti, che costituivano il fiore
all’occhiello dell’industria italiana.
Tra quelle che hanno
delocalizzato c’è addirittura la Fiat che era considerata il simbolo
dell’industria meccanica italiana.
Ma l’elenco è lunghissimo
e comprende anche il tipo di aziende considerato il più indicativo della
creatività italiana, cioè l’alta moda.
Il fenomeno riguarda, a
maggior ragione, le imprese tuttora amministrate dallo Stato, o che sono state
privatizzate solo de iure,
avendo
continuato ad essere gestite con criteri anti-economici.
Perché, in questo caso,
oltre alle condizioni “al contorno”, vengono ritenute superate anche quelle
relative al tipo di gestione.
In questa categoria
ricadono le aziende di cui maggiormente si parla oggi: l’Alitalia e
l’ArcelorMittal (ex Ilva).
E’ del tutto evidente che
specialmente la prima ha sempre operato con criteri anti-economici e difatti
sono anni che lo Stato la tiene in vita artificialmente iniettando ogni anno i
fondi necessari ad impedirne il fallimento.
Purtroppo nel caso
dell’Alitalia si è particolarmente restii a lasciarla fallire per il fatto che
essa è vista più come un vessillo nazionale che un’azienda.
Inoltre, ad aggravare la
situazione, ci pensa anche il personale dipendente che, anziché aiutare
l’impresa per cui lavora, come avviene in America, contribuisce ad affossarla
con continui inutili scioperi.
Cioè con la peggior arma
possibile, perché mette in luce, contemporaneamente, l’indifferenza che gli
operatori provano sia per i gravi disagi che procurano agli incolpevoli
passeggeri che il danno economico che causano alla loro stessa società.
E’ evidente che, così
facendo, essi dimostrano di essere ancora succubi degli insegnamenti del
vecchio partito comunista, secondo cui il datore di lavoro è il nemico da
abbattere, altro che l’amico da aiutare!
La
gestione fallimentare dell’Alitalia si manifesta nel fatto che essa è
largamente sovradimensionata per numero di dipendenti.
Non è un caso che, ogni
volta che si presenta un potenziale compratore, egli imponga come prerequisito
una drastica riduzione del personale occupato.
Né serve che l’azienda
venga ceduta a quel compratore che, per ingenuità o generosità, prometta il
minor numero di licenziamenti, perché prima o poi la cattiva gestione verrà a
galla. Quod differtur non aufertur.
Per maggiori informazioni
sul caso Alitalia, consiglio la lettura del mio saggio:
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A9d09d1b9-014a-4399-8cf4-8b648b560315
Circa l’ArcelorMittal, la
partita è ancora in corso, ma temo che il sig. Mittal, acquistando questo
vecchio carrozzone statale, abbia fatto lo stesso errore che già fece il sig.
Riva e che ora ne sia amaramente pentito.
Infatti in questo momento
egli si trova a combattere contemporaneamente contro i sindacati, il governo e
la magistratura.
Che, per giunta, fanno
richieste diverse l’una dall’altra.
C’è persino chi gli
chiede di spegnere un forno e chi gli suggerisce di guardarsi bene dal farlo!
Alla
faccia della libertà d’impresa.
Commento di Maria Luisa Bressani
al PDF di Giglio
Reduzzi:
Rudimenti di
Economia.
Quando
scrivo di Giglio Reduzzi rimarco sempre la sua “chiarezza cartesiana” d’esporre
che facilita la comprensione del lettore anche per argomenti difficili per i
non addetti come l’Economia.
Parto
dalla contrapposizione poveri e ricchi che
osserva Reduzzi sono sempre esistiti ma per cui i partiti comunisti e
socialisti si affannano per ridurne la distanza, mentre i partiti di destra
sono più interessati a creare ricchezza.
Vengo
subito al concetto di Stato in quanto nel libro
precedente di Claudio Papini su Marx, il Professore per l’appunto discute
(nell’ottica del tempo di Marx) della sua funzione e secondo Reduzzi la
ricchezza può essere creata solo da Aziende (libera iniziativa di cittadini o
di gruppi) mentre allo Stato spetta creare condizioni di crescita.
Ma
cosa deve fare lo Stato a tal fine? Secondo Reduzzi deve assicurare: libero
accesso alle infrastrutture; Libertà d’Impresa; assicurare “giusto e rapido processo” se l’imprenditore
incappa in lite giudiziaria; equa tassazione dei profitti dell’Impresa.
Anzi,
se l’Impresa viene obbligata ad assumere una manodopera che non ritiene adatta
o ad assumerne il doppio di quanto le
occorre (metti 10 operai al posto dei 5 ritenuti necessari) si annusa “odor di
mafia". Ammonisce Reduzzi: “Alla larga da aree a
forte pressione mafiosa).
L’Autore si sofferma in particolare su Alitalia e ArcelorMittal (ex Ilva
di Taranto): sulla nostra compagnia di bandiera ha scritto un saggio di cui
fornisce il link (e l’ho riportato) per poterlo visionare. Sottolinea come da
anni lo Stato le inietta fondi necessari ad impedire il fallimento (è quindi
una privatizzazione solo “de iure”) ed inoltre il personale contribuisce ad affossarla con “continui ed
inutili scioperi", che fanno venire in mente gli “insegnamenti del vecchio
partito comunista per cui il datore di lavoro era il nemico da abbattere”.
Suo
lapidario commento in latino: "Quod differtur non
aufertur", che spiega perché l'Alitalia -problema differito- non torni a
crescere.
Quanto
all’ArcelorMittal compatisce il sig. Mittal che, acquistando questo vecchio
carrozzone statale, ha fatto l'errore di Riva con Alitalia, e si trova a
combattere con la Trimurti: “sindacati, governo, magistratura”!
Siamo
così alle comiche finali dato che Reduzzi con i
consueto senso of humour chiude il saggio riferendosi così al sig. Mittal:
"C'è chi della Trimurti gli chiede di spegnere un forno e chi gli
suggerisce di guardarsi bene dal farlo.
Capisco
che ho ripetuto frasi e concetti di Reduzzi, condensando stile Bignami, e mi
fermo per non superare in lunghezza chi come l’Autore ha scritto nove
paginette, chiare ed esaustive.
CLAUDIO PAPINI
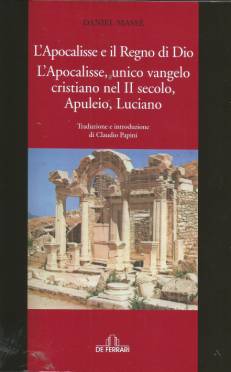
Per commentare
questo arduo libro di Claudio Papini, ma che interessa i tanti perché fa
riflettere sull’origine della nostra religione e quale è il nostro cammino di
uomini, parto dall’Epilogo, cioè dal suo finale e da queste parole del
Professore che sono come una meta da raggiungere. (E virgoletto all’inizio le
frasi del Professore, quelle che riporto integralmente pur se tolte dal
contesto, di qui la necessità di leggere il libro in modo autonomo e
riflettendo parola per parola).
“La libertà di
pensiero, questa nobiltà infinita dell’uomo è stata decretata come diritto
imperscrittibile della persona umana
dall’Ellenismo malgrado il ‘veto’ della Chiesa.
“L’ideale dell’Ellenismo è
il Saggio che si eleva alla contemplazione della Verità, aiutandosi con la
Scienza e con l’esercizio della ragione e fa beneficiare l’uomo delle sue utili
scoperte, mentre l’Ebreo non ha inventato nulla di utile alla vita e il
Cristianesimo nemmeno, [lo si legge ancora nella risposta ad Apione –
grammatico e sofista commentatore di Omero-, egiziano di età ellenistica noto
per la sua avversione agli Ebrei e al giudaismo, vissuto nella metà del I secolo].
“Il Cristianesimo è e resta,
molto ‘umanamente’, per la scienza e la ragione, che non saprebbero inchinarsi
dinnanzi all’articolo di fede, né di compromettersi con le esigenze delle
debolezze e delle superstizioni
secolari, un prodotto storico che mi piace studiare,
in quanto tale, senza favore, come senza
collera, per il solo amore della verità, - e per qualche fine più nobile
che dirò come giustificazione della mia
opera”.
Anche questa chiusa, “il
fine più nobile” , che l’autore non ci rivela subito pur se siamo alla fine
della sua opera, c’incuriosisce come ci trovassimo nella lettura di un giallo
in cui scoprire il meccanismo, cioè cosa ha motivato la narrazione dell’autore
(e sappiamo che la giallistica ha predominato nei gusti dei lettori di fine
Ottocento, nel Novecento e fino ad ora,
anno 2020).
Nell’Epilogo Papini cita
Camille Jullian, l’accademico che scrisse: “Se noi siamo cristiani, se occorre
a tenere a questo nome come ad una formula di salvezza, è perché esso
rappresenta tutto ciò che i sogni galilei hanno messo nella coscienza umana,
tutte le lezioni che le filosofie antiche ci hanno lasciato”.
Ma a proposito dei sogni
galilei Papini ci ricorda che la Giudea fu a fuoco e sangue per 150 anni sotto
Augusto, Tiberio, Nerone, Vespasiano, Domiziano, Adriano.
“Sogni galilei? Niente di
più falso - dice il Professore - vedete
la Storia”. Anzi individua due insiemi critico-storici:
1) “il corpo delle nozioni ebraiche del Messia,
le nozioni agnostiche dell’Eone Gesù (gli Eoni in molti sistemi gnostici
rappresentano le varie emanazioni del Dio e Cristo prese la forma della creatura umana Gesù per
insegnare all’umanità), la nozione che s’incorpora -da un tempo ad un altro-
nel Cristo, le nozioni dell’incarnazione,
la teoria del Cristo Redentore di San Paolo, la catechesi apostolica
passata nei riti sacramentali dai misteri pagani;
2) “il corpo delle grandi scuole filosofiche
della Grecia, di Roma, con i nomi di Pitagora, Palatone, gli Stoici,
Aristotele,Epicuro, Lucrezio, Cicerone, Seneca.
“Il cristianesimo
non è che una giustapposizione di questi due elementi: l’uno venuto dal
giudaismo e facile da identificare, l’altro greco-latino che si può designare
con il nome di Ellenismo.
“E’ l’Apocalisse
che porta a compimento la Thora, che realizza il dominio di Israele sul mondo
con la distruzione delle nazioni,
l’Ellenismo invece non è che un rivestimento superficiale, come un intonaco di
malta sulle mura, come una carta da parati sulle pareti dei vani. E malgrado
l’appoggio dei Barbari, dopo la caduta dell’Impero romano, mai la Chiesa nell’universale smarrimento e nell’anarchia
dei tempi, avrebbe potuto fare una propaganda religiosa se non avesse
impugnato, con le mani del suo dio Gesù inventato, avendo già rinnegato il suo
Cristo ebraico, il lucignolo acceso alla fiamma dell’Ellenismo".
Questo testo di Claudio
Papini sull'Apocalisse è del 2017, cioè arriva cinque anni dopo l'inizio della
Collana "Amici del libero pensiero" da lui diretta per De Ferrari
Editore e che inizia con un suo libro su Daniel Massé e gli enigmi del
Cristianesimo. Nella collana ne seguono altri cinque sempre dedicati a Massé.
Le mie sono piccole notizie ma per far capire come negli anni l’interesse del
Professore per il Cristianesimo e i suoi rapporti con l’antica Roma si sia
sempre più approfondito.
Questo testo riporta
nell’introduzione parole di Luois Rougier da Celse Contre les Chrétiens - reaction païenne sous l’empire romain
(1926). Per Rougier “tra le malattie
interne dell’impero romano al primo
posto è la nuova fede, il Cristianesimo”, perché entrò
in conflitto con una civiltà politeista che conciliava diversi culti.
Nell’Impero erano tutti considerati dal popolo come ugualmente veri, dal filosofo
come ugualmente falsi e dal magistrato come ugualmente utili. La tolleranza
romana manteneva la concordia.
Per la cronaca Rougier, nato
a Lione, dopo aver conseguito la laurea in filosofia insegnò anche a Roma
tre il 1920 e il ’24, e sono quasi commoventi
queste sue parole citate da Papini: “Dividevo il mio tempo tra l’insegnamento,
la visita di Roma e la biblioteca della École de Rome a Palazzo Farnese. Andare alla scoperta in una nuova biblioteca è uno dei
regali dell’esistenza”. All’École Rougier scoprì un testo di Aubè, La
Storia delle persecuzioni della Chiesa, la polemica alla fine del II secolo,
che includeva un saggio di ricostruzione e traduzione del Discorso di Celso.
Continua Rougier: “I cristiani con il rifiuto delle magistrature politiche e
del servizio militare, dovuto al timore dell’idolatria, facendo secessione,
fomentavano un immenso sciopero in tutto l’Impero nel momento in cui i Parti e
i Barbari premevano alle frontiere”.
Claudio Papini si pone la
domanda se ciò sia sufficiente a spiegare lo scontro Cristianesimo/Impero
romano e risponde che “no!”, considerando che gli Ebrei sono andati avanti a
combattere con i romani per 130 anni, a partire dalla legge del Censimento,
sotto Augusto imperatore fino all’ultima rivolta di Bar-Kocheba quando
l’imperatore Adriano “cancellò la loro terra dalle carte geografiche, facendo
passare l’aratro sopra le rovine di Gerusalemme, la loro città santa,
disperdendone ulteriormente la popolazione (commenta infatti il professore che il fenomeno della diaspora
è ben più antico) e vietando agli Ebrei di risiedervi”.
E ancora mettete a mente
questa considerazione riferita a quei tempi lontani: “Il paganesimo non era mai
ufficialmente morto, ma è evidente il sopravvenire progressivamente
preponderante del Cristianesimo al punto che nel 380 l’imperatore Teodosio con
l’editto di Tessalonica imponeva a tutti di seguire la religione data ai Romani
dal divino apostolo Pietro”. Però Celso nel suo Discorso di Verità aveva messo
in rilievo come la radice delle due dottrine, la
cristiana figlia dell’altra, l’ebraica fosse la Ribellione.
Prima di tornare attraverso
Papini al suo discorso iniziale che comprende Mosè, Giuda di Gamala che guidò
la rivolta contro la legge che istituiva il censimento e che fu detta cristiana
(v. p.12),e il Cristo, inserisco ora
una mia umile critica.
E’ logico -secondo me- non
poter trasporre fatti antichi nell’attualità moderna e quindi trasportare
dall'antico all’oggi una critica ad Israele come volesse dominare tuttora il
mondo e soggiogare le nazioni. Avanzo questa mia considerazione sue due basi:
1)
l’aver
frequentato attentamente da giornalista l’Apai, Associazione per l'amicizia
italo-israeliana fondata da Franco Bovio (vice-presidente Carige e uomo di
nobile sentire che molto fece culturalmente per Genova) ed aver toccato con
mano attraverso conferenze quante fake news dilagassero -una ventina di anni or
sono- da parte palestinese contro Israele pur facendo allora tanti, tanti
proseliti italiani;
2)
e – fatto
principale per me – l’aver avuto al ginnasio del D’Oria di Genova un’insegnante
ebrea Gina De Benedetti (il cui nome Regina - Gina ne era solo il diminutivo –
mi è sempre sembrato rivelatore della sua grandezza d’animo).
Scrive infatti Papini
(sempre nell’Epilogo): “Il Giudaismo, scontento del Cosmo e del mondo che pure
il suo dio Iahweh avrebbe creato per lui, non ha sognato che distruggerlo il mondo perché non ha tenuto in nessun
conto la vita umana, facendo appello senza gloria “al gran giorno della collera
di Iahweh: perisca il mondo affinché Israele regni su
tutta la terra giudaizzata!”, questo augurio giudaico-cristiano non è
che lo scenario drammatico dell’Apocalisse cristiana del Giovanni-Cristo (anche
per capire questo accostamento bisogna rifarsi alla parte iniziale del libro di
Papini e mi scuso se ho preferito
correre alle conclusioni).
“Le logomachie ideologiche
dell’anarchia rivoluzionaria non hanno fatto che trasporre sul piano
internazionale universale e politico dal punto di vista ebraico al piano
sociale moderno la rivendicazione di Israele. E verrà – secondo loro – un’era
nuova in cui, con un’esatta ed uguale ripartizione di beni – non diciamo nulla dell’ineguaglianza della passione al
lavoro e della valentia nel produrre (notate, per favore!, come Papini
con queste parole non si astenga dalla sua critica puntuale e tagliente)– le
iniquità spariranno e la giustizia con una G maiuscola regnerà. Perisca il
mondo piuttosto che l’ingiustizia sia! (Non vi sembra di sentire qualcosa a
questo riguardo del nostro reddito di cittadinanza?, pur inventato per
soccorrere tanti casi di vera povertà?)
“Storicamente
è a Roma che si deve l’organizzazione amministrativa e giuridica dell’umanità
civilizzata, la pratica della tolleranza e la dedizione attiva di tutti i
cittadini alla cosa pubblica, ma l’Ellenismo è ciò che è umano e nulla di umano
gli è estraneo.
L’Ellenismo ha
proclamato l’armonia del Cosmo e l’eccellenza della vita umana glorificata
dalla Saggezza e dall’eroismo. Ha fondato la civiltà razionale, basta sulla
scienza e sulla preminenza delle élites.
Ed ora, io, Maria Luisa
Bressani, ricordo parole della mia antica insegnante.
“Ho avuto al ginnasio del
D’Oria di Genova una professoressa ebrea Gina De Benedetti, direttrice della
scuola ebraica prima della guerra e che in tempo di guerra, pur giovane, si
ritrovò da sera a mattina i capelli tutti bianchi. Le volli tanto bene da
chiamarla perfino ‘mamma' nel senso ariostesco del termine quando disse di
Gregorio da Spoleto “mi fu più che padre… perché lo aveva aperto alla vita dello
spirito”.
A una mia domanda
a Gina sul perché gli Ebrei nel mondo fossero in ruoli dominanti per cultura e
se esistesse una sorta di supremazia intellettuale degli Ebrei, mi rispose che
ciò era dovuto al loro metodo d’insegnamento.
Ai loro bimbi a tre anni s’insegnava a leggere e questo
apprendimento avveniva sui testi sacri, libri utili alla vita e alla
comprensione di questa e del nostro compito in essa.
Ho poi ritrovato lo stesso
metodo ad opera di un americano Glenn Doman:
Insegnare a leggere a tre anni (metodo
che in realtà egli sviluppò per curare i bambini cerebrolesi). Ritengo che
l’apprendimento quanto più precoce è, tanto più utile sia, però bisogna anche
saperlo fare. Per insegnare non basta voler applicare un metodo, bisogna capire
come rapportarlo alla mentalità di chi dovrebbe imparare. Lo splendido motto di
Glenn Doman era: “I bambini possono vogliono e devono imparare a leggere”.
Torno al libro di Papini e
per chiarire meglio di cosa si tratta ne elenco i titoli dei capitoli. Cap. I-
Il regno di Mille anni e l'avvento del Cristo; Cap. II - L'Asino d'oro di
Apuleio; Cap. III - Luciano di Samosata e il Cristianesimo, Cap. IV -
Filopatride o l'uomo che s'istruisce. Infine l'Epilogo: Ellenismo, Giudaismo,
Cristianesimo.
Sono partita dall’Epilogo,
le conclusioni nel campo delle idee, ma poiché queste da sempre camminano sulle
gambe degli uomini, il discorso di Papini si fa più che mai interessante con
l’incarnazione delle idee stesse in persone note al nostro immaginario ma che
forse non abbiamo capito appieno.
Ecco dunque Mosè ma prima
bisogna annotare una frase di Freud sul popolo d’Israele da L’uomo Mosè e la
religione monotesistica (1934/38): “…di tutti i popoli che nell’antichità hanno
abitato intorno al bacino mediterraneo, il popolo ebraico è all’incirca l’unico
che esiste ancor oggi di nome e anche
in sostanza”. E l’uomo Mosè, non di origine ebraica bensì egizia, anzi un
seguace della svolta religiosa imposta all’Egitto da Amenofi IV (=Ekhanatòn)
che lottò contro il politeismo del suo popolo facendo coincidere il culto di
Atòn con quello del Sole, Mosè appunto (secondo
lo storico Papini) accrebbe la presunzione degli
Ebrei, assicurandoli che erano il popolo eletto da Dio. Mosè,
l’egiziano, è anche “padre” come il dio che predica, un dio unico di cui non
fare immagini.
A questo punto s’innesta il
discorso sull’indole dei popoli.
“I Greci ricercarono
l’armonia tra spirito e corpo, mentre gli Ebrei scelsero decisamente lo
spirito.
Ma secondo una parte
marginale della tradizione ebraica Mosè finì ucciso; concezione che per altro
si ritrova in Freud in Totem e tabù:
l’uccisione del padre, signore assoluto di uno dei gruppi umani in cui
s’articolò l’orda originaria; la sua uccisione da parte dei figli coalizzati e
il divoramento del suo corpo da parte di tutti i membri della tribù.
“Un evento così traumatico
che portò al concetto di “peccato originale”.
“Non a caso, Paolo, un ebreo
romano di Tarso, ricuperò questo senso di colpa, lo ricondusse alle
prime fonti storiche, coniando la definizione “peccato
originale” perché questo delitto meritevole di morte (s’introduce legato al peccato anche il concetto di morte)
era stato l’uccisione del padre primigenio, successivamente deificato.
“Non solo che il redentore,
Cristo, si fosse sacrificato senza colpa, era una deformazione tendenziosa: “Come può, chi è innocente dell’assassinio, prendere su di
sé la colpa degli assassini, consentendo di essere ucciso?”
Ma questa è proprio
l’origine dell’eroe che sempre si ribella al padre e in qualche forma lo
uccide, il vero fondamento della “colpa tragica” (del
dramma s’intende): l’eroe e il coro della tragedia greca raffigurano questo
stesso "eroe ribelle e la banda dei fratelli" e non è senza
significato che nel Medioevo il teatro torni a rivivere con la rappresentazione
della Passione del Cristo.
“Ne consegue pure che il
Giudaismo era stata una religione del Padre, il Cristianesimo diventò una
religione del Figlio; non solo per alcuni aspetti la nuova religione significò
un regresso di civiltà rispetto alla più antica, l’ebraica, e la religione
cristiana non mantenne l’altezza spirituale cui si era innalzato il giudaismo,
e ripristinò perfino la grande divinità materna (Maria), trovando spazio per
collocare molte figure divine del politeismo. Anzi, il
trionfo del Cristianesimo fu una nuova
vittoria dei sacerdoti di Ammone sul sul dio di Ekhanatòn dopo 1500 anni.
“Eppure -e qui arriva il commento di Papini-il cristianesimo fu un progresso e
da allora in poi la religione ebraica fu in certo modo un fossile”.
Concludo con le parole di
Papini sul perché di questo suo libro:
“Per farsi accettare e
sostenere la Chiesa si dà oggi arie da grande potenza, non avendo potuto
realizzare il suo sogno ‘escatologico’, quello del Cristo dell’Apocalisse,
prendendo a prestito dalla morale delle belle civiltà antiche le sue migliori
nozioni, le sue dottrine più spiritualistiche e vuole anche apparire come
grande consolatrice. Rischia il tutto per tutto con la complicità dei Governi e delle classi dirigenti che fanno
della religione uno strumento di dominio.
“Ma è dal basso,
dal popolo che avanza e progredisce la liberazione, l’affrancamento da questa
vecchia e fanatica eredità semitica.
“Possa questa liberazione effettuarsi senza una rivoluzione, per
mezzo della sola forza della ragione… mettendoci il tempo che occorre”.(Anche
questo un ideale -o un'utopia- però tanto, tanto suggestivo …e se mai
diventasse realtà!).
Paolo
Rumiz
Il FILO INFINITO
Viaggio tra i Monasteri alle Radici d'Europa
Questo di Paolo
Rumiz, scrittore e giornalista triestino, è senz’altro uno dei più bei libri da
me letti e recensiti.
L’autore è inviato speciale del quotidiano
«Il Piccolo», editorialista de «La Repubblica» e dall’87 scrive sulle
rivoluzioni in Europa orientale, sulle guerre nei Balcani con servizi da
Sarajevo, Mostar, Knin, Vukovar.
Avevo già letto altri libri di Rumiz (anche il suo libro Gerusalemme perduta
scritto con la fotografa polacca Monika Boulaj, autrice di Gente di Dio – alla
ricerca dell’altra Europa che conservo con amore e per cui metterò dopo questa
recensione una mia antica intervista).
Ebbi modo di
vedere al Ducale di Genova un’affollatissima mostra di Monika. Ricordo che era
sempre presente alle riunioni del Consiglio di Circoscrizione di
Nervi-Quinto-Sant’Ilario l’avvocato Lanzillo che aveva sposato una polacca e si
deve a lui il suggerimento di popolare il torrente Nervi con anatre e oche come
aveva visto nel Paese di sua moglie. Ora infatti il “nostro” torrente (io vivo
a Nervi e allora seguivo come cronista le riunioni del Consiglio) è più che mai
vivo ed animato.
Di Rumiz in passato ho letto altri libri e
recensito Vento di Terra – Istria e Fiume - appunti di viaggio tra i Balcani e
il Mediterraneo.
Ma l’emozione
che ho provato leggendo questo suo, che si apre con la statua di San Benedetto,
rimasta ritta ed intatta, nonostante la devastazione della Chiesa, nel
terremoto di Norcia, è stata unica. Da quell’immagine l'idea per Rumiz di
scrivere un libro che fosse un viaggio tra i monasteri benedettini d’Europa,
partendo da questa considerazione: “I monaci di Benedetto piantarono presidi di
preghiera e di lavoro negli spazi più incolti d’Europa per poi tessere tra loro
una salda rete di fili".
“L’Europa è bella - afferma - specie se la
si guarda dall'alto, da un aereo” ed osserva che è l’Europa dove finisce il
giallo dei deserti ed inizia il verde dei coltivi. Però ne ha anche un pensiero
tormentoso, di una sua crisi attuale che passa attraverso la caduta del Muro,
le bombe sull’Iraq, le Torri Gemelle, l’incendio balcanico, la Siria in fiamme,
la grande fuga degli esiliati. Conclude nell’ultima pagina del libro con
l’esortazione ad avere “coraggio e cuore" come i monaci che la rifondarono
sotto l’urto delle invasioni barbariche, come i padri fondatori dell’Unione che
dopo due guerre mondiali ridiedero dignità e ricchezza a un continente in
ginocchio. Essi sapevano che "l’Europa non è un dono gratuito, ma una
conquista e spesso un sogno che nasce dalla disperazione per la sua mancanza.
Europa la figlia di un re fenicio che per prima passò il Mediterraneo con paura
e diede il suo nome al nostro pezzo di mondo”. Amo la mitologia e questa racconta
che Europa, fanciulla di Tiro, fece innamorare di sé Zeus. Il padre degli dei
per conquistarla si trasformò in un toro bianco sulla cui groppa lei salì, ma
è stata anche fiera opponendosi a lui e
poi da lui costretta a cedergli, fu ricompensata: in terra diventando con il
matrimonio regina di Creta, in cielo con la costellazione del toro che ricorda
il suo rapimento. Anche la sua fierezza
da non dimenticare è all'origine mitica della nostra terra.
E perché amo tanto questo
libro? Luce, vento, voli di rondine e Storia, la mia prima impressione nel
leggerlo.
Storia gettata a piccoli
semi dalla mano di chi sa far nascere germogli e che mi riporta alla mente quest’immagine di Van Gogh del seminatore.

(Vedete come è sicuro il seminatore? E poi cosa sarebbe Van Gogh senza i
suoi colori?
Per questo l’ho preferito ad un altro quadro dell’artista ma in bianco e
nero)
Rumiz fa crescere i suoi semi-piante nel “dialogo” e la “rotta”, per
chi vuol capire, si configura fin dalle prime pagine.
Per arrivare a Norcia, nell’aprile del 2017, Rumiz scende da una
distesa incantata, invisibile dal basso, chiamata Pian Grande. “Il paesaggio
intorno è già percorso di vita, a maggio conoscerà la più celebrata fioritura
d’Europa: il giallo, il viola, il rosso e l’azzurro delle lenticchie, dei
papaveri e degli iris” . Commenta: “era il centro della linea di faglia che
aveva scosso l’Appennino e al tempo stesso il centro perfetto della Penisola che stava in mezzo al
Mediterraneo”.
Al centro della piana la statua di San Benedetto, Patrono d’Europa.
Rumiz ne ricava un messaggio: l’Europa è ripiombata nel Medioevo e, per
ritrovare le radici spirituali, deve passare di nuovo tra le macerie come nelle
due guerre in cent’anni ed ora in quelle del terremoto, questa terza
catastrofe. “Ora et labora”, è la Regola del Santo e la riforma cistercense era
stata il primo parlamento del Continente, insegnando: “disciplina ma anche
dolcezza nei rapporti umani”. Benedetto aveva salvato l’Europa quando Unni,
Vandali, Visigoti, Longobardi, Slavi e i ferocissimi Ungari avevano costituito
migrazioni – una cosa seria e non solo un arrivo tra noi di diseredati. “Per
tre volte – puntualizza Rumiz - l’Europa era rinata da quella montagne
d’Appennino: con Roma, con il monachesimo e con il Rinascimento…Non a caso
Ratzinger, dopo la morte di Wojtyla corse alla grotta del Santo a Subiaco e
scelse come Papa il nome di Benedetto e, infine, rinunciando al pontificato, si
ritirò in un monastero. Non a caso Carlo Magno affidò l’Impero ai monaci
benedettini, non solo per la loro fitta rete di monasteri, ma anche per
l’efficacia della Regola. Questi “atleti della fede”, i benedettini, avevano vinto e convinto i barbari, non con
le armi, solo con la forza della Fede e con l’Esempio del loro tenace lavoro.
La loro storia inizia dalla lotta
contro la selva, che dopo il crollo dell’Impero, invade l’Europa ed il monastero
irrompe nel paesaggio “come un’astronave che ha preso terra negli spazi al
limite del mondo”.
Un’immagine che non può non affascinarci, come tante altre disseminate
nel libro, o come questo giudizio folgorante sui nostri Papi, (Rumiz lo mette
in bocca a padre Guillaume del monastero della Pierre-qui Vire): “Giovanni Paolo II, un Papa che si guarda
(indimenticabile il suo volto appoggiato al pastorale), Bendetto XVI, un Papa
che si ascolta; Francesco I, un Papa che si tocca”. Dopo l’episodio della cinese
che lo strattonava un po’ chiedendogli comprensione ad un suo problema, vien da
dire: “e che picchia chi lo vuol toccare!”
(il “mio” indimenticabile
Papa quando si è affacciò e disse: “non abbiate
paura!”)
Dalla
selva - posto dove il diavolo è più visibile (forse perché la selva fa paura)-
emerse il Santo barbuto per fondare Montecassino. Ma tutto – è sempre il filo
del discorso dell’Autore – iniziò due secoli prima, nel deserto. “La vita
monastica nasce dal principio del deserto, dalla ricerca del vuoto, dalle
tentazioni di Sant’Antonio Abate".Non solo, le macerie del terremoto si
saldano nella memoria a quelle della guerra. A Norcia l’Autore è colpito dal
Monumento ai caduti della II Guerra con inciso anche il nome di Sergio Forti,
un triestino, ucciso in questi luoghi dopo indicibili tortureNon solo, il
bisogno di Fede e di Cultura nasce dalla cultura del libro e quindi
dell’apprendimento che si realizza attraverso di esso, anzi nei secoli passati
si è sempre realizzato attraverso esso. (Oggi esistono altri mezzi ma meno idonei alla riflessione
e bisognerebbe ricordare che per fare un libro, un tempo occorreva la pelle di
cento pecore).
Non solo, nel riportarci
alla memoria la guerra, le tante morti, le tante distruzioni, l’Autore ci
rammenta: “Come tanti ebrei all’inizio del nazismo, ci illudevamo di essere
immuni dalla resa dei conti. Ci rassicurava vedere altri dibattersi nel
naufragio. In breve si pensava ‘a noi non tocca’, perché noi siamo diversi. E
invece…”
Seguono altre riflessioni
come sulla centralità dell’Italia nel destino del continente e di quanto ne sia stata consapevole o no, per
saltare all’oggi, ad un’Italia taglieggiata dalle camorre. Valeva la pena di
fare la guerra per arrivare a questo stato di decadenza attuale?
Lo scrittore si risolleva
dal buio di questi pensieri riconsiderando ciò che fece Benedetto nei secoli
cosiddetti “bui”. Mise al centro "l’uomo in comunità". L’Europa Unita
divenne la più alta espressione sinfonica di una comunità di nazioni che il
secondo millennio ha saputo produrre. La musica è più che mai presente nel
racconto di Rumiz e sembra di sentirla attraverso le sue parole: “I luoghi si
capiscono di giorno, ma si sentono di notte. E’ l’acustica a svelarli. Che sia
tuono o sussurro è acustico l'atto della creazione: Spirito è soffio, voce,
verbo".
Vorrei soffermarmi un attimo
a considerare le pochissime note autobiografiche che l’autore ci dà. Suo nonno
emigrò e ci ricorda che tra Otto e Novecento siamo partiti in ventiduemilioni per cercar fortuna all'estero.
Ventidue milioni di italiani in mezzo secolo significa una nave con mille
persone al giorno per cinquant’anni di fila. Ora egli si sente uomo di
frontiera, orgogliosamente senza radici. Le notizie del sé: “Ho figli europei
che vivono lontano da me. Cittadini del mondo, ma con radici forti, di
frontiera. Fanno mestieri utili al Pianeta: uno cerca di salvare il clima,
l’altro i cibi autentici minacciati dal Globale. Mi hanno dato dei nipotini.
Uno, dolce birbone altruista, legge gli atlanti e l’ho beccato a studiare il
sistema solare.
(NB – nota bene-: in questo
nipote l’Autore ha travasato un po’ del suo Dna, di quando nel libro ha scritto
di aver sempre avuto la passione di leggere le carte geografiche. E scusate il ricordo
mio, di una nonna campagnola, che da anziana continuava a consultare l’atlante
sognando viaggi che non avrebbe mai fatto)
“L’altro nipote, più piccolo, ha gli occhi sempre stupiti e la musica
dentro”. …E ancora: “Non vivono incollati a uno schermo (o ad un cellulare).
Hanno familiarità con mucche e cavalli e non hanno paura di rotolarsi per
terra. Ecco è tutto. Ed è già tanto di cui ringraziare il buon Dio”. Le parole con cui Rumiz ci ha parlato
di sé, raggiungono lo scopo di ogni scrittore: “capire, far capire e anche
farsi capire”.
Da un libro si desidera sempre imparare e Rumiz semina a piene mani.
Ci ricorda che Dom Pérignon prima di essere uno champagne era un
vignaiolo benedettino. Ci racconta che “il cristianesimo conquistò il mondo con
il vino e naturalmente anche con la birra. La quale non è cosa del Nord. La
ricetta sbarca in Europa attraverso la Calabria grazie ai monaci copti
d’Egitto, risale la Penisola dall’Abbazia di San Francesco da Paola che ne
aveva codificato la ricetta, segue la dorsale appenninica, inonda la Padania
lasciando tracce di schiuma sui baffoni dei Longobardi per valicare le Alpi e dissetare le masse
carolingie a est e ad ovest del Reno, diventando Oktoberfest tra i tedeschi,
dando vita in Germania al marchio Franziskaner e Paulaner, per dilagare verso
il Belgio, dove raggiungerà il top nel mondo cistercense e in quello trappista,
nati per gemmazione dalla pianta benedettina. Cammino leggendario di enzimi e
di fede, dal Nilo ai mari del Nord".
La
storia del vino mi riporta a queste parole di Mordechai che Rumiz definisce
"il mio rabbino dell'anima": "La letizia è un dovere, prima che
un diritto. L'uomo ha l'obbligo di essere felice, perché solo così fa felici
gli altri. E' uno dei massimi insegnamenti dell'ebraismo. Nei campi di
sterminio i Chassidim entravano
cantando con i loro rebbe (=maestri) nelle camere a gas. Se gli antisemiti lo
sapessero, si guarderebbero dal perseguitare gli ebrei, perché la persecuzione
li rafforza all'infinito, facendo valere infinitamente questo culto della
gioia”.
Per
tornare al vino Mordechai diceva che guardare un tramonto sul mare bevendo un
bicchiere di buon vino, è santissima
preghiera, così santa che Dio stesso t’invidia.
Il
libro è di alta spiritualità ma senza peso come si vede da quanto prima
accennato ed ha il pregio di portarci in un viaggio attraverso i monasteri
benedettini d'Europa. Uno, tutto femminile, si trova proprio da noi a
Viboldone. E arriva anche una fulminea
e correlata riflessione dello scrittore:"La veste dei preti altro non è
che un trucco per usurpare il ruolo del femminile nella comunità della
fede".
Tra
le benedettine di Viboldone scopre la
pazienza del gomitolo : “Che cos'è la vita se non un lungo filo di lana che
scavalca muri, fiumi, montagne e frontiere?" Fili che hanno dato origine
alla rete di Abbazie.
Tra i tanti Abati che incontra alcuni sono
sorprendenti come Notker che suona con i Deep Purple o Stefano di Harding, uno
dei tre fondatori di Citeaux, inglese coltissimo. Grazie al suo studio dei classici
e ai 25 anni che impiegò nella conoscenza del mondo del suo tempo dopo Citeaux
nacquero Pontigny, La Ferté, Morimond e Chiaravalle.
Dei
monaci incontrati a me è rimasto impresso soprattutto Frédéric, classe 1933,
una laurea in ingegneria geofisica, la guerra in Algeria alle spalle e un
formidabile istinto per la musica e la
battuta di spirito. Dopo l'Algeria - ventisette mesi e ventisette giorni-
decise di diventare prigioniero di Cristo. "Non c'era poi grande
differenza tra caserma e monastero. Discipline simili", dice e quando
Rumiz gli chiede del suo rapporto con Dio, la risposta è: “Se Cristo non è
resuscitato sul serio, vuol dire che faccio il pagliaccio da cinquant’anni”.
Nel
capitolo dove Frédéric suona (e “quando improvvisa all'organo è il cielo che
scende sulla Terra”), l'Autore ci ricorda che la democrazia
è
nata in Europa ma tanti l'hanno dimenticato. Democrazia vuol dire che non puoi
fare quello che vuoi solo perché sei più grosso o più ricco e che la polizia
non può picchiarti. E tutti possono studiare ed essere curati".
Utopia?
o già fine della democrazia per come siamo oggi?
Però
nel libro non ci sono solo gli abati, i benedettini-personaggi e quando Rumiz
accenna al suo amato Osip Mandel'stam, ecco la mia corsa a documentarmi e ad
imparare. Ve ne do un assaggio: è stato un poeta e saggista russo nato a
Varsavia (all'epoca in cui era parte dell'Impero russo), da famiglia ebraica
protestante e morì in gulag a Vladivostok.
La
moglie Nadezda, colta pittrice, fu come lui vittima delle grandi purghe
staliniane e dieci anni dopo la morte del marito riuscì a far pubblicare i
versi di lui, imparati a memoria per poterli tramandare. Concludo con due foto
di questa mia frettolosa ricerca: Osip giovane e Osip nel gulag e con la sua
poesia a Stalin.
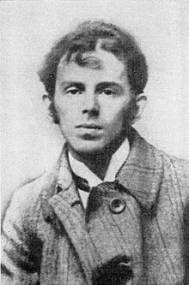
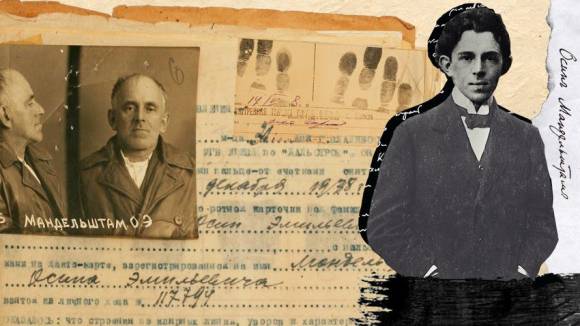
A
Stalin:
“Viviamo senza fiutare il paese sotto di noi
i
nostri discorsi non si sentono a dieci passi
e dove c’è spazio per un mezzo
discorso
là ricordano il montanaro caucasico.
Le sue dita tozze sono grasse come vermi
E le parole, del peso di un pud (=pisello),
sono veritiere,
ridono i baffetti da scarafaggio
e brillano i suoi gambali”.
Monika Bulay
Mostra al Ducale di Genova
(Intervista di
M.L.Bressani)
Le affascinanti 130 foto a colori di Monika Bulaj,
un viaggio per immagini nell’altra Europa, nei microcosmi dimenticati tra Mar
Baltico, Mar Caspio, Mar Nero resteranno alla Loggia degli Abati di Palazzo
Ducale fino al primo aprile. Un’occasione per conoscere periferie incantate
segnate dalla Storia. Non solo periferie d’Europa, anche periferie delle fedi,
periferie speciali dove i monoteismi, oggi in conflitto, generano – a sorpresa
– terreni di coabitazione.
Com’è nata l’idea di questo straordinario reportage/ricerca sulle religioni monoteiste?
"E’ stato un work in progress lungo dieci anni", spiega Monika.
"Il progetto è nato per riempire il vuoto che mi ispirava
la religione mentre crescevo in Polonia, per riempire il silenzio". Il Dio
del silenzio è quello del dopo Auschwitz, ma lei ha rifiutato quel silenzio per
riempirlo di voci, volti, storie: “Tutti possono raccontare cose interessanti,
bisogna ascoltare cogliendo il meglio di ciascuno. E come la Comunità Ebraica
ha collegato i luoghi immaginari dei sopravvissuti della Shoà, così ho fatto io
in Ucraina, Azerbaigian o altrove anche ripercorrendo luoghi con nomi legati ai
Santi”.
Monika si è laureata in antropologia all’Università
di Varsavia, vive a Bergamo con la famiglia e con i tre figli, cittadini
italiani come ama precisare. Collabora a diversi giornali italiani, al National
Geographic, in Polonia alla Gazeta Wyborcza e nel 2005 ha ricevuto il Grant in
Visual Arts da parte dell’European Association for Jewish Culture”.
Tappe sempre diverse e arricchite del suo progetto
sono state una prima Mostra al Teatro Sociale di Bergamo, un’altra nel novembre
scorso nell’ambito di Religioni per la
Pace, incontro tra fedi diverse organizzato a Trento. La Mostra genovese,
voluta dal Centro Culturale Europeo promosso dalla Fondazione Carige nel 2004,
sta per diventare un libro con l’editore Frassinelli, con cui ha già pubblicato
Gerusalemme perduta (in collaborazione con il triestino Paolo Rumiz) e Figli di
Noè, poi prodotto come documentario da Lab80 Film.
Monika rievoca alcuni eventi storici che
hanno segnato la Polonia. “Il 1569 quando Sigismondo Augusto riunì in un unico
grande stato Polonia e Lituania. (Per inciso, nonostante l’elettività della
corona, era riuscita a farlo salire al trono polacco l’energica madre italiana
Bona Sforza).
“Il 1918, Trattato di Brest Litovsk con cui
la Russia riconobbe i diritti della Polonia e dovette cedere, oltre alla
Polonia orientale, le province baltiche, l’Ucraina, la Finlandia, la
Transcaucasica.
“La Polonia era uno stato immenso,
plurietnico – sottolinea - e fino al ’39 vi ha vissuto strettamente con i polacchi
la più grande comunità ebraica”.
All’occupazione della Polonia da parte di
tedeschi e russi nel settembre 1939 Pio XII, profetico, disse: “Ma le Nazioni
non muoiono”.
Monika ricorda le sofferenze della guerra,
i pogrom e gli straordinari atti di coraggio. Non scende nei particolari, ma a
me piace ricordare la storia dello Schindler polacco dei bambini, Janus Korczack che aveva aperto la “casa
degli orfani” di Varsavia, fiore
all’occhiello in Europa fino al ’42. Quando quei bimbi del ghetto furono inviati
al campo di concentramento di Treblinka, i nazisti per la sua fama gli
offrirono la salvezza, però Korczack preferì morire con i suoi orfani nel
lager.(v. L’impossibilità della storia. Tributo a Janus Korczack di Dario Arkel
e Anna Rella).
Ricorda ancora l’occasione
perduta del dialogo tra le Chiese, il gravitare di parte dei credenti verso la
Chiesa ortodossa poiché dal punto di vista sociale la Russia era identificata
con l’ortodossia, quindi la rinascita delle cupidigie russe sulla Polonia che a
fine guerra si trovò con confini mutati, con spostamenti giganteschi di etnie e
con un governo unitario che operava sotto la guida dei comunisti. Così Monika
si è mossa, proprio in senso materiale, percorrendo chilometri a piedi alla
ricerca di testimonianze delle piccole comunità aggrappate alla loro antica
tradizione religiosa.
Ha scritto degli Udi della
terra di Nic, in Azerbaigian, cristiani
dell’antichissima lingua degli Albani che sarebbero i capostipiti dei Vichinghi
e che furono convertiti da Eliseo: “Sempre perseguitati per la loro fede dai
persiani, dai bizantini, dagli armeni, infine dai sovietici che tolsero loro le
croci dai muri, gli Udi finirono per adorare la Luna e gli alberi. Finito
l’ateismo di Stato, con la riscoperta della fede mandano delegazioni in Polonia
per imparare a costruire le chiese e hanno regalato una croce a Giovanni Paolo
II, ma sono indecisi dove spedire i giovani per farli diventare preti: nella
chiesa georgiana, ortodossa, cattolica o luterana?” Le Religioni monoteiste, pur
stravolte dal sincretismo o da coabitazioni che le portano a sfiorare la
superstizione, sono più forti delle ideologie e sono anticorpi allo scontro fra i fondamentalismi.
Dice ancora: “Mi
piace fotografare all’alba o al tramonto”.
I suoi colori sono caldi,
sembrano impastati di terra, fin gli spazi aperti hanno il calore di interni di
una casa misteriosa perché come animati da presenze vive. La pastosità delle
sue luci sospese nel tempo e la sua fotografia visionaria fanno
venire in mente la Mostra che abbiamo visto al Ducale nel 2000 Il silenzio dei
Maya di Luis Gonzalez Palma, guatemalteco che lavorava ritratti allegorici con
cera e bitume liquido. Giovani artisti che con sensibilità diverse sanno
guardare così lontano da restituirci le culle perdute dell’uomo.
Guido Barbazza
Il Genovese Volante
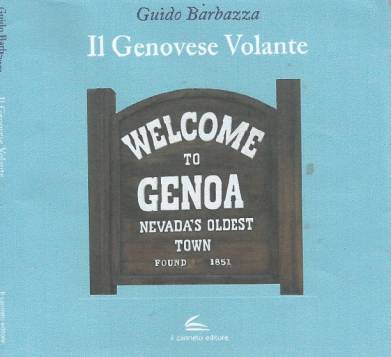
PREMESSA
Un libro deve
parlare da sé prima di cercare – forse, e per chi voglia – le vicende del suo
autore. Ragion per cui inizio da questo sorprendente libro «Il Genovese
Volante» di Guido Barbazza. Nasce da una rubrica, richiestagli da Alessandro
Cassinis che firma la bella prefazione, per
«il Secolo xix» a testimoniare
“tracce" di Genova nel mondo. Nessuno meglio di Barbazza avrebbe potuto
ritrovarle dato che ha avuto il Guinness World Records per il maggior numero di
viaggi aerei e i suoi 2200 viaggi sono
certificati dalle carte d’imbarco, un tempo
- colorate ed originali - ora
"ingrigite" nell'uniformità.
Bisogna ricordare una peculiarità di Genova, detta
«La Superba», che conquistò il suo
appellativo perché fu una Repubblica indipendente, prospera, fiera delle sue
risorse: commercio, pesca, sale, viti.
Lo mantenne in lunga storia di secoli: dal 1099 quando
si sganciò dal Sacro Romano Impero diventando libero comune a partecipando alla
I Crociata, fino al 1797 quando defunse con Giacomo Maria Brignole durante la
campagna d’Italia di Napoleone. Poi ricostituita, fu nel 1815 annessa al Regno
di Sardegna.
RECENSIONE
La fortunata
rubrica di Barbazza prende il nome dall’opera di Wagner, «L'Olandese Volante»,
e Il Canneto Editore ci porta nella più prestigiosa raccolta di bei nomi di
scrittori genovesi e non solo.
Il primo articolo
del libro riguarda un portacenere che l’Autore individua a Mumbai sul banchetto
di un venditore ambulante. E’ un portacenere della “Linea C.” della Costa
Armatori di Genova. Incise nel logo amatoriale le parole “Europa, Sud-Centro America”.
L’ambulante gli spiega che l’oggetto proveniva da Alang Bay e l’Autore
commenta: “Bingo! Doveva provenire dall’Eugenio Costa, turbonave della Costa
Armatori e spiega che quel luogo in India è il cimitero delle navi con la più
grande industria di demolizioni navali al mondo.
Ricorda per tutti
noi “quella nave dalla linea così snella ed elegante, le alte ed aggraziate
ciminiere gemelle gialle con la “C” blu” che in modo professionale ed
efficiente ha portato nel mondo l’immagine dell’Italia, “dell’industria che
l’aveva creata, degli artisti che l’avevano abbellita e dell’operosità dei suoi
equipaggi”.
L’Autore si è
presentato a noi con occhio acuto che sa riconoscere un oggetto particolare e
come uomo sensibile: nelle tre parole, industria, artisti ed equipaggio, ha
messo insieme tutto ciò che costituisce l’anima di una nave e anche di una
nazione. Inserisco perciò l’immagine del “prezioso” (per noi, per la nostra
italianità) portacenere (e ogni capitolo è corredato da una foto significativa
e poiché l’immagine è l’occhio della pagina, questo è un altro suo indubbio
pregio):

Il secondo
articolo-racconto riguarda un’immagine che Barbazza vede nella toilette di TGV
(Train a Grande Vitesse) che lo portava da Lille a Parigi e commenta “the devil
is in the détails” : è Boccadasse, lo splendido borgo in fondo a Corso Italia,
la più rinomata passeggiata genvese. A Boccadasse si gusta un gelato molto
rinomato.
Da esperto
manager, riguardo la foto, commenta: “Ma a proposito i diritti d’immagine sono
riscossi dal Comune di Genova ?”.
[Tasto per me
dolentissimo perché avendo pubblicato nel novembre 2018 con Albatros (casa
editrice che ha una sua storia elitaria) Questione di Giustizia e messo in
copertina l’immagine della «Fanciulla sulla roccia a Sorrento» di Filippo
Palizzi, quando mandai in omaggio il mio testo a Maria Flora Giubilei (dirige
il complesso dei Musei di Nervi - 4 Musei e 4 Parchi- detti “la piccola
Versailles” italiana), mi avvertì che dovevo pagar tassa: le immagini non sono
più gratis a seguito di una delibera comunale di un paio d’anni prima. Fortuna
che nel mio libro c’erano, copertina inclusa, solo cinque immagini di quadri
dei Musei nerviesi e dovetti sborsare circa euro 150, io che avevo creduto di
fare un po’ di pubblicità al complesso nerviese attraverso le mie pagine].
Per descrivere il
capitolo che riguarda la Lanterna di Genova (la vedete piccola, sullo sfondo a
destra in basso), inizio con la foto dell’antico faro così caro ai genovesi che
sorge sul colle di San Benigno all’ingresso del porto.

Barbazza
ha visto il quadretto in un ristorante di Kiel, porto di armamento tedesco nel
locale Kieler Schloss, arredato in stile marinaro. Era uno dei Captain’s paint
di scuola genovese, come quelli che aveva già visto sia al Galata (Museo del
Mare) sia a Camogli (Museo marinaro). Nella seconda metà dell’Ottocento nel
Genovesato sorse una scuola di pittori specializzati nella raffigurazione di
navi per conto degli armatori. Operavano con tecnica ad acquarello e i
bastimenti ritratti erano di fianco su una piccola varietà di sfondi, tra cui
molto “gettonato” l’ingresso del Porto di Genova. Gli artisti che si distinsero
in questa pittura furono: Nicolas Cammilleri, di Malta, il precursore, Domenico
Gavarone di Varazze che lo superò, Angelo Arpe di Bonassola.
“Ombre del passato
nelle brume di Calais” è il titolo del capitolo successivo e ci riguarda molto
da vicino, come genovesi.
L’Autore ama girare
per cimiteri e non per necrofilia (come, a scanso d’equivoci, tiene a
precisare) ma perché sono i custodi della storia di un luogo. Così passeggiava
in quello di Calais e trovò un nome:
Charles Louis Sébastien Staglieno che morì appunto in quella località
francese il 6 ottobre 1819, mentre comandava il 40° Reggimento di fanteria, la
Legion del la Somme ed ebbe questa scritta commemorativa: “meritò la morte des
braves (=gli eroi)”. Era nato a Genova il 20 gennaio 1775 da nobile famiglia
diventando assistente di campo del Doge della Repubblica. Combatté a fianco di
Napoleone in Spagna, Austria, Russia.
Però non fu
l’unico dei nostri connazionali a morire a Calais. Nella guerra dei Cent’anni
tra Inghilterra e Francia, 12mila inglesi, comandati da Edoardo III
d’Inghilterra combatterono 50mila francesi, guidati da Filippo VI di Valois con
suo figlio, il “Principe Nero”. Affiancati anche da 6mila balestrieri genovesi.
Questi furono mandati in battaglia sotto un temporale, in un vero e proprio
pantano e il disastro di Crécy – en - Ponthieu, 26 agosto 1346, vide: poche
centinaia di caduti inglesi, 30mila dei francesi, 2300 dei genovesi. Fu
l’inizio del declino di questo glorioso corpo.
Nel capitolo
seguente «Sulle rotte della Terra del
Fuoco» l’Autore, un po’ come fa Hitchcock nei suoi film, non si sottrae alla
tentazione di mettere la sua “firma da protagonista” del racconto stesso.
Ricorda infatti che l’8 febbraio 1982
sulla Federico C. che si recava ad Ushuaia in Patagonia, c’era un
giovanissimo ufficiale macchinista: Lui!
E ricorda che il
26 ottobre 1948 partì con 650 a bordo tra operai e ingegneri, ecc., da Ponte
dei Mille la motonave Genova, carica di
tutto ciò, prodotto in Italia, che serviva per ricostruire la nuova città, poi
capitale della Patagonia. Soltanto dopo un anno partì la nave con i loro
familiari: il 6 settembre 1949. Anche se molti rientrarono in Italia a
fine progetto, cioè dopo due anni, in Patagonia da allora si contarono circa
2000 italiani.
Il progetto di
ricostruzione della città, che rischiava l’abbandono dopo la chiusura della
colonia penale, era stato voluto da Juan Péron e messo in pratica
dall’imprenditore Carlo Borsari: Ushuaia divenne la città più a sud
dell’Argentina e dell’intero globo. Il nome di Patagoni era stato dato ai
nativi di quella terra da Ferdinando Magellano che li scambiò per giganti.
Com’è avventurosa la storia vera!
Ci spiega Barbazza
che le rotte della Terra del Fuoco furono molto frequentate da navi e marinai
genovesi. Molti infatti i nostri brigantini che, sfidando le tempeste
dell’Atlantico e del Pacifico, nell’Ottocento navigarono fin laggiù: doppiavano
Capo Horn per recarsi alle Chincas, le “isole del guano”, in Perù, dove
caricavano tonnellate e tonnellate di escrementi di gabbiani e di altri uccelli
marini che costituivano un pregiato fertilizzante naturale allora molto
richiesto anche da noi.
E ancora, nel
libro: scopro Simone Pietro Doria, un giovane diacono della comunità
parrocchiale di San Michele Arcangelo di Brondolo, frazione di Chioggia. Proprio
lì, il 22 gennaio 1380, morì un suo avo,
l’ammiraglio genovese Pietro Doria, in un convento assediato dai
veneziani. E fu la sconfitta della flotta genovese che il 16 agosto del 1379
aveva conquistato la roccaforte di Chioggia. Quell’unico anno di occupazione
genovese e i cinquemila prigionieri lasciarono un segno indelebile a Chioggia,
detta “piccola Venezia” per le caratteristiche urbanistiche della zona antica,
ma il dialetto chioggiotto conserva una cadenza cantilenante, simile a quello
ligure. Cosa un po’ inquietante, le leggende popolari raccontano che nella
vicina isola di Poveglia, detta “dei fantasmi”, la notte si avverte il canto
degli orfani liguri a memoria del massacro della flotta genovese.
Il racconto di
Barbazza si sposta a Pisa, già repubblica marinara. E’ di nuovo in un cimitero
dopo aver accompagnato un importante cliente tedesco a visitare la torre e il
complesso monumentale della città: “A fianco della torre, del duomo e del
battistero, e di fronte a noi, appese al muro, penzolanti, c’erano delle
immense catene di ferro arrugginito. Per soddisfare la curiosità del mio ospite
lessi le scritte sulle targhe di marmo che campeggiavano sopra i catenoni,
spezzoni di quella serie di maglie di ferro, poste a sbarrare l’accesso al
porto di Pisa. I genovesi, guidati da Corrado Doria, nel 1290 riuscirono a
superarle grazie all’ingegno di un fabbro, Noceto Ciarli, che accese il fuoco
sotto la catena, arroventandola. Dopo averla così indebolita, venne spezzata
con l’urto delle navi: i genovesi entrarono in porto e sparsero il sale sulle
rovine. Era la punizione per quella Repubblica Marinara Pisana che non aveva
rispettato gli impegni previsti dal trattato del 1288 dopo la pesante sconfitta
della Meloria. Anelli di quella catena vennero smistati anche a Firenze e a
Genova. Oggi le due città, oltre che dalle regate delle antiche repubbliche
marinare, sono accomunate da due tra i più famosi cimiteri monumentali del
mondo e dalle ombre e dai fantasmi dell’antica battaglia”.
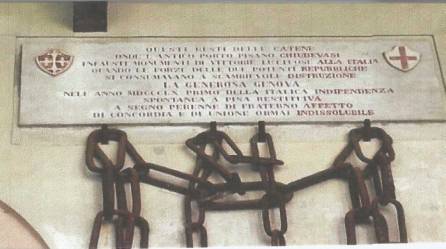
Barbazza scopre un
sottile filo che accomuna otto stati nordamericani e corre al nord e, da est ad
ovest, attraversa quasi tutto il continente. Sono dieci città che portano tutte
lo stesso nome: “Genoa”, in onore di quella originale. Una nello stato di New
York, due in Ohio, una nel Michigan, una nell’Illinois, due nel Wisconsin, una
in Nebraska, una in Colorado e l’ultima nel Nevada. In aggiunta a queste, altre
quindici località con lo stesso nome. In
tutto venticinque, in venti diversi Stati, le Genova (o Genoa) statunitensi. Fa
effetto imbattersi in cartelloni stradali con scritte come: “Welcome to Genoa,
Nevada’s oldest town”, o “Genoa, Nebraska, Pawnee capital” (gli “indiani
cattivi” di «Balla coi lupi»), o ancora, “Genoa Wonder Tower”.
La leggenda
racconta che la “Genoa” del Colorado, fondata nel 1888 come “Creech”, fu nel
1895 re-intitolata con il nome della “nostra” città. Fu l’ultimo desiderio di
un operaio delle ferrovie, pesantemente infortunato e destinato a morire poco
dopo, che, rendendosi conto di non poter più tornare a vedere la «Lanterna»,
parlava in continuazione della sua città natale. E’ stato il suo «Ma se ghe
pensu» e ci sembra di ascoltarlo come lo cantava l’indimenticabile Bruno Lauzi,
dall’indimenticabile voce.
E poiché musica e
cucina sono due piaceri della società in ogni tempo l’Autore ci spiega che il
Pan di Spagna nel mondo è la Pasta genovese.
Nel 1747 il
marchese Domenico Pallavicino, inviato della Repubblica di Genova come
ambasciatore presso Ferdinando IV, Re
di Spagna, pensò di far preparare per lui dal suo cuoco, Giovanni Battista
Cabona, un dolce che fu battezzato Pan di Spagna in onore del monarca, ma
suscitò tanta ammirazione presso la
Corte che vollero onorarlo con il nome della sua provenienza: Génoise!,
così è conosciuto nel mondo. Rimarca Barbazza: “ma a Genova non la chiamano
così” e lo dice con un po’ di malinconia la stessa nel raffronto del Porto di
Genova – Pra’ con il Porto di Rotterdam . Questo in otto anni è diventato
un terminal gigantesco, ha prodotto una
spiaggia che prima non esisteva, un Museo: è cresciuto non intaccando
l’ambiente, creando ricchezza ed occupazione. A Pra’ purtroppo è successo
esattamente l’opposto.
Quante cose si
possono imparare dai 43 capitoli del libro o ricordare. E dato che da poco si è
conclusa la giornata della donna (in sordina a causa dell’emergenza) in un
capitolo viene ricordata Caterina Negrone di Bogliasco, “pioniera ed eroina del
volo che, nel 1935, a bodo di un biplano Caproni Ca-113, conquistò il record di
altitudine femminile per aerei a elica, record tutt’ora imbattuto”.
Però voglio chiudere in modo ancora un po’
cimiteriale (anch’io sono amante delle peregrinazioni nella quiete di cimiteri
che racchiudono storia e vita delle città e sono ricchi di storie di uomini…).
Chiudo con
l’immagine dell’Angelo di Staglieno,
(ammalia anche gli olandesi come spiega il titolo del capitolo che lo
riguarda).
Barbazza, in
Olanda davanti ad un club fotografico che espone opere di Liz Windt (foto
dell’olandese di Vendaam pubblicate nel suo libro I luoghi della memoria), vede
proprio l’Angelo di Monteverde o Angelo della Resurrezione. A Staglieno decora
la tomba monumentale della famiglia Oneto (13° nicchione del porticato
superiore, lato ponente) e fu realizzata nel 1882 da Giulio Monteverde.
Barbazza sottolinea che Staglieno è il più importante Museo a cielo aperto
d’Europa.
(Ricordo però
anche la frase che Agatha Christie mette in bocca ad un personaggio in un suo
giallo: “Non ho mai visto niente di così kitsch come il cimitero di Staglieno”.
E’ infatti improntato non solo al ricordo ma anche alla magnificenza. Altri
cimiteri come quelli israeliani
coltivano invece l’umiltà).
Dal libro
inserisco l’immagine bellissima e malinconica dell’Angelo come una riflessione
sul senso della vita. Chiudo con un elogio, molto sentito, allo stile del
“nostro” Barbazza, che tale lo sentiamo dopo aver scorso il suo libro: uno
stile asciutto, senza spreco di parole
e per questo più diretto, più capace di entrarti in cuore.

REWIND
di Guido
Barbazza
(Allego l’antica
recensione che ebbi modo di scrivere su questo testo dell’Autore, condizionata
dagli spazi in un giornale: la carta stampata permette solo riflessioni brevi).
~
~ ~
~ ~ ~
“Una bellissima,
lunga, diritta spiaggia di sabbia grigia, digradante dolcemente sino a
inabissarsi nel “gradino”, ove il mare si faceva più profondo”, una descrizione
che è atto d’amore, e con rimpianto, dell’arenile di Pra’ di un tempo. In Rewind (De Ferrari), l’autore Guido
Barbazza esprime la convinzione che il Porto costruito al posto dell’antica
spiaggia sia un errore tanto più che il Porto di Genova non era utilizzato
secondo la reale capienza, com’è evidente dai chilometri e chilometri di
banchine e capannoni mezzi vuoti. Il concetto “scomodo” lo fa dire dagli
abitanti del quartiere che un tempo coabitavano felicemente con i tanti
turisti, che fruivano insieme di quel luogo accogliente, pieno di ombrelloni
festosi: “Qui è stato perpetrato uno dei più grandi crimini ambientali della
storia. Un crimine contro l’umanità. Hanno fatto sparire tre chilometri di
spiaggia. Ci hanno seppellito sotto una discarica. Hanno massacrato, cancellato
un paese, ci hanno eliso. Ma dov’erano gli ambientalisti, quando qui facevano
cose turche? I nostri politici da strapazzo, telecomandati da capi, a cui del
nostro paese non importava un fico secco, ci hanno diviso, imbottendoci di
palle sulle migliaia di posti di lavoro e la ricchezza che sarebbe derivata da
questo Porto senza senso”.
Barbazza, ingegnere e capitano di mare, è un
innamorato di Pra’ come testimoniano le sue molte pubblicazioni da Antologia
Praese, a Pra’ qui Pra’ là, al giornale “Il Praino” da lui fondato nel 2009; è
anche autore di romanzi: Salvate il Generale e Il Diavolo e l’Acquasanta. In questo libro si cimenta nel giallo
e la storia ha per protagonista Giorgio Bignone, un americano agente della CIA,
però orginario del luogo, coadiuvato da un’avvenente poliziotta, il cui lato b,
esaltato dai pantaloni della divisa, non ha niente da invidiare a quello della
nota Pippa.
L’avvio è con lo schiantarsi della settima grande
nave contro la diga del Porto di Pra’ e con l’uccisione da parte di un serial
killer di eccellenti sui cui cadaveri lascia un biglietto con scritte del tipo:
“Nemico del popolo, nemico dell’ambiente...” Proibito raccontare la trama di un
giallo, però il finale presenta sorprese non-scontate, con attinenza al
paranormale, agli avatar, ad X-Files. Perciò il libro piacerà anche ai più
giovani che amano questi sfondi sovraumani. La riflessione possibile è che tali
nuovi personaggi non provengano da spazi remoti, ma rappresentino una coscienza
collettiva, che nasce dal passato e si proietta nel futuro per ammonirci a non
autodistruggerci. A questo riguardo due frasi del libro mi sembrano
significative: “Se vuoi capire un paese passeggia nel suo cimitero”, e: “Come
può un popolo lasciarsi stuprare, annullare, senza far niente?”. Il racconto,
davvero mozzafiato, che costringe ad andare all’ultima pagina senza pause, ha
il valore aggiunto di quadri marini: “Il branco di sgombri guizzante
nell’enormità blu del mare di luglio in cerca di acciughine, le conchiglie (i
cornetti come le turritelle, le più ricercate dai bimbi), i quattro ragazzi che
mettono in mare un canotto provocando grandi schizzi con i piedi nudi che
battono ritmicamente la ghiaia effervescente...” E di quadri storici dove
qualche elemento del passato si fa, senza infamia anzi con decoro, connotativo
del paesaggio: la Casa del Fascio, la Torre del Grillo, il cantiere Tixi, fin
un nome “Sextum”, buttato nella conversazione più semplice senza peso
didattico, ad indicare Sestri e la sua origine romana.
Trieste e le divergenze parallele
di Guido
Barbazza
Trieste è la città italiana dove ho trovato
la maggiore quantità e varietà di collegamenti con Genova. Le due città si sono
spartite il dominio armatoriale e cantieristico nazionale operando con un
insolito rapporto di collaborazione e competizione, di “divergenze parallele",
consolidando le rispettive aree di supremazia sui due versanti della penisola:
quello tirrenico e quello adriatico. Oggi si barcamenano entrambe ricordando
gli splendori della loro “noblesse”, ormai offuscata. I collegamenti magari
subito non saltano all’occhio con grande evidenza ma, con un po’ di attenzione,
gratta gratta, vengono fuori copiosi. Possiamo cominciare con i curiosi
paralleli legati al nome della nostra città. Infatti, la sede legale della
Fincantieri, a cui fa capo il cantiere navale di Sestri Ponente, si trova
proprio in via Genova, e il prestigioso istituto nautico della città giuliana è
intitolato a Tomaso di Savoia, Duca di Genova. In via Venti Settembre, a Genova, c’è la “Gioielleria Triestina”, e
nella Delegazione di Sestri Ponente troviamo addirittura piazza “Triestino
Genovesi”. Alla banchina dello Yacht Club genovese, il
ventisei marzo del 1930 era ormeggiata la nave Elettra, da cui Guglielmo
Marconi fece partire il segnale radio che fece accendere le luci del municipio
di Sidney, in Australia, dando inizio all’era delle telecomunicazioni. Ebbene,
proprio l’Elettra, requisita dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale,
venne affondata da cacciabombardieri alleati in prossimità di Zara. Recuperata
e riportata in Italia nel 1962, la
sua prua è conservata presso l’area “Science Park”di Padriciano, a Trieste, e
sempre nel capoluogo giuliano altri resti della nave sono conservati presso il
Civico Museo del Mare e il Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa. Se
parlate con un triestino, poi, è meglio non tirare fuori quell’antica vicenda
dell’estate del 1380, quando, durante la guerra contro Venezia, una squadra di
trentotto nostre galee al comando del Capitano Matteo Maruffo, per vendicare la
bruciante sconfitta subita poco prima a Chioggia attaccò Trieste, da pochi anni
sotto dominio veneziano, saccheggiandola selvaggiamente. A ricordo di
quell’impresa, resta un leone di pietra incastonato sulla facciata di Palazzo
Giustiniani, nell'omonima piazza nel centro storico di Genova. L'iscrizione
sotto il leone alato di San Marco, simbolo di Venezia, ricorda che questo leone
proviene proprio da Trieste. E’ curioso il fatto che, negli anni tra le due
guerre, le più importanti costruzioni navali siano state spartite, con precisione
“cencelliana”, tra Genova e Trieste. Infatti, ben prima che il democristiano
Massimiliano Cencelli, nel 1967, inventasse la celebre formula per la
spartizione delle cariche pubbliche in base al peso elettorale di ogni singolo
partito o corrente politica, nel 1931 a Genova l’Ansaldo varava il
transatlantico “Rex”, che conquistò il “Nastro Azzurro”, ma la nave gemella, il
“Conte di Savoia”, fu costruita in contemporanea a Trieste dai Cantieri Navali
Riuniti dell’Adriatico. La corazzata “Roma”, affondata dai tedeschi subito dopo
l’armistizio, fu costruita a Trieste dal Cantiere San Marco insieme alla
gemella “Vittorio Veneto”, ma le altre due gemelle, la “Littorio” e l’ “Impero”
toccarono all’Ansaldo. Nel dopoguerra fu la volta del transatlantico “Michelangelo”,
costruito a Genova, e della gemella “Raffaello”, varata, guarda caso, proprio a
Trieste. Diversamente andò in anni più recenti quando, dovendo decidere in
merito alla sede della neonata Fincantieri le “divergenze parallele” tra le due
città si risolsero a favore di Trieste. E Genova restò con un palmo di naso. Ma
questa è un’altra storia.
Notizie d’Autore
Sono partita dal recente libro Il genovese volante di Guido Barbazza
che è ciò che il lettore si trova tra
le mani e su cui può riflettere, però mi sembra indispensabile completare con
qualche notizia sull’autore.
Guido Barbazza, nato nel 1960 a Genova, capitano e ingegnere, è Executive della multinazionale Wärtsilia
ed ha pubblicato: Salvate il Generale (Frilli,2008); Il diavolo all’Acquasanta
(De Ferrari, 2010), Rewind (De Ferrari, 2012), Uomini Neri (Magenes, 2013), Il
macchinista (Magenes, 2017).
La rubrica sul Secolo XiX, il giornale dei
genovesi, gli è stata richiesta da Alessandro Cassinis,
nato a Milano nel 1960 che nel 1998
divenne redattore economico del Secolo xix diventandone direttore nel 2014 fino
al 2016 quando gli subentra Massimo Righi ed ora ha l’incarico di
editorialista.
L’ho conosciuto di persona, apprezzando la
sua voglia d’informare diretta non solo alla nostra città o al nostro Paese ma
con un interesse a più vasto raggio e per questo lo stimo.
Una piccolissima nota sul titolo che
parafrasa L’Olandese Volante, leggenda che Richard Wagner musicò e che narra di
un vascello condannato a vagare per i mari in eterno in seguito ad un patto che
il suo comandante fece con il diavolo. Riguardo la sua esistenza ci sono però
testimonianze come quella di un suo avvistamento ad est di Suez per cui
l’ammiraglio Karl Donitz scrisse nel diario di bordo che gli uomini del suo
equipaggio dicevano di preferire uno scontro con la flotta degli Alleati (era
il 1943 della II Guerra Mondiale) più che riprovare il terrore di un secondo
incontro con la nave fantasma.

(Una delle tante riproduzioni del temuto vascello fantasma)
Infine poiché una delle passioni di Barbazza
è la Storia, quella che la scrittrice
genovese Minnie Alzona diceva di mettere sempre
nei suoi libri per dar loro maggior consistenza, riporto alcune note di storia
genovese secondo il cardinal Giuseppe Siri.
Cardinal Giuseppe Siri
e la Storia di Genova

Dal colloquio con Siri, appassionato della
Storia di Genova che mi parlò di momenti della
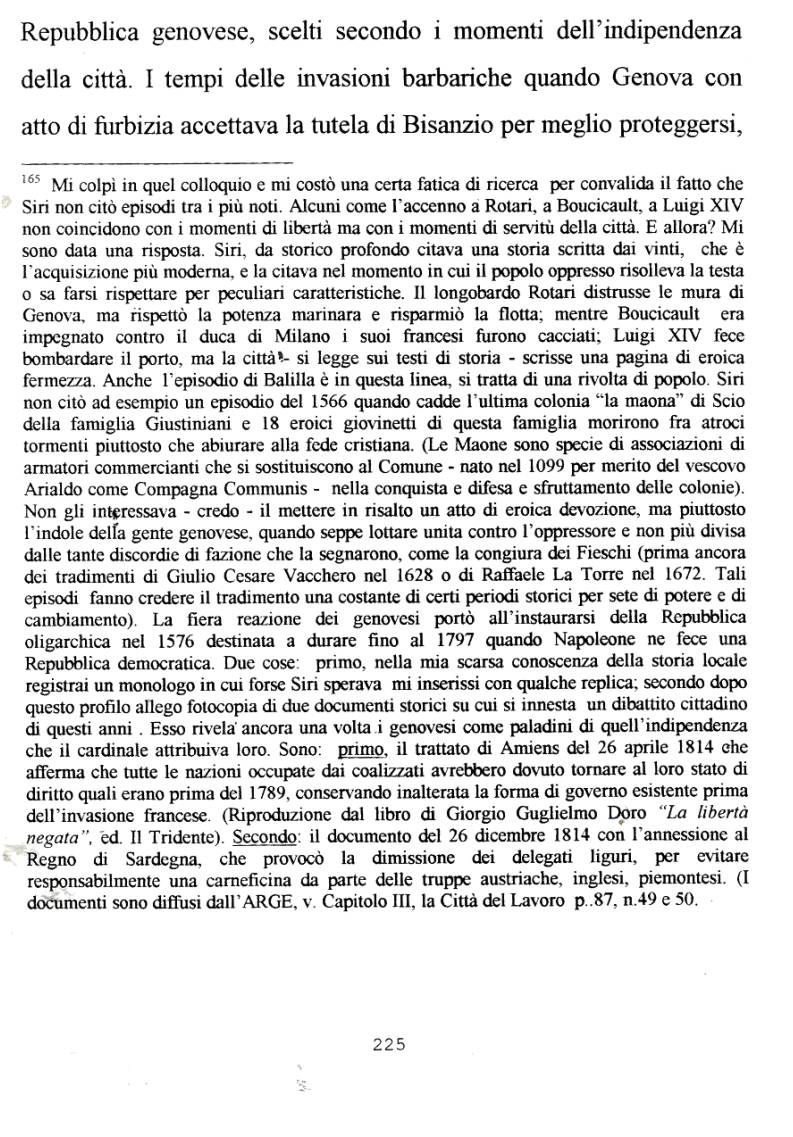
Nel
1993/94 per la Scuola delle Comunicazioni Sociali dell’Università
Cattolica di Milano, scrissi la Tesi di Specializzazione
“Nascita e sviluppo del Settimanale Cattolico di Genova",
relatore Gianfranco Garancini e al
Capitolo VII, I Giornalisti,
iniziai con il colloquio che ebbi con il cardinal Giuseppe Siri: aveva infatti compiuto nella
primavera del 1986 i 40 anni di governo
pastorale e poiché la data non precedeva di molto l’eleborazione di
questa tesi pensai fosse l’occasione per riportarla ricordando le sue parole di
quando aveva iniziato il colloquio con me: “Le dico
questo perché un giorno Lei ne scriva”.
Mi aveva suggerito di andare da Siri il
professor Gianfranco Bianchi, fondatore con Mario Apollonio della scuola
stessa, nel 1965 a Bergamo, e dove erano stati invitati ad iscriversi i
migliori laureati d’Italia di ogni Facoltà. L'invito era stato rivolto anche a
me, laureata in Lettere classiche all’Università di Genova, Facoltà di Lettere
con il grecista Enrico Turolla e tesi Aristeia omerica e virgiliana. Allora,
(mi ero sposata il 4 aprile del 1964), non potei accettare dato che sarebbe
stato troppo difficile per me frequentare la scuola che era a Bergamo (e con
frequenza obbligatoria). Rinunciai. M’iscrissi e diplomai in seguito trovandomi
a vivere con mio marito e i tre figli un anno a Milano dove si era trasferita
la scuola nella sede dell'Università Cattolica.
Anche per recarmi da Siri tergiversai
qualche mese, però poi andai, ricevuta in una delle sue udienze del mercoledì.
Siri mi disse che non concedeva interviste e quindi mi pregò di mettere le sue
parole come riflessioni mie su ciò che mi avrebbe detto però fu prodigo di
notizie.
Pensava ai problemi di Genova e nella tesi
scrissi in dettaglio ciò che aveva compiuto per la città, dall’introduzione dei
Cappellani del Lavoro subito dopo la guerra all’Opera delle Minestre, alla
destinazione di un fondo per la costruzione di case economiche per i meno
abbienti... Siri, nel ricordare i pochi uomini che nell’Otto/Novecento fecero
Genova fiorente come il senatore Erasmo Piaggio disse:
“Se suo figlio Rocco fosse vissuto più a lungo, Genova avrebbe pianto meno”.
Mi confidò il suo amore per la musica nato
per merito di un compagno, don Pertica, ottimo
musicista. “E fu un bene – precisò-
perché dietro la musica avrei potuto perdere la testa e non avrei fatto altro”.
Gli piaceva Schubert per la vita struggente e per la ricchezza melodica e ogni
anno, quando poteva far a meno dell'etichetta (che sentiva come una
costrizione) si recava a Vienna per ascoltare buona musica.
Per Genova affermava: 1) l'industria era
stata penalizzata con la parziale statalizzazione conseguente al sostegno
chiesto nel dopoguerra per riconvertirsi a scopo di pace; 2) il Porto, vera
vocazione genovese con il commercio, era diventato tanto capace da avere km.18
di banchine; 3) la città d’arte era seconda forse solo a Firenze, purché i
proprietari di tesori, accumulati come “riserve" di valore,
acconsentissero ad aprirli."Genova – diceva - è
la città dei tesori nascosti, tutta da scoprire".
Ricordava come la Chiesa genovese avesse dovuto
arginare sul campo i problemi della città, tra cui il degrado del centro
storico, dove molti erano gli alloggi sfitti e abbandonati agli
extracomunitari. “Per questi fratelli sradicati – tagliava corto - la Curia ha
fatto tutto ciò che ha potuto e c’è una speranza: la
città ha una tale forza di carattere che le basta una generazione per
assorbirli”.
A concludere, gli chiesi:"il suo Popolo, le ha attribuito qualità come
l'intelligenza, la coerenza, la cultura, la pazienza, il rigore, quale di
queste ritiene più sua?"
La sua
risposta:
"Non so,
è irrilevante. So che ho una faccia sola, mai due".
Della mia prima tesi di
specializzazione alla SSCS (Scuola Superiore delle Comunicazioni Sociali)
dell'Università cattolica,
Momenti e problemi di vita
genovese nell’immagine di "Il Cittadino” (1873-1974), relatore Gianfranco
Bianchi, anno 1982/83
riporto due pagine.
(Della mia primissima tesi l “Aristeia”, con
cui mi laureai all’Università di Genova e per cui il prof. Enrico Turolla
avrebbe chiesto la dignità di stampa se, dopo la laurea, acconsentivo a
migliorarla continuando all’Università, so che cinque
anni dopo andò al macero come tutte le altre. Ignoro ciò che avviene ora
per le tesi, anche quelle degli studenti più brillanti, perciò ritengo che il
loro contenuto rimanga noto solo a chi lo ha scritto, pur se interessante, per
studio e novità di ricerca e di sensibilità).
La prima pagina che ne riporto riguarda il
cardinale Siri ma non c’è il colloquio con lui che prima ho ricordato (allora,
molto “disciplinata” anche con me stessa, riportai nella tesi solo il suo
pubblico Elogio funebre per il cardinal Boetto)
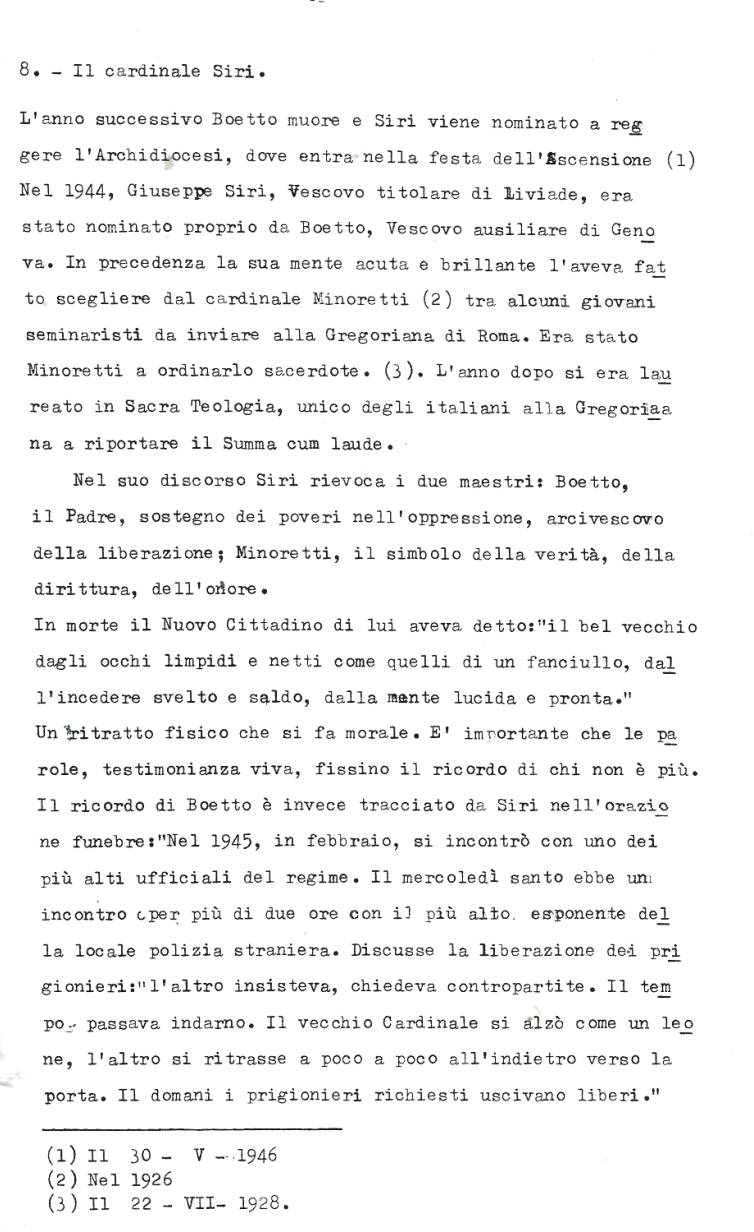
Quindi mi piace inserire il fondo
di Fausto Montanari La fatica della libertà alla
ripresa della pubblicazione de "Il
Cittadino"
il 23 maggio del 1945