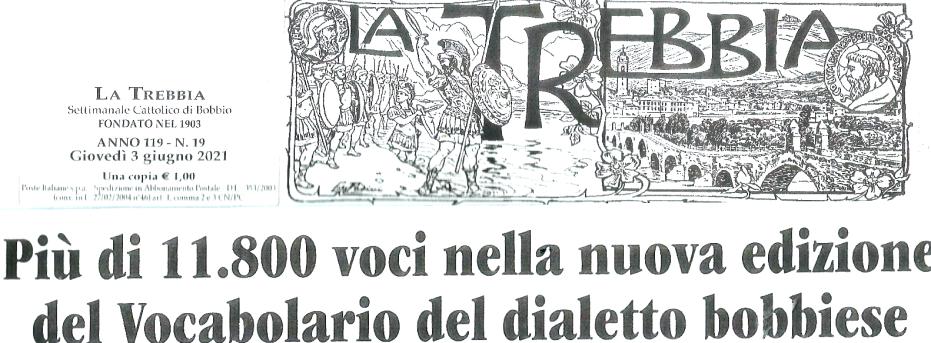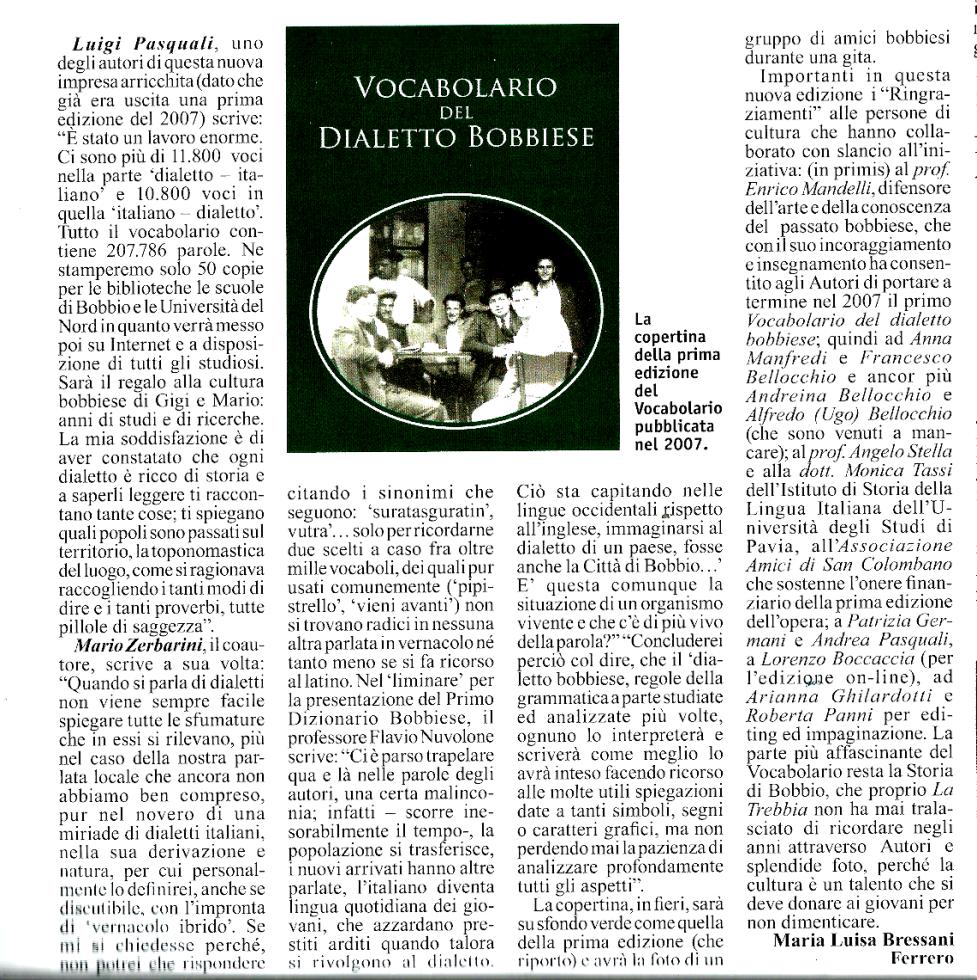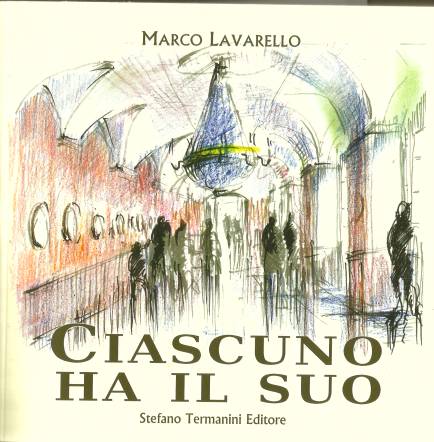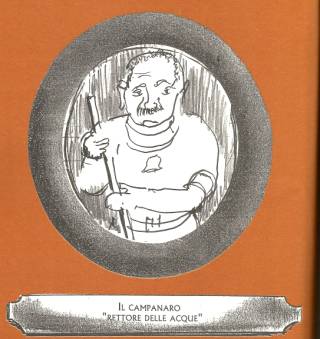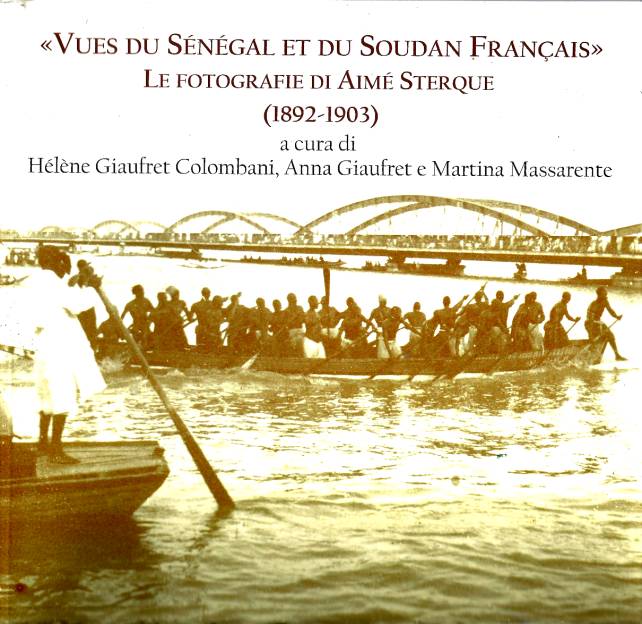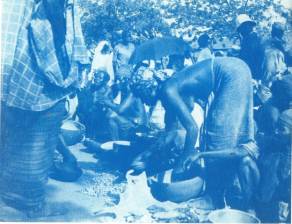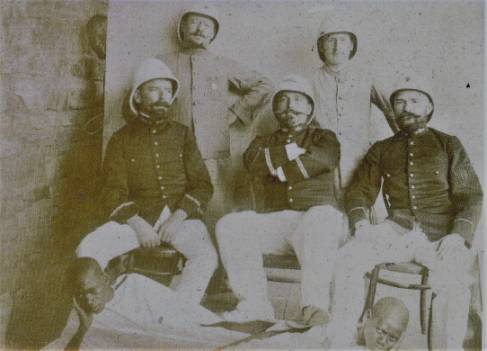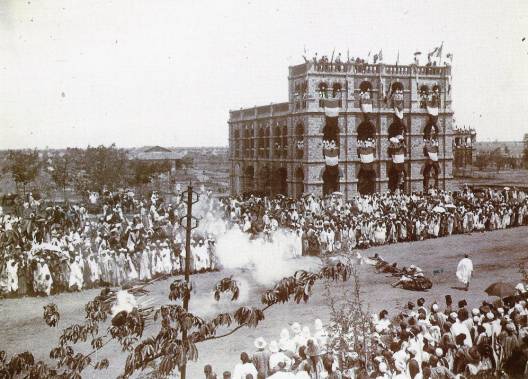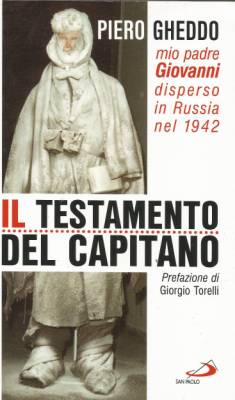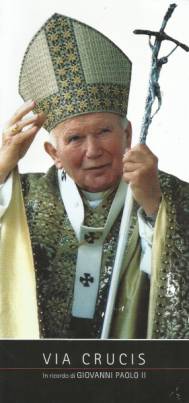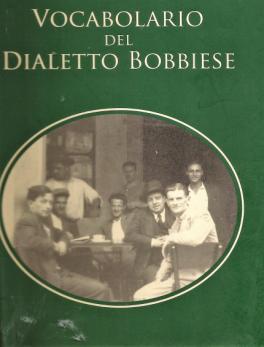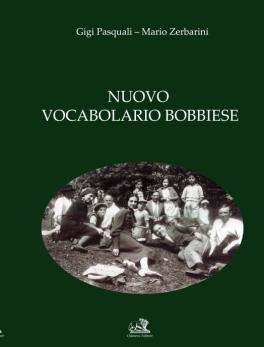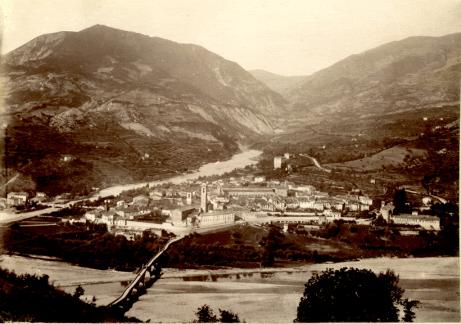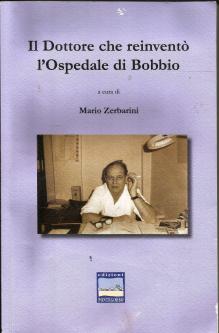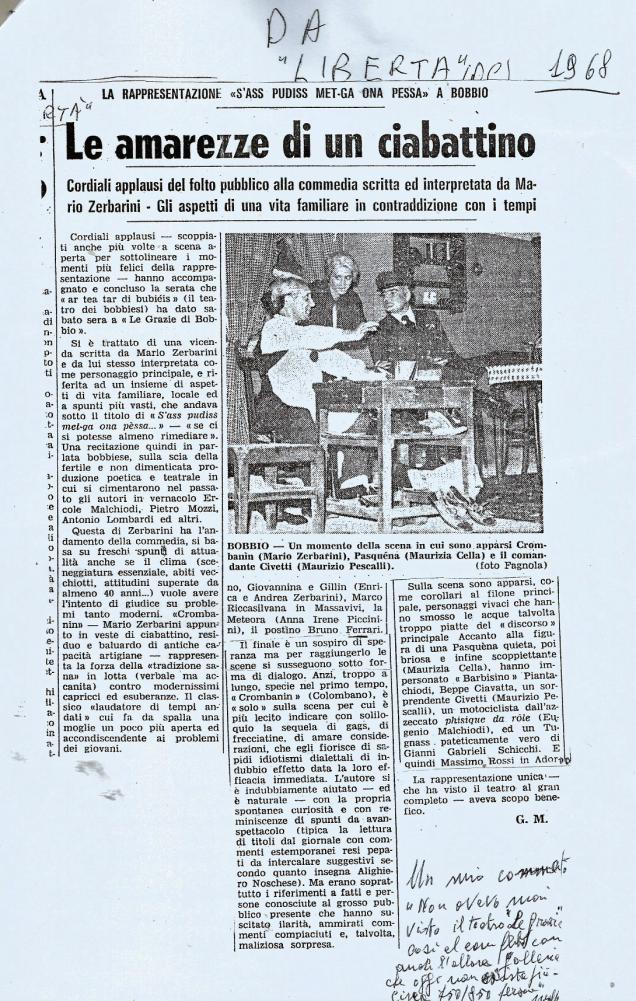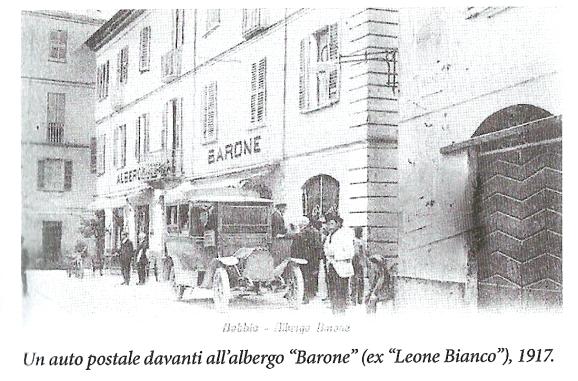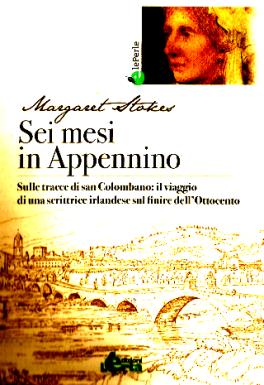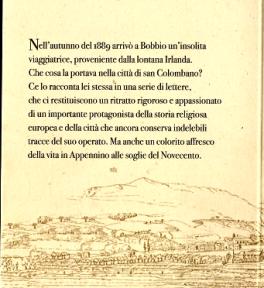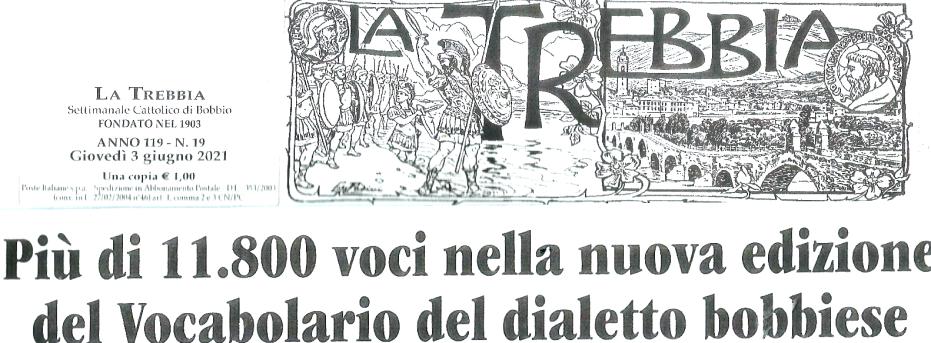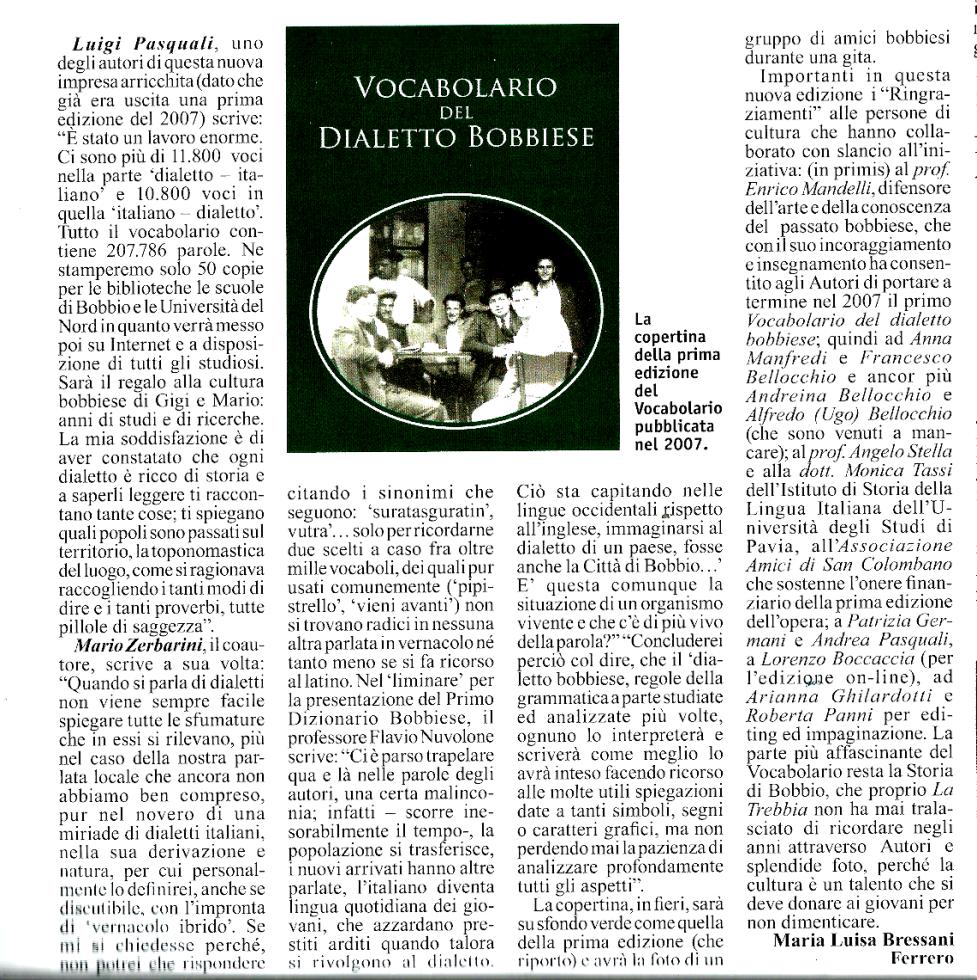Mi sembra giusto e opportuno premettere alla mia recensione al
libro parole dell’Editore Stefano Termanini, che ha considerato Lavarello
come “maestro”.
<<Marco – dice - era un creatore di mondi e un costruttore di positività. In ogni
sua cosa: quando progettava Euroflora e ne ha
progettate
tante
edizioni, quando disegnava uno studio
per un amico medico o avvocato o Ia nuova casa di giovani sposi. Quando
disegnava un teatro.
Quando faceva incontrare due amici.
Marco era amico di tutti ed
egualmente, badava al valore intrinseco di ciascuno. Per una specie di magia
transitiva, sapeva far nascere
amicizia e stima reciproca fra i suoi amici, pur se fra loro fino ad
allora non si conoscevano. Ne era lui stesso garante. Marco studiava le
persone e aveva per loro uno speciale intuito. Poi ‘le inseriva’,
costruendo attorno a loro il loro ambiente: Iui aveva già visto quale,
per loro, sarebbe stato il più opportuno e il più consono>>.
Solo dopo queste parole
emozionanti e dopo aver letto scrivo le mie impressioni, partendo dalla
sensibile dedica che l’Autore premette
al suo testo:
Ai molti che non hanno mai saputo
quanto mi hanno dato.
Lavarello, a otto anni dalla laurea in architettura, entra come
apprendista-giornalista nel quotidiano cittadino e scrive diversi articoli
sulla
politica e le imminenti
elezioni ma dai suggerimenti e agli insulti dei lettori capisce che “quella non
è la sua strada”. Però il
direttore, con pazienza, lo chiama per chiedergli “cosa voglia davvero scrivere”.
Risposta: <<a me piace la mia terra, queste colline e queste
pianure… mi piace questo cielo … vorrei scrivere su questa terra e su questa
storia, vorrei parlare di
questa gente… Li conosco, li capisco,
ho i nonni in questo cimitero, li conosco nella loro dignità sempre difesa,
nel loro sorridere ed
anche piangere>>.
Per il nuovo incarico che gli viene accordato, con entusiasmo e
preveggenza per un futuro che sarà anche di scrittore, inizia a cercare
nell’archivio comunale di un borgo che però è andato a fuoco. Ma
vi incontra proprio sulla scala d’accesso una ragazza che lo invita
a consultare l’archivio di famiglia del suo trisnonno, agricoltore,
umanista e storico. Nasce così questo album di ritratti illustrati, dato
che Lavarello è abile disegnatore. Racconta “storie di uomini”, ricercando in base
all’archivio chi ha avuto una famiglia, vissute lì
da tanto, tanto tempo. Entra in contatto con il sindaco che
abbraccia il suo progetto e gli propone di estrarre a sorte un’altra ventina di
nomi oltre a quelli da lui
selezionati. Nascono così le 25 interviste del libro.
Per far meglio capire dalla prima allego alcuni spunti.
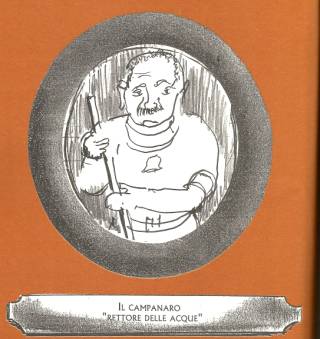
Inizia con una frase del campanaro: <<sa con il mio mestiere
si ha un padrone esigente: l’orologio>>. Spiega che nel taschino tiene
una
“cipolla da ferroviere”,
ma suo padre che faceva già il suo lavoro l’aveva in testa e sapeva sempre ore
e minuti tanto che la moglie
commentava: <<deve
aver avuto una mamma svizzera>>. Spiega poi che come primo compito apre e
chiude la fornitura dell’acqua ai
singoli poderi e come secondo
annuncia le messe con le campane facendole suonare tutte e otto nei giorni
di festa. Di solito con
tre campanelle suona anche
qualche musichetta per annunciare le messe.
Per il primo lavoro, quello da “rettore delle acque”, precisa:
<<quando verso agosto il sole brucia, guardo verso sud per vedere
se lo scirocco ci manda
nuvole. Per giorni e giorni il cielo è pulito, notte dopo notte la luna ci
illumina. Nel fiume l’acqua cala…
4io vado lo stesso a vedere i campi ed i campi mi vedono
sempre…poi una notte la luna ha l’alone e qualcosa cambia…Acqua,
acqua dal cielo…e io parlo
da solo e rido come chi ritrova la felicità>>.
C’è tanta poesia in questa parole del “rettore” che da “campanaro”
ricorda un episodio di una domenica quando fece suonare dalle
campanelle una musichetta
allegra. Sentì un vociare e
affacciandosi alla ringhiera vide una trentina di persone ferme all’angolo
della
farmacia, che gli
indirizzarono un caloroso applauso. <<Non avevo mai avuto un successo da
ribalta>>, commenta e così rientrato fece
risuonare il
"bis" della canzone.
Lavarello da architetto ha avuto un cursus ricco di soddisfazioni
ed anche una lunga vita perché è morto quasi centenario.
Ha realizzato il Teatro
Margherita di Genova, descritto come magnifico nelle guide cittadine e che era sorto nel 1855 come Nuovo
Teatro Andrea Doria, a brevissima distanza da Porta degli Archi. Ristrutturato una prima volta nel 1885, poi
intitolato alla Regina
Margherita, fu distrutto dai bombardamenti inglesi durante la
seconda guerra mondiale. Ricostruito
tra il 1954/57 con il “Progetto
Lavarello", s’inaugurò con la commedia Pignasecca e Pignaverde di Gilberto Govi. In attesa della
ricostruzione del Carlo Felice,
per i successivi trent’anni vi si trasferì la stagione dell’Opera
lirica.
L’architetto e scrittore, nato e vissuto a Genova, è stato
co-titolare dello “Studio Lavarello"
noto per le sue realizzazioni come
l’arredamento del mitico
transatlantico Michelangelo, l’ammodernamento della Camera dei Deputati, la
progettazione di Euroflora,
quasi sua figlia perché
l'ha accompagnata al successo per i primi sei o sette anni.
Mi piace concludere ancora con parole di chi l’ha conosciuto,
tratta dalla commemorazione per lui di Ugo Serra, il 6 novembre 2018
al Rotary Club di Genova.
<<Le petits cadeaux font la bonne amitié era un adagio francese caro a Lavarello e sono stati tanti
i piccoli doni che ci faceva
ogni volta che lo
incontravamo: il dono del sorriso, della battuta piena di umorismo
intelligente, dell’apprezzamento sincero,
dell’attenzione
affettuosa.
Ogni suo gesto verso il prossimo fondava le radici in una
partecipe condivisione della condizione umana. Guardava e vedeva dentro
alle persone, ne conosceva
soprattutto i valori che ciascuno ha, a volte senza saperlo. E’ stato così
anche nel suo rapporto con il
Rotary. Eravamo entrati
insieme cinquanta anni fa. Ne apprezzava valori e ideali ma a volte si
dispiaceva che in qualche circostanza
vi si scorgesse
utilitarismo e materialismo.
(Per concludere): quando una nave lascia un porto per il suo
viaggio sul mare, noi che restiamo sul molo diciamo ‘è andata' e quando
sparisce dietro
l'orizzonte diciamo ‘è scomparsa’ . Ma non è scomparsa, siamo noi sul molo che
non la vediamo più, ma la nave esiste,
naviga nel grande oceano.
Marco è lassù, nell'immenso oceano dell'universo, dove tutti i perché hanno una
risposta>>.
AIME’ STERQUE
Vues du Sénégal
et du Soudain Français
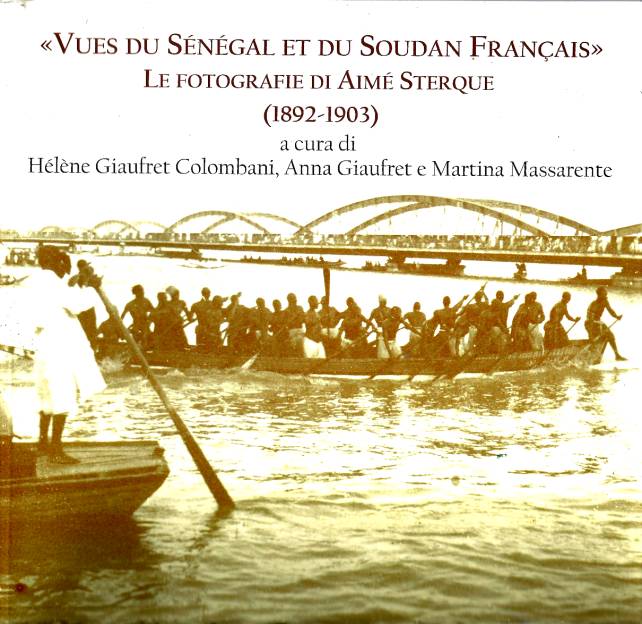
Un libro prezioso, perché raffinato ed elegante,
edito da Stefano Termanini (Serel Inernational s.r.l.) nel 2019: nasce da una
Mostra fotografica come spiegano nella presentazione la nipote Hélène Giaufret
Colombani e sua figlia Anna Giaufret.
Il loro nonno e bisnonno fu soldato poi ufficiale nelle truppe coloniali
in Africa e in Indocina dove morì nel 1911 a 41 anni.
Le sue foto (vues parola che in francese ha una
stratificazione di significati ad indicare un’immagine, soprattutto un dipinto o una fotografia che proprio con
questo termine sono indicati nelle
cartoline costituiscono un Fondo di “39 monoscopiche su vetro", "38
stereoscopiche su vetro", e 241 stampate all'epoca.
Come si può vedere dai vari loghi sotto la foto
tanti gli sponsor della mostra.

L’ufficiale ritratto nella quarta di copertina
sopra riportata sembra salutarci, mettere la sua firma per noi lettori, ma
poiché da nessuna parte si specifica che si tratti di Aimé diventa solo
un’implicita deduzione.
In breve la vita di Aimé è questa: nasce a nel 1870 a Bonlieu nel Jura ed è figlio di
un maniscalco e di una agricoltrice. Nel ’91 si arruola come volontario
nell'esercito (artiglieria di marina), quindi per due anni è in una prima
missione in Sénégal, nel ’98 in una seconda, quindi per altri due anni nel
Soudan Francese in guerra (oggi Mali). Torna e si sposa con Marie Genin di
Arles ed hanno quattro figli di cui il primo, chiamato Aimé come il padre,
muore da bambino. Una della sue sorelle Lucie è la madre di Hélène che ha
raccolto il materiale della mostra e dato il via a questo album illustrato.
Dopo la pace, già promosso ufficiale, torna in Soudan: è il periodo delle tante foto che
invia alla famiglia. Quindi tra il 1905-1907 è inviato in Indovina (Concincina)
e nel suo ultimo anno di vita a Tonchino, viene quindi sepolto ad Hanoi.
Molti ed eccellenti i nomi di chi ha collaborato
con brevi saggi farci capire le foto:
Xavier Ricou contestualizza il
materiale nel quadro del Sènègal colonizzato, Marie Rodet ci illustra la
situazione in Soudan, Elisabetta Papone ricolloca le immagini nelle tecniche
fotografiche dell’epoca. Infine Martina Massarente ripercorre come si è
arrivati ad organizzare la Mostra. Quasi pietra preziosa ad illuminare tutto il
percorso un viaggio in Sènègal di Anna, pronipotina di Aimé, impegnata per tre
mesi in un programma di cooperazione, ma per ragioni di sicurezza non ha potuto
recarsi a Kayes nel Mali, dove è stata scattata la maggior parte delle foto.
Adesso scelgo dall’Album fotografico alcuni scatti
che mi sono sembrati molto interessanti per farci capire o che mi hanno
attratto per la loro singolarità
Il primo riguarda le imbarcazioni di quel viaggio.

Seguono poi due scatti in blu che Elisabetta Papone
chiama “cianotiopie", spiegandoci che sono dovuti ad una tecnica antica,
recuperata sul finire dell’Ottocento con una colorazione azzurro-blu che la
rende simile ad un acquarello.
Il primo dei due rappresenta un gruppo di abitazioni tradizionali, il
secondo riguarda il mercato di Kayes.

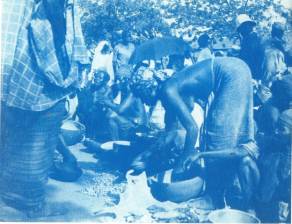
Sono davvero suggestivi!
Quindi
scelgo altre due foto: la prima è intitolata “cinque ufficiali", la
seconda “due militari in groppa a due asini” e non può non venir in mente come
probabilmente sia nato il detto: “in mancanza di cavalli trottano anche gli
asini.
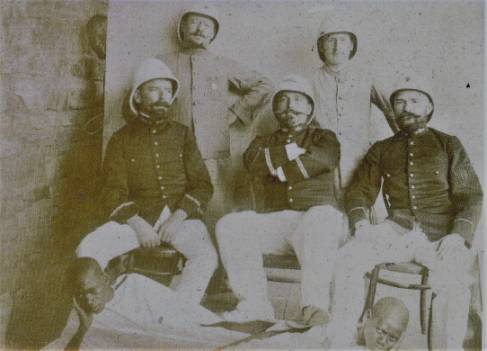

Quindi altrettanto splendide la foto dei sacchi di
posta francese a Kayes che gli indigeni portano in capo.

Né poteva mancare l’immagine della festa del 14
luglio 1902 che è festa nazionale francese dal 1880 ricordando la presa della
Pastiglia dell’anno prima.
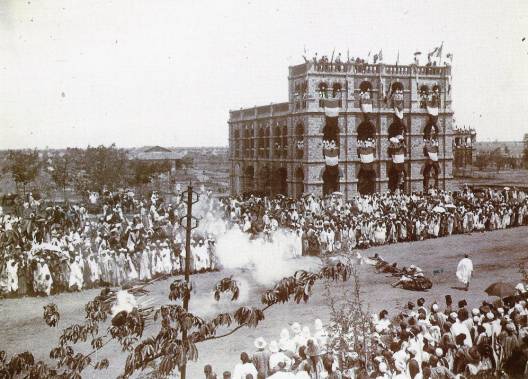
Quindi un edificio coloniale e due militari in una
giornata ventosa.

Per chiudere in bellezza l’immagine di questi
piccoli africani in fuga dall’obiettivo (Soudan 1892,1903), con quello in primo
piano così simpatico che sarebbe da strapazzare di baci.

Però da parte mia s’impone una critica: riguarda
l’inizio dell’articolo di Xavier Ricou, architetto responsabile di grandi progetti
infrastrutturali in Sènègal e che ha elaborato il Piano di Salvaguardia e e valorizzazione della delle città di Saint Louis del Sénègal nel
2005.
Si permette questo inizio (e capisco che
sull’Africa vivendoci per le sue realizzazioni ha più competenza reale sui
luoghi e sui costumi di me), però ve lo sottolineo: “La colonizzazione ‘que
vilain mot’! (Esprime con queste parole tutto il suo disprezzo, il suo orrore).
Ci rinvia alle pagine più nere della storia dei nostri paesi”.
Ecco mi permetto di dissentire in quanto mi sembra
un luogo comune. La colonizzazione non ha portato solo orrori anche civiltà ed
una riprova ne sono i barconi che dall’Africa muovono verso le nostre coste,
verso la nostra civiltà occidentale. Per motivi solo economici? Forse anche per
una vita in pace, migliore non solo per soldi (per chi riesce a guadagnarseli).
Più civile.
E’ un nostro
lascito
e non è da
non sottovalutare.
Giglio Reduzzi
Le Ong salvatrici

(Giglio
e Pietrangela nel loro recentissimo 59esimo di matrimonio)
Sono passati anni da
quando una brava persona come il card. Robert Sarah, arcivescovo senegalese,
rivelò al mondo come avveniva (e tuttora avviene) il trasferimento via gommone
dei migranti clandestini dalle coste africane a quelle italiane.
Anzi forse è proprio per
questo che, al compimento del suo 75° anno di età, è stato subito allontanato
dai prestigiosi incarichi che svolgeva in Curia, dato che il Vaticano è
notoriamente favorevole agli sbarchi no limits.
Ma cosa aveva detto di
tanto scandaloso il cardinale?
Niente: aveva spiegato
che nulla di quanto avviene sulle coste africane sfugge all’intelligenza “francese”
e, dunque europea.
Si sa quante persone si
accalcano su quelle coste in attesa di essere trasbordati; si sa da dove
vengono i gommoni; chi fornisce loro i falsi documenti e soprattutto si
conoscono luoghi e orari dell’incontro tra i gommoni e le navi ONG.
Infatti, ogni volta che
parte un barcone, lo scafista compone un certo numero di telefono e
questo, a sua volta, fornisce i dettagli alle navi ONG , in modo che queste
ultime possano andare dritte sul bersaglio senza perdersi in inutili ricerche.
Purtroppo non sempre gli
appuntamenti vanno a buon fine.
Ed allora sono guai seri.
Sì perché i gommoni, come
si sa, partono sovraccarichi e con una scorta di carburante insufficiente per
l’intero percorso, per cui se la nave non arriva in tempo all’appuntamento e
magari il mare è grosso …sono cavoli amari.
Questo è quanto ha detto
e scritto il card. Sarah, che sembrava una persona seria.
Lo ha scritto in un
libro, che però deve aver avuto una ben scarsa diffusione, perché le
giornaliste TV continuano a presentarci gli equipaggi delle navi ONG come
benemeriti autori di eroici salvataggi effettuati a seguito di autonome
ricerche.
E tutti credono a questa
versione, compresi alcuni ex ministri.
(Inserisco
ora un mio articolo sui genitori di Piero Gheddo, missionario nel mondo che
face davvero del bene alle popolazioni che incontrava a differenza delle Ong
che portano quasi sempre migranti “economici”)
I santi genitori del missionario
Piero Gheddo
Giovanni e Rosetta Gheddo, due santi genitori, esempio non
solo per i figli, ma per tutti, una santità quotidiana in una famiglia normale.
Tanti i laici beatificati e canonizzati da Giovanni Paolo II che in Novo millennio ineunte, ad inizio 2001,
ringrazia Dio per quel dono, ma già dal Concilio Vaticano II era venuto il
messaggio della chiamata per tutti alla santità.
“Quando pensiamo alla santità,
di solito pensiamo ad un prete, ad una suora con il velo, ad un vescovo o un
Papa, invece Rosetta e Giovanni ci ricordano che la vocazione alla santità è
universale”. Parole dell’omelia, tenuta da monsignor Enrico Masseroni,
Arcivescovo di Vercelli, nella cattedrale di Santa Maria Maggiore il 17 giugno
scorso. Era la cerimonia di chiusura del Processo informativo diocesano per la
Causa di Beatificazione di Rosetta Franzi e Giovanni Gheddo.
La Causa era stata postulata nel
2004 dalle Suore di clausura Redentoriste di Magliano Sabina (Rieti). Leggendo
in comunità il Testamento del capitano, libro che il figlio Piero,
missionario, aveva dedicato al padre disperso in Russia nella II guerra
mondiale, le suore si erano commosse e cominciarono a pregare davanti ad
un’immagine dei genitori del sacerdote chiedendo grazie per famiglie in
difficoltà,...grazie esaudite!
Il 2004 era il “Secondo anno internazionale della
famiglia”; nel Primo, 1994, la Diocesi di Roma aveva aperto il processo
canonico per le eroiche virtù dei coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi,
poi beatificati nel 2001; i primi, dai tempi dei santi Gioacchino e Anna,
mitici genitori della Madonna.
Quel libro ha dato frutti: l’antica testimonianza del
giovane sottotenente cui, nell’offensiva dei Russi sul Don nel dicembre 1942,
il Capitano diede l’opportunità di salvarsi scegliendo di restare lui con i
feriti intrasportabili, è stata confermata da un anziano di Udine, già militare
della Cosseria in Russia. Questi ha scritto a Gheddo indicando nel 17 dicembre
1942 la morte del padre: “Penso che
suo padre sia deceduto quella notte proprio a Krasnj e lì sepolto con gli
uomini che erano con lui”.
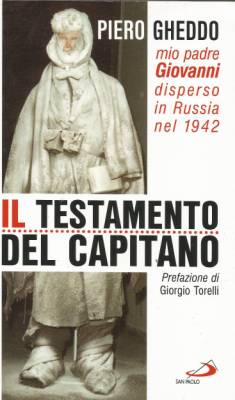
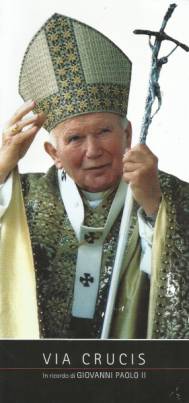
Il libro ha mosso le preghiere delle Suore, la venerazione
della gente e l’istruzione della Causa di Beatificazione. Ora più le persone
conoscono e pregano i due sposi, più crescono le testimonianze di “grazie
ricevute” e diventa più celere il cammino per la Beatificazione.
Far conoscere è l’obiettivo di “Lettera agli amici di Rosetta e Giovanni, sposi in cammino verso la
santità”, Bollettino quadrimestrale, (si può richiedere direttamente a
Piero Gheddo, PIME, via Monterosa 81, 20189 - Milano, 02-438201). Il n.3 del
settembre 2007, con l’omelia di monsignor Masseroni e il manifesto del Family
Day raccoglie lettere e testimonianze: toccante quella di una coppia “Giovani e
precari, ma il nostro amore è per sempre”.
Nel Bollettino una breve biografia dei Gheddo, membri
dell’Azione Cattolica, il cui matrimonio fu allietato da tre figli ma durò solo
sei anni fino alla morte per polmonite di Rosetta e dei gemellini che portava
in grembo. I due sposi pregavano assieme tutti i giorni, avevano consacrato a
Dio la prima notte di nozze e Giovanni, vedovo a 34 anni, continuò a ripetere
che “voleva troppo bene a Rosetta per risposarsi”.
Piero Gheddo ha
scritto di quando visitava gli infermi in un ospedale a Milano e i carcerati a
San Vittore: a contatto con persone segnate da “famiglie divise, conflittuali,
violente”, uscendo alla sera ringraziava il Signore per la famiglia in cui era
cresciuto e i suoi santi genitori. Ed era rimasto orfano a 5 anni di madre, a
13 del padre.
C’era una volta il futuro
-Un viaggio
nell’archeologia industriale della Liguria-
A cura di Giovanna Rosso e Massimo Minella

Questo libro molto interessante
è stato edito in cinquemila copie da Repubblica
che aveva proposto all’Università di Genova di partecipare ad un progetto
dedicato alle ricerche di Archeologia medievale condotte nella Regione ligure.
Gli archeologi medievisti – direttore tecnico Massimo Minella con tre giovani
ricercatori Giada Molinari, Andrea Pollastro, Enrico Cipollina del Dipartimento
di Antichità, Filosofia e Storia- hanno compiuto questo reportage <<Liguria medievale ritrovata>>
che ha riscosso molta attenzione di pubblico. Le puntate sono state raccolte in
questo libro edito da Genova University Press distribuito gratuitamente con il
quotidiano e tutte esaurite nel giro di poche ore.
Ora il
libro è disponibile in open access e chi lo vuole può averne una copia digitale
gratuita.
L’obiettivo è stato parlare ad
un ampio pubblico della sostenibile fragilità del patrimonio archeologico
regionale e proporre un itinerario a tappe, percorribile dal lettore attraverso
la Liguria da Levante a Ponente.
“La
cultura del lavoro di un tempo passato è lezione per il presente e possibile
chiave di lettura per il futuro… E’ la scoperta di una bellezza differente e
spesso inconsapevole: quella dell’industria, delle vecchie fabbriche e
attrezzature dimesse e riconvertite…Non solo, proprio in Liguria, l’industria
ha avviato trasformazioni profonde nel territorio e nella società fin dalla
metà dell’Ottocento”.
Un aspetto del libro che va
dritto al cuore è a conclusione di ognuno dei 17 capitoli una foto o cartolina
d’epoca con profumo di nostalgia del nostro passato recente ma anche come un
pass-partout verso un nuovo futuro: se l’industria ligure ha saputo far questo
può raggiungere nuovi traguardi nel futuro.
Per proiettare il lettore
dritto nell’argomento cito solo alcuni titoli di questo sguardo sul passato:
"Gli aerei Piaggio, prendere al volo un secolo di storia" (di Fabio
Caffarena); "Valpolcevera tra jutifici e villaggi operai" (di Lucia
Onesti); "Padron Titilin e le reti da pesca: che storie a Riva!” (di
Romina Condemi).
Per entrare più nel dettaglio
mi soffermo sul primo capitolo, curato da Giovanna Rosso Del Brenna,
riguardante la Darsena Municipale come la descrive il giornalista e
scrittore Alessandro Varaldo, articolo
pubblicato dall'Illustrazione italiana nel suo “Quaderno di Natale e Capodanno
del 1916/17”. Ci racconta che è una piccola città con gli otto quartieri che
ricordano le maggiori colonie genovesi: Galata, Scio, Metelino, Caffa, Tabarca,
Famagosta, Cembalo e Cembalo piccolo ed è attraversata da cinque vie: Marino
Boccanegra (architetto del Molo vecchio e della Darsena); Megollo Lercari
(mercante, che per vendicare un affronto, assaltò nel 1316 l’Impero di
Trebisonda, Jacopo da Levanto (ammiraglio di Luigi IX di Francia che condusse
il re alla Crociata), Paolo Imperiale e Francesco Vivaldi (benemeriti cittadini)...
E’ un tuffo nella storia e per
rianimare questo “magico” luogo, ricco di storia, lo si adibì a grandi
magazzini, detti Emporio. Già fin dal 1851 il Conte di Cavour aveva pensato di
adibirli a docks commerciali, sul modello di quelli di Londra, trasferendo
l’Arsenale a La Spezia. Il Comune
acquistò la Darsena nel 1870, ma
l’Emporio era entrato in crisi e a fine anni Settanta sembrava una cittadella
abbandonata.
Però l’architetto Giancarlo De
Carlo, incaricato dal Comune di redigere un progetto di ricupero del quartiere
di Prè v’inserì anche la Darsena. Nel
quartiere di Scio trovò posto la Facoltà di Economia dell'Università di Genova
(oggi Dipartimento di Economia, Scuola di Scienze Sociali) e nel 1990 il progetto di riconversione in
un complesso universitario, fu affidato allo studio dell’architetto Aldo Luigi
Rizzo e dell'ingegnere Aldo Pino. Quattro grandi aule sono state ottenute
"scavalcando" l'edificio mediante travi poggiate su un grande arcone
d’acciaio (qualcosa di analogo era avvenuto una decina d'anni prima con la
ristrutturazione dell'ex velodromo Carlini nel 1981).
Il secondo capitolo ha un
titolo “sacro”per così dire. E’ a cura di Silvia Scotto: "In carrozza alla
Guardia, santa tecnologia!"
Inizia con una verve per cui il
sacro si fa divertente: "In paradiso in carrozza? No, d'accordo; ma al
Santuario della Guardia, ci si va proprio in carrozza". E' il titolo de “Il Nuovo Cittadino",(il
giornale cattolico genovese con cent'anni di storia 1873/1974 su cui dovetti
fare la mia tesi per la scuola di specializzazione in Comunicazioni Sociali
all'Università cattolica e in fondo mi
appassionai anche per la storia di quegli anni d’intensa evoluzione e di
progresso) nel numero del 24 giugno 1934
per celebrare l’inaugurazione del secondo tronco della Guidovia che portava al
Santuario. Finalmente lo si poteva raggiungere non solo a piedi, a dorso di
mulo o col carro, bensì comodamente seduti su un mezzo di trasporto moderno.
E non si può vivere a Genova
senza essere profondamente devoti alla Madonna della Guardia, per cui ecco una
foto giovane di me con mio marito seduti sugli scalini del Santuario e dopo una
primaverile scarpinata a piedi per raggiungerlo (se no, che voto o buon
proposito sarebbe se non si va a piedi...)

La Guidovia, come spiegato
nell’articolo fu finanziata da Carlo Corazza, imprenditore e azionista delle
“Autovie Piacentine” che, malato di polmoni, era tornato in salute dopo essersi
recato al Santuario su suggerimento di alcuni marinai genovesi: è la prima ed
unica applicazione in Italia di un originale brevetto dell’ingegnere piacentino
Alberto laviosa (1877-1959): la “ruota con cerchione in gomma e bordino
metallico” che scorrendo sulle apposite rotaie assicurava un’alta aderenza
anche su pendenze elevate come appunto è la salita alla Guardia. La Guidovia
rimase attiva per 38 anni anche in tempo di guerra, permettendo lo sfollamento
quotidiano dalla città. Si giungeva in 45 minuti al Santuario con varie fermate
intermedie. L’impianto cadde in disuso con il diffondersi della motorizzazione
privata e delle autocorriere e venne chiuso il primo novembre 1967.
La maggior parte del materiale
rotabile fu venduto “a peso ferro”, ma alcune motrici sono state conservate.
La n. 1 prima trasferita a
Piacenza presso la sede della società di Laviosa, le “Autoguidovie Italiane”,
ancor oggi è visibile presso il Museo dei Trasporti di Villa Fantasia sul Lago
Maggiore; la n. 7 ceduta al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano ed
esposta all’aperto è stata distrutta dalla intemperie, le altre sono state
vendute a privati e trasformate dagli usi più diversi: la n.11 a Travo in
Valtrebbia è diventata
uno “studio d’artista”, la n.4
un guardaroba per discoteca…

Non solo, ogni anno arriva
puntuale il tributo del Presepe di Geo, quando il faro della Guidovia - grazie
al modellino realizzato da Bruno Pedemonte- illumina la salita del Monte
Figogna su cui sorge il Santuario nella notte di Natale.
E come non concludere per far
meglio ancora capire al lettore con questa splendida cartolina di un Caproni
della Piaggio?
Una vera
eccellenza ligure ed italiana
per immaginare altri
splendidi traguardi.
Luigi Pasquali e
Mario Zerbarini
Vocabolario del dialetto
bobbiese
Luigi Pasquali, uno degli
autori di questa nuova impresa arricchita (dato che già era uscita una prima
edizione del 1907) scrive: “È stato un lavoro enorme ti basti sapere che ci
sono più di 11.800 voci in quello dialetto – italiano e 10.800 voci su quello
italiano – dialetto. Tutto il vocabolario contiene 207.786 parole. Quello in dialetto
– Bobbiese contiene 11.400 voci ca.
Ne stamperemo solo 50
copie per le biblioteche le scuole di Bobbio e le Università del Nord in quanto
verrà messo poi su Internèt e a disposizione di tutti gli studiosi. Sarà il
regalo alla cultura bobbiese di Gigi e Mario. Sarà il nostro regalo per la cultura bobbiese anni di studi e
di ricerche. La mia soddisfazione è di aver constatato che ogni dialetto è
ricco di storia e saperli leggere ti raccontano tante cose; ti spiegano quali
popoli sono passati sul territorio, la toponomastica del luogo, come si
ragionava raccogliendo i tanti modi di dire e i tanti proverbi (tutte pillole
di saggezza). Tutto questo
è nel nostro vocabolario”.
Non solo Luigi ci tiene a precisare che niente è più sbagliato che
indicare come “volgare” un dialetto come quello bobbiese. Infatti tutte le
famiglie nobili delle cittadina parlavano il dialetto con piacere e lo suavano
come un biglietto da visita per indicare l’appartenenza ad una comunità, ricca
di storia e culturalmente avanzata. Nei larghi saloni delle case nobiliari si
svolgevano incontri per ritrovi culturali, più o meno di svago,divertimento con
balli recite dove il dialetto bobbiese si sviluppava in una modalità raffinata
e signorile”.
Mario Zerbarini, l’altro coautore, scrive a sua volta: “Quando si para
di dialetti non viene sempre facile spiegare tutte le sfumature che in essi si
rilevano. più nel caso della nostra parlata locale che ancora non abbiamo ben
compreso, pur nel novero di una miriade di dialetti italiani, mella sua
derivazione e natura, per cui personalmente lo definirei, anche se discutibile
, con l’impronta di ‘vernacolo ibrido’.
Se mi si chiedesse perché, non potrei che rispondere citando i sinonimi
che seguono: ‘suratasguratin’, vutra’… solo per citarne due scelti a caso fra
oltre mille vocaboli, dei quali pur usati comunemente (‘pipistrello’, ‘vieni
avanti’) non trovano radici in nessuna altra parlata in vernacolo né tanto meno
se si fa ricorso al latino.
Nel ‘liminare’ sottoscritto al prof. Flavio Nuvolone per la
presentazione del primo dizionario bobbiese, il Professore scrive:”…ci è parso
trapelare qua e là nelle parole degli autori, una certa malinconia; infatti –
scorre inesorabilmente il tempo-, la popolazione si trasferisce, i nuovi
arrivati hanno altre parlate, l’italiano diventa lingua quotidiana dei giovani,
che azzardano prestiti arditi quando allora si rivolgono al dialetto. Ciò sta
capitando nelle lingue occidentali rispetto all’inglese, immaginarsi al
dialetto di un paese, fosse anche la Città di Bobbio…” E’ questa comunque la
situazione di un organismo vivente e che c’è di più vivo della parola?
Concluderei perciò col dire, che il ‘dialetto bobbiese, regole della
grammatica a parte studiate ed analizzate più volte, ognuno lo interpreterà e
scriverà come meglio lo avrà inteso facendo ricorso alle molte utili
spiegazioni date a tanti simboli, segni o caratteri grafici non perdendo mai la
pazienza di analizzare profondamente tutti gli aspetti”.
Gigi
Pasquali – Mario Zerbarini
NUOVO
VOCABOLARIO BOBBIESE

La nuova copertina, su sfondo verde come quella della
prima edizione che qui pure riporto, però con la foto di un gruppo di amici
bobbiesi durante una gita.
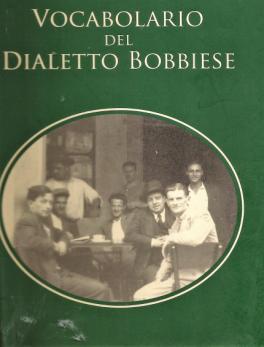
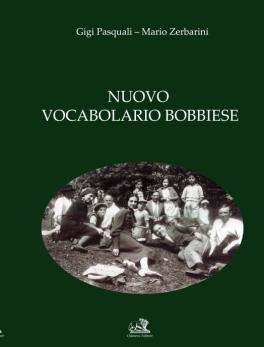
(Dal
Vocabolario)
RINGRAZIAMENTI (indispensabile ricordare questa pagina per
far capire quante persone si sono appassionate all’opera dando il contributo
della loro competenza).
C
on la pubblicazione del Nuovo Vocabolario bobbiese, pensiamo
di aver por-tato a termine quella ricerca di vocaboli dialettali iniziata tanti
anni fa e che avevamo voluto al fine di fermare nel tempo la parlata dei nostri
padri, in modo che il loro linguaggio, il loro modo di essere, la loro cultura
non venissero dimenticati.
Un pensiero va al prof. Enrico
Mandelli, a riconoscimento dell’amore che ha sem-pre dimostrato verso la Città
di Bobbio: uomo di cultura, difensore dell’arte e della conoscenza del nostro
passato, con il suo incoraggiamento e insegnamento ci aveva consentito di
portare a termine nel 2007 il primo Vocabolario
del dialetto bobbiese.
Non possiamo nemmeno dimenticare
tutti coloro che ci avevano aiutato nelle no-stre ricerche, fornendoci vocaboli
e suggerimenti: ricordiamo Anna Manfredi e Francesco Bellocchio e ancor più
Andreina Bellocchio e Alfredo (Ugo) Bellocchio, che sono venuti a mancare.
Anche al prof. Angelo Stella e
alla dott. Monica Tassi dell’Istituto di Storia della Lingua Italiana
dell’Università degli Studi di Pavia vanno il nostro ricordo e la no-stra
gratitudine: il loro prezioso aiuto ci ha permesso di effettuare un lavoro
equili-brato e tecnicamente alla pari dei più qualificati dizionari dialettali.
Un grazie all’Associazione Amici
di San Colombano che aveva sostenuto l’onere finanziario della prima edizione
dell’opera, che resterà comunque nel tempo e potrà essere di supporto a futuri
e possibili studi del nostro dialetto insieme a questa nuo-va edizione, che
integra ampiamente la ricerca dei vocaboli.
Ringraziamo Patrizia Germani e
Andrea Pasquali per la collaborazione.
Un particolare ringraziamento a
Lorenzo Boccaccia, che, con il suo talento profes-sionale, ha messo a
disposizione il supporto tecnico per la pubblicazione online di questa seconda
edizione.
Siamo grati anche ad Arianna
Ghilardotti e Roberta Panni per l’editing e l’impaginazione.
Gli
Autori
INTRODUZIONE
A
ffrontare un’impresa di ampio
respiro come la compilazione di un vocabo-lario ci ha portato a dover superare
diverse difficoltà, tra cui la necessità di decidere come rappresentare i suoni
del dialetto e come raccogliere tutte le parole da inserire. L’incertezza era
capire se bisognasse indicare solo la terminolo-gia più remota oppure,
indistintamente, tutti i vocaboli della parlata corrente.
In questi ultimi decenni
l’evoluzione dell’italiano, che ha visto nascere tanti nuovi vocaboli, ha
portato all’esigenza di esprimere anche nel dialetto bobbiese le nuove parole
derivate da avvenimenti e scoperte tecnologiche propri di questo periodo
storico. La rappresentazione dei suoni è stata perciò affidata al prof. Angelo
Stella, docente di storia della lingua italiana dell’Università di Pavia e
illustre membro dell’Accademia della Crusca. Egli, trovando interessante il
nostro lavoro, ha affiancato agli autori la dott. Monica Tassi, affinché il
vocabolario potesse avere tutti i requisiti necessari per trovare posto tra i
tanti studi già esistenti sulle parlate locali e consegnare, così,
definitivamente il dialetto bobbiese alle generazioni future.
L’inserimento di termini d’uso
attinenti a tematiche più attuali è stato possibile ascoltando ed interrogando
le persone che ancora oggi parlano il dialetto.
In ogni caso, va evidenziato che
anche il bobbiese, come ogni parlata vernacolare, non può più dirsi
“autentico”, sia per l’influenza esercitata dagli abitanti scesi dai paesi
limitrofi, sia per gli interventi della popolazione indigena stessa, che,
essen-dosi recata in altre città per necessità di lavoro, ha introdotto nuove
terminologie.
***
Il presente lavoro, che riprende e
approfondisce la ricerca a suo tempo svolta dal Prof. Enrico Mandelli nel
volume Il dialetto bobbiese,
sviluppa il vocabolario qua-le strumento di futuri studi sulla nostra parlata.
Occorre precisare che, se altri
dialetti hanno avuto la fortuna di usufruire di insigni maestri che con le loro
opere e studi hanno fissato canoni e regole, non altrettanto si può dire della
parlata dialettale bobbiese. Anche attingendo ai pochi scritti a noi pervenuti,
la mancanza di un consimile patrimonio di base non consente, quindi, di
comprendere appieno la peculiare evoluzione di questo dialetto nel tempo.
Bobbio, pur nel suo isolamento, ha
modificato nei secoli l’idioma parlato; tale cambiamento si è maggiormente
accentuato dopo gli anni Cinquanta. Con la fine della Seconda guerra mondiale e
l’avvento di una civiltà industrializzata, la città, defilata dalle grandi vie
di comunicazione, ha subito il più massiccio spopolamen-to; intere generazioni
di giovani sono state costrette a trasferirsi nei grandi centri alla ricerca di
un posto di lavoro.
Gli
artigiani, i negozianti, i giornalieri venivano man mano sostituiti dagli
abitanti del contado che, approdando a Bobbio, vi portavano anche il loro
linguaggio. Di conseguenza il dialetto bobbiese si è velocemente modificato,
subendo l’influsso di chi proveniva dall’hinterland cittadino con inflessioni
linguistiche diverse e del tut-to nuove.
Pochi conoscono ancora l’antica
parlata dei nostri avi; i giovani parlano ormai l’italiano e gli anziani si
adeguano, cancellando così specifici modi di dire, costumi e tradizioni.
Il presente lavoro, pertanto,
vuole rendere le nuove generazioni consapevoli del passato storico su cui si
fondano le conoscenze pervenute fino ai giorni nostri, gra-zie a quel gustoso e
colorito linguaggio la cui identità è senza ombra di dubbio da rivisitare in
tutta la sua interezza.
***
Sono già trascorsi quindici anni
da quando abbiamo scritto questa introduzione e pubblicato la prima edizione
del vocabolario; in tutto questo periodo le nostre ri-cerche non si sono mai
fermate. Abbiamo trovato vocaboli nuovi usando un meto-do semplice e divertente,
anche se impegnativo: ci siamo messi a scrivere nel no-stro dialetto brani di
prosa, poesie, ricette, non tralasciando mai di ascoltare coloro che ancora lo
parlano. Questo continuo approfondimento è nato dalla consapevo-lezza che ci
sono sempre meno giovani che si esprimono nella parlata dei nostri avi e dalla
necessità di arricchire sempre di più il nostro frasario dialettale.
Inoltre abbiamo ritenuto opportuno
mettere online il vocabolario revisionato e ar-ricchito, a disposizione di
tutti i bobbiesi e degli appassionati dialettologi italiani, perché il nostro
dialetto non venga dimenticato e serva come base per nuovi studi.
IL
DIALETTO BOBBIESE
Il dialetto bobbiese appartiene ai
dialetti dell’Italia settentrionale, conosciuti col nome di gallo-italici, che
comprendono i gruppi ligure, lombardo, piemontese e emiliano-romagnolo. Come
tutti i dialetti italiani, il bobbiese deriva dallo sviluppo e dalla
trasformazione del latino volgare, arricchito nel tempo dall’apporto
lingui-stico dei popoli che si sono avvicendati sul nostro territorio.
Il sermo vulgaris aveva già le sue radici nel sostrato celtico, la
lingua parlata degli abitanti del luogo prima dell’arrivo dei Romani, ossia i
Galli, una popolazione cel-tica proveniente dai territori dell’attuale Francia.
L’influenza celtica si nota,
soprattutto nella fonetica delle parole: ad esempio, nel suono vocalico «ö»,
che equivale al suono «eu» francese, nella «ü» dialettale, cor-rispondente alla
«u» francese, e inoltre nei diversi suoni nasali. Dalla parola latina durum deriva dür, da ostium, üs, da folia, föia, da hinc hodie, incö, per citare solo alcuni esempi.
Meno importante fu invece
l’influsso celtico sul lessico. Ricordiamo alcuni voca-boli: brenta (recipiente di legno per il
vino), mascarpòn (mascarpone), magiüstar (fragole), brich (punta rocciosa), sgürè (raschiare, lucidare), bgnòn (gonfiore cuta-neo), garòn (coscia).
La valle del Trebbia, in
particolare Piacenza, abitata già al tempo delle popolazioni terramaricole, fu
in seguito dominata da Liguri, Etruschi e Galli Boi, per passare
successivamente ai Romani (dal 218 a.C.). La loro lingua ebbe il sopravvento e
si impose su quella delle popolazioni locali. Mentre le persone colte parlavano
il lati-no, il popolo adottò il sermo
vulgaris, che in seguito, per evoluzione graduale, dette origine ai vari
dialetti locali.
Con la caduta
dell’Impero romano, l’Italia subì l’invasione di vari popoli. Verso il 450
d.C., i Goti, gli Unni, i Burgundi e diverse altre tribù barbariche di origine
germanica scesero alla conquista della Lombardia e dei territori limitrofi; tra
que-ste, quelle che ebbero più peso per la nostra storia furono i Longobardi.
Era l’anno 572 d.C. Ai Longobardi seguirono i Franchi, altra popolazione di
origine germani-ca, che scesero in Italia al seguito di Carlo Magno nel 774
d.C. Tutte queste popo-lazioni non imposero però la propria lingua, come
avevano invece fatto i Romani, ma si impossessarono di quella delle popolazioni
locali, portandovi ovviamente nuove terminologie, come del resto avviene ancora
oggi quando due gruppi etnici di idioma diverso si incontrano e sono costretti
a convivere.
Dopo questa
introduzione dal Vocabolario stesso,
per far meglio capire riporto la prima parola alla lettera A e l’ultima alla Z che contiene una sessantina di
voci.
A
a prep.
a. Pensè ad l’ètar,
pensare ad altro; andè a Lisàndria,
andare ad Alessandria; andè
a ra céza, andare alla chiesa; andè
ar Pènaz andare al Penice; dìl a u pupè, dillo al
papà; l’espressione «diglielo alla mamma», onde e-vitare l’accostamento
omofonico tra l’articolo e la preposizione, non è dìgōl a a màma,
ma «diglielo con la mamma» digōl cón a màma; dàgōl a i òm,
daglielo agli uomini; dàgōl a e dòn, daglielo alle donne. Può
assumere la for-ma eufonica ad davanti a parola che comincia con vocale.
a pron.
atono sogg. A vègn, io vengo; a vègna, ella viene; a
gnùma, noi veniamo; a gnìv, voi venite.
a art.det.femminile.
A mama, la mamma.
abaìn s.m. (l’abaìn) abbaino
Z
zabaglione s.m. (ar) sambaiòn.
zuppiera s.f. (a) grilèta, süpéra
(in mezzo alla
sessantina di voci c’è anche la definizione di strega o cartomante)
zingara s.f.
(a) séngra; (a) stròluga, che legge la mano.
zingaro s.m. (u) singàr, (u) stròlugh.
Tutto questo prova
la vivacità del dialetto, superiore a quella della lingua italiana.
Vorrei però
ricordare dei due meritevoli autori, Luigi e Mario, anche altre loro fatiche
Luigi è autore de “ilnotiziariobobbiese.net” da cui
riporto una foto antica di Bobbio e l’altra - molto suggestiva - per come
appare vista dal Ponte Gobbo
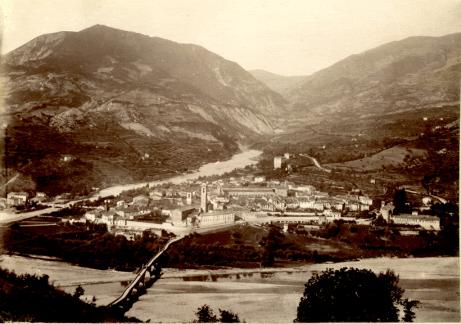

Mario è autore di altre pubblicazioni tra cui quella
dedicata a Giuseppe Colombetti e ora di un libro su Margaret Stokes Sei mesi in Appennino (Edizioni L'Erta) -Viaggio di una scrittrice irlandese sul
finire dell’Ottocento sulle tracce di San Colombano.
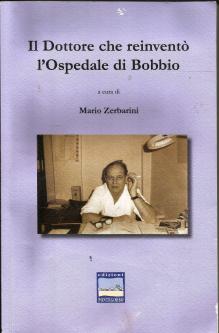
Mario
nel suo scritto ha ricordato il prof. Flavio Nuvolone, nato in Val Trebbia e
alla quale ha dedicato i volumi di Archivum Bobiense, editi da lui e con
l’apporto di studiosi da tutto il mondo. Ha continuato così l’opera iniziata
nel 1979 da monsignor Michele Tosi. La morte prematura di Nuvolone, docente a Friburgo, è stata ricordata con
queste parole da un giornale svizzero: “colto, generoso, disponibile” e lascia
in chi l’ha conosciuto un indelebile ricordo di uomo probo.
Mi
piace concludere con la dolce dedica del Vocabolario:
Alla
Città di Bobbio
Nella nostra
parlata,
la storia dei nostri
padri
e della nostra civiltà
Per maggior informazione sugli autori allego la
segnalazione di altre loro opere: Luigi nel 2003 pubblica Cento anni di storia
bobbiese, nel 2005 con Paolo Mozzi il testo Unione Sportiva Bobbiese- 90 anni
di storia e nel 2013 Unione Sportiva… a 100 anni; nel 2009 pubblica Grammatica
Bobbiese.
Mario entra
nel Consiglio d’Amministrazione dell’Ospedale di Bobbio. E’ tra i fondatori
della Famiglia Bubièisa e con Luigi ne cura la sezione Arte e Cultura.
Nel 1995 insieme riescono a pubblicare Il dialetto
bobbiese, libro del prof. Enrico Mandelli. Mario scrive ed interpreta con la
figlia Enrica una commedia di successo “S’as
pudissa mètga ona pèsa” che fu
rappresentata una volta sola nel settembre 1978 e fu registrata da Telelibertà:
basata su conflitti tra generazioni e vi si intravedevano quelli che sarebbero
diventati poi “i paninari” degli anni Ottanta. Mario pubblica anche alcuni libretti di poesie. Qui inserisco
l’articolo dello storico giornalista di Bobbio, Gino Macellari scritto sulla
commedia.
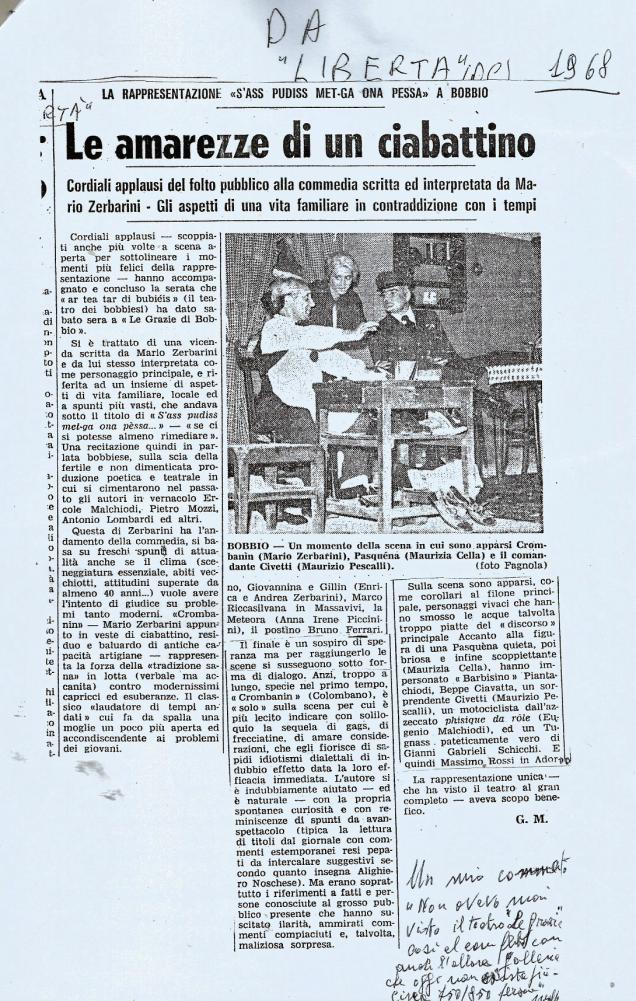
Ma è una caratteristica degli autori bobbiesi forse
per quell’aria di antica cultura che hanno respirato a Bobbio di non star mai
fermi.
Ecco quindi l’ultima intrapresa di Mario: ha
pubblicato con la supervisione dell'art director Eliana Ferioli (il cui nome si
lega alla splendida rivista Gardenia) Sei
mesi in Appennino - Sulle tracce di San Colombano: il viaggio di una scrittrice
irlandese sul finire dell’Ottocento.
La scrittrice è Margaret Stokes e non ho mai letto
tra i tanti libri su Bobbio, pubblicati con belle foto, uno così interessante
anche per il fatto che Margaret era già allora un'abile fotografa ed ha
illustrato il suo racconto con foto d’epoca (come si chiamerebbero oggi)
davvero suggestive. Ci danno luoghi e paesaggi dell'anima come questa
rirpoduzione dello storico Albergo Barone dove soggiornai con i miei genitori
da bimba.
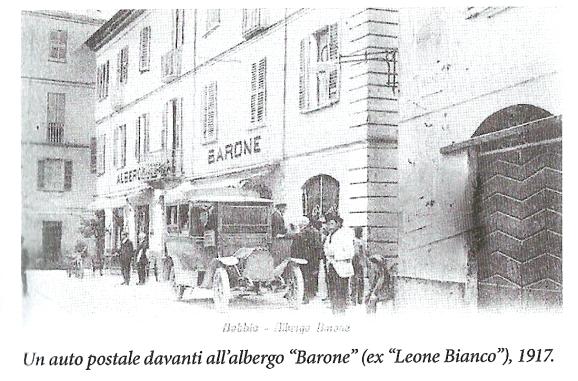
Interessantissimo questo libretto, pubblicato da Le
Edizioni L’Erta.
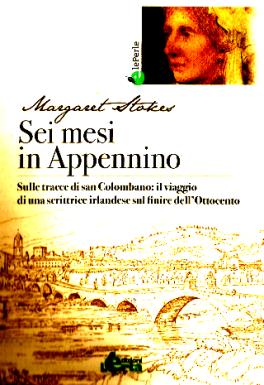
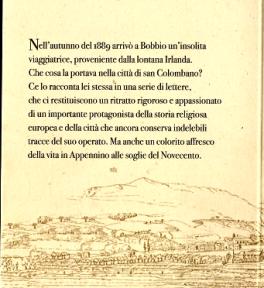
Solo per citarne uno spunto, quando la Stokes arriva
a Piacenza, dove pernotta prima di proseguire per Bobbio, visita la città e si
meraviglia che non vi sia un’Accademia
delle Belle Arti e non si possa avere foto dei pregevoli affreschi delle chiese
che hanno un’architettura molto interessante. Ci dice che il Duomo, iniziato
nel 1133, è romanico lombardo. Si meraviglia pure di quanto siano vuote le chiese,
anche se in passato Piacenza era stata chiamata “la fedele”.
Sorprendente quanto racconta Mario di questo
documento che ha fatto diventare libro: è rimasto nei cassetti degli Archivi
Storici Bobiensi (A.S.B.)per 132 anni,
solo perché scritto in lingua inglese. Mario tra i cinque e sette anni apprese
dalla nonna paterna Carolina la storia di questo evento che lei da ragazza
aveva personalmente vissuto. Accadde poi che Enrica, figlia di Mario e laureata
in Lettere frequentando gli A.S.B., ebbe in dono dallo scomparso don Angiolino
Bulla una copia tradotta da Santino Poggi che era stato professore del padre e
che conosceva ben otto lingue tra cui l’aramaico. Così Mario si è sentito in
dovere di rendere giustizia sia al suo antico professore, sia alla nonna che
per prima lo aveva introdotto a questa storia vera e di straordinaria cultura e
ne ha fatto un “prezioso” libro.
Per concludere allego anche il mio articolo sul
Vocabolario comparso su La Trebbia
giovedì 3 giugno 2021.