Questa pagina s’intitola “i fiori” perché ad
ogni Autore è accostato un fiore che ricorda il suo libro.
INDICE
1)
Claudio Papini, L’attualismo,
De Ferrari,2023
2)
Claudio Papini,
Elementi di filosofia della scienza, De Ferrari, 2024
3)
Enrico Halupca, Batiscafo Trieste, Presentazione
4)
Roberto Orlando e
Stefano Termanini Genova infinita, Ed. Stefano Termanini, 2024
5)
Roberto Vecchioni, Tra
il silenzio e il tuono, Einaudi,2024
L’ATTUALISM0 e ELEMENTI
Di Filosofia della Scienza
di
CLAUDIO PAPINI

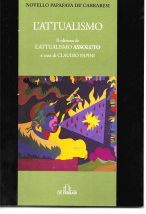
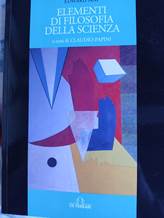
Per questi libri del
prof. Claudio Papini ho pensato al papavero perché con la sua fiamma indica che
dobbiamo concentrarci su quanto è attuale e per capire l’attualità è
indispensabile saper di filosofia.
Sarà la recensione ad
indicare in breve cosa il Professore intenda per Attualismo e cosa nel suo
libro successivo. Perché mi succede di pensare e ripensare come recensire in
modo appropriato dato che non frequento più la filosofia dai tempi del liceo e
intanto che penso il Professore riesce a mandare in stampa un altro dei suoi
preziosi libri.
Non solo il primo
Autore che ci presenta in Attualismo si chiama Papafia
quindi il nome ha una certa assonanza con papavero e con la sua fiamma.
Prof.
Claudio Papini
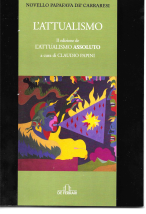

“La
comprensione della filosofia richiede in precedenza cognizioni, elementari di
teologia e fisica, storia e biologia, estetica e letteratura, tutto un
materiale che via via vien macinato al mulino del filosofo”.
Queste parole inserite in un libro del Prof. Claudio Papini
indicano come sia arduo per chi non ha più seguito studi di filosofia dopo il
liceo recensire i suoi libri pur se scritti con cartesiana chiarezza, però ne
do ora alcune indicazioni.
L’Attualismo
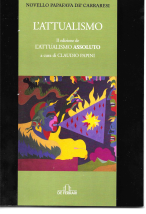
E’ del 2023: nasce come i precedenti testi dalla collaborazione di
Claudio Papini con l’Editore Gianfranco De Ferrari per cui è diventato
direttore della collana “Amici del Libero Pensiero”. De Ferrari nato nel 1937,
fondò l’omonima casa Editrice nel 1985 poi diventata anche Fondazione
culturale onlus con una produzione annuale di 80 titoli ed un catalogo di circa
1000 volumi pubblicati. Nel 2006 con la Fondazione Sorriso Francescano avviò un’attività parallela
rivolta al sociale con la sigla De Ferrari & Devega – Edizioni
musicali. La Fondazione custodisce l’Archivio di Edward Neil già musicologo di fama
internazionale.
La collaborazione di Claudio Papini con De Ferrari inizia nel
1968 con la pubblicazione di “Marx” di Ernst Ingmar Bergman, il Professore ha una lunga esperienza didattica nei
Licei genovesi, sia il Colombo che il D’Oria. Per De Ferrari la sua ultimissima
opera è il commento a Pietro
Nurra, Genova nel Risorgimento (pensiero e Azione) e dai suoi libri c’è sempre
molto da imparare.
Vengo in tema a L’Attualismo che ho citato nella pagina del mio
sito “4 fiori” associandolo al papavero anche perché l’introduzione inizia
raccontandoci del liberale Novello
Papafava de’ Carraresi, presidente RAI dal 1961 al’64. Questi nel ‘1922 scriveva che
la guerra del 15/18 era stata la fine dell’umanesimo, in quanto aveva sconfitto
la civiltà nata dal Rinascimento, umanistica e illuministica. La Chiesa
cattolica “depositaria di una morale assoluta ed erede della tradizione
aristotelica-tomistica ne era un’avversaria irriducibile”.
Il pregio della scrittura del Professore si rivela in aneddoti o
in questo incipit nel ricordare alcune canzoni che divennero cavalli di
battaglia di Achille
Togliani nel 1920 ma mescolandole insieme ci colpisce con “nel 1919
vestita di voile e di chiffon… riparammo per la pioggia in un portone”. E il
colpo di genio o il sottile umorismo è il riunirle anche a “Signorinella
pallida, dolce dirimpettaia del quinto piano”. Si crea un’atmosfera romantica
che rende sopportabile il ricordo della guerra. Gli avvenimenti essenziali di
questa e di ciò che ne provocò lo scoppio sono indagati con assoluto rigore.
Tutto questo per portarci a riflettere sul fatto che realismo e idealismo sono accomunati dalla realtà che diviene. E così siamo condotti come
per mano a capire che l’attualismo “la legge dell’uomo” ci dice “pensa” ed è
rivolta a ciascuno di noi perché nel “nosce te ipsum” consiste la suprema legge
etica dell’uomo.
Non solo: anche per la tecnica la suprema legge etica è
“pensare”, conoscere se stessi come volontà di
potenza. L’evidenza del divenire può essere assimilata all’esperienza che si
traduce nell’atto del pensiero e questo è trascendentale. Tale evidenza porta
sulle spalle – come conclude il Prof. l’intera storia del mondo. Bisogna però
arrivare a “pagina 38” per capire bene il titolo del libro, perché
richiamandosi a Gentile il Prof. ci spiega che la
posizione estrema dell’idealismo può anche essere chiamata idealismo attuale o
attualismo.
Da notare la bella cover di Nicola Ottria, in cui Giovanni Keplero difende la madre dall’accusa di stregoneria, realizzata
a Genova nel 1970. E qui si scopre anche un’altra freccia all’arco di Papini: è
un appassionato ed intenditore d’Arte e Ottria è un artista nato a Genova nel
1943 le cui opere sono passate in asta ben nove volte. Ne allego l’immagine
perché sembra di un antico profeta.
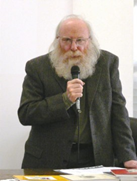
Elementi di filosofia della scienza

Penultimo testo di Papini ha di nuovo la cover di Ottria.
Ma
prima di entrare
nel merito del testo mi soffermo un attimo su Edward May, l’Autore cui Papini dedica
questo libro e traggo alcuni spunti del retro della cover che parla di
lui. Nato Nel 1905 a Mainz e morto nel
1956 a Berlino, è stato un biologo tedesco, teorico della scienza
(epistemologo) e filosofo della natura, interessato anche alla zoologia per cui
ottenne il dottorato di ricerca presso l’Università di Francoforte. Nel 1942
lavorò Presso l’Università di Monaco e non fu arruolato dalla Wehrmacht causa
la sua sofferenza cronica ad un orecchio. Però riuscì a servire il suo Paese
nella Seconda guerra mondiale perché nominato capo del Dipartimento di
Entomologia per la ricerca scientifica della Difesa. Si occupò delle cause del
proliferare dei topi nelle fogne dei campi di concentramento e sviluppò nuovi
antidoti contro l’infestazione di zanzare specie quelle che trasmettevano la
malaria. Partecipò a progetti di guerra biologica fu imprigionato nel 1945 ma
rilasciato perché il suo lavoro scientifico era stato ritenuto valido solo
nell’intento di combattere gli insetti e si era rifiutato di fare esperimenti
sugli esseri umani. Nel 1947 fu testimone ai processi di Norimberga. Ma
l’aspetto di questo eccezionale ricercatore così come presentato da Papini, l’aspetto
che più mi ha fatto entrare in sintonia è stato il suo aver condotto ad inizio
carriera ricerche sulle libellule presso il Museo Seckenberg.
Penso
che in natura le libellule siano l’essere più ricco di grazia del creato più
ancora delle farfalle perché la loro presenza è anche accompagnata dal suono
delle ali. E’ come se suonassero per noi.
Ricordo
personale:
ritorno
con la memoria a quei piccoli libri che mio padre mi leggeva da bimba e tra
questi c’’era la “Signora
Brucatutto” che parlava appunto della
trasformazione e nascita di una leggiadra libellula. E - sorpresa – andando su Internet
ho trovato che quel libricino fu edito per la prima volta nel 1940 ed oggi è
diventato oggetto di antiquariato al punto che su un sito viene venduto a 250
dollari. Un libro per bimbi di quel valore!
Allego
l’immagine nata dall’immaginazione degli illustratori Monti e Iolanda Colombini
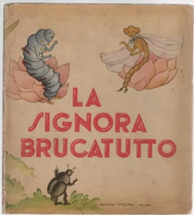
Grande merito di Papini è riportare alla
memoria personaggi del passato dalle vite interessanti e che ancora ci possono
insegnare.
La prima edizione è del 1951 e nel 1961 è
approdato a Genova con il titolo Forze geometriche, testo curato
da Papini per De Ferrari.
Il testo è riccco di spunti o frasi su cui
riflettere, come “Nessuna constazione
sperimentale è in grado d’imporre una data geometria”, opp. “Il principio del
pensiero non è in nessun modo un dato, ma un’origine”, o ancora:”La libertà di
scelta non vale solo per la geometria, anzi si può far valere in tutti i
problemi fondamentali della ricerca scientifica”, o riguardo ‘L’induzione’ che
si può intendere come salita dal particolare all’universale mentre la deduzione
sarebbe la discesa dall’universale al particolare: però le cose sono in
realtà straordinariamente sviluppate e
complesse”.
Tanto su cui riflettere e la conclusione è che non si può concepire una rappresentazione
chiusa del mondo.
In conclusione:
“Filosofare significa lavorare intorno a dei
problemi, precisamente quelli che sono riservati al pensiero puro e le scienze
particolari con i loro strumenti e metodi non possono afferrarli”.
BATISCAFO TRIESTE
di ENRICO HALUPCA


L’11 maggio ore 11
allo Yacht Club Adriatico Enrico Halupca ha
presentato il suo libro “Il Trieste” nell’incontro intitolato L’impresa del
Batiscafo Trieste. La casa editrice Italo Svevo di Trieste sarà presente al
Festival MareinFvg proprio con questo testo.
Per ricordare Halupca ho scelto la genziana fiore dei monti che ha il
colore del mare perché non c’è triestino che non abbia fatto escursioni in
Carso e che non sia amante del mare.
Ad Halupca
devo gratitudine perché quando pubblicai con Lint
(editrice triestina) il libro tratto dalle lettere dei miei genitori in tempo
di guerra e tra i dieci finalisti al Premio di Pieve di Santo Stefano (AR, Toscana) fondato
da Valerio Tutino e che raccoglie le memorie di tanti italiani mi guidò nella
pubblicazione per la Lint. Anzi una volta con grande
garbo mi fece presente che ero incorsa in un errore storico.
Quanto alla storia del
Batiscafo il 23 gennaio 1960 con a bordo Jacques Piccard (che lo aveva
progettato) raggiunse la profondità record di immersione (11mila metri sotto il
livello del mare) nell’abisso Challenger nella fossa delle Marianne.
Il batiscafo è esposto
al Museo navale di Washington.
GENOVA INFINITA
ROBERTO ORLANDO e STEFANO TERMANINI

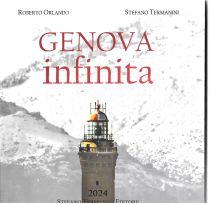
Un libro raffinato che
richiede un fiore raffinato e queta orchidea mi è stata regalata il gennaio
scorso da Daniela Massocco e Andrea Guglielmino miei
allievi nella prima liceo classico del Doria (anno 1972/73).
Per questo testo mi
appoggio alle parole del retro della cover dei due autori: “abbiamo camminato
per la città. Se la sua bellezza è tanto esposta quanto nascosta, noi, ci siamo
detti, faremo la nostra parte per portarla tutta in luce. Raccontare deve essere
questo: mettere in luce. Con le immagini e con le
parole.
Allego alcune foto dal
libro che sono di Orlando
mentre i testi sono di
Termanini:






Elenco le immagini:
1)Galleria dorata di Palazzo Tobia Pallavicini; 2) il matitone; 3) Nervi passeggiata Anita Garibaldi, 4) la
cremagliera di Granarolo; il cibo è cultura: la Panissa; 5) Staglieno: Tomba
Oneto, angelo di Monteverde
TRA IL SILENZIO E IL TUONO
ROBERTO VECCHIONI

E’ la passiflora il fiore che si addice alla vita piena di successi ma anche
segnata dal dolore del geniale cantautore, poeta, scrittore di libri
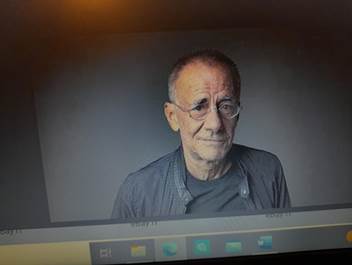

Nel
programma televisivo “In altre parole”
di Massimo Gramellini, il “cantaprofessore” Vecchioni
come lo ha definito l’intervistatore Massimo ha definito il suo libro
<<Tra il silenzio e il tuono>> come un dialogo tra il suo corpo di
ragazzo in crescita con la sua anima, rappresentata dal nonno che non gli
risponde mai. Però gli parla e lo educa attraverso le persone che ha conosciuto
e ciò che la vita gli ha insegnato.
Ho
pensato di dividere il mio commento in
due parti: quella che riguarda il ragazzino in crescita e l’altra con le
esperienze del nonno.
Parte
prima.
Vecchioni da bimbo e poi da giovane, cosa
ricordare di lui? S’incomincia subito da quando dice:<<Più di tutto mi
piacciono le parole: le vorrei sapere tutte>>. (In Tv dirà che le parole
hanno dentro l’anima e questo è tanto più importante per chi come lui è stato
per tutta la vita professore di greco e di latino, per chi come lui ha
insegnato).
Tra
i suoi primi ricordi Napoli in casa di nonna Annunziatina, avara come Paperone. Gli zii gli regalavano chi
1000 chi 1500 lire e lui le spendeva tutte in giornaletti. Un ricordo di
autentica poesia quando gli occorre un incidente ed è costretto a letto ma di
sera vede “le luci, tante luci a rincorrersi per la meravigliosa via
Caracciolo, su su fino al Castello”.
Roberto ebbe un’istruzione elitaria presso l’Istituto Gonzaga dei Gesuiti e la
scuola dei sacerdoti come quelle delle suore, vedi le Marcelline avevano una marcia
in più rispetto a quelle statali: una tradizione di lunga data, che invece il
professore della scuola statale è costretto a crearsi ed inventarsi da sé.
Gli
piaceva il gioco del calcio e il suo idolo sportivo era il portiere Giorgio Ghersi “che si catapultava
sui centravanti avversari come un kamikaze (suo soprannome) sugli aerei
giapponesi. Nasce per lui anche
l’amicizia per un compagno che come lui, praticando il calcio, faceva il
portiere. Un’amicizia che s’interrompe quando lui compie un piccolo sotterfugio
per vincere e l’amico, molto leale, di lui non vuol più saperne: triste perdere
un’amicizia sincera!
A
scuola quando si trova a studiare Montale
suo padre gli dice: <<Uno che vede ciò che noi non vediamo>> e
questo è lo sguardo di ogni grande poeta. Con i compagni un po’ goliardi
criticano Carducci e c’è al riguardo una gustosa maldicenza di Salvatore Di Giacomo che a cena con
lui quando il Vate gli suggerisce di poetare in italiano per avere un pubblico
più vasto risponde: <<E lei dovrebbe togliere la mano dal ginocchio di
mia moglie perché chist’è ‘o paese ca se te prore ‘o
naso more acciso>>.
Pur se io non amo
il Carducci di lui bisognerebbe ricordare sempre quella frase: <<E sempre corsi e mai non giunsi
il fine>>, quindi il Vate aveva
dovuto sfangare parecchio per sé e la famiglia”. E c’è in una delle “risposte”
del nonno questa considerazione di un nativo dell’Amazzonia: <<Ma voi
correte, correte sempre: dovreste ogni tanti fermarvi e aspettare che la vostra
anima vi raggiunga>>.
In casa Vecchioni il padre Aldo,
giocatore d’azzardo e alle corse di cavalli, ebbe un colpo di fortuna. Trasferitosi
con la famiglia a Milano, vinse un milione e tutte le corse ippiche del 1954
con il cavallo Nelumbo comprato per due lire. Una fortuna che poi
si dissolve per il vizio del gioco al punto che in casa sono costretti a
mangiare a sera gli avanzi del mezzodì e diventa fondamentale per andare avanti
il ruolo della madre che Roberto ricorda con splendide parole. Ma anche del
padre dice: <<Ha perso una fortuna ed è per questo che l’ho amato
tanto>>. Felice Vecchioni
bimbo che è stato amato dai suoi genitori e li ha riamati.
Salto avanti negli anni quando è
diventato un ottimo allievo e poi sarà professore di greco e latino per tutta
la vita, ma per stare in ambito familiare salto a quando incontra la sua
seconda moglie Daria
Colombo, entrambi con un matrimonio
fallito alle spalle. Sarà lei a sostenerlo a spingerlo a coltivare il suo
“mestiere” di cantautore che a 44 anni con Samarcanda gli fa vendere 80mila copie.
Due cose mi vengono in mente perché un
libro piace tanto di più quanto più ci si immedesima in alcuni aspetti di esso.
Anch’io mi sono laureata in greco e
quando Roberto parla di Achille e Patroclo dissento da lui e da una narrativa moderna
che li vede amanti: certo che nella Grecia antica i costumi non erano plasmati
dal credo cristiano, ma tra i due eroi leggo una profonda amicizia più che un
rapporto intimo. Amore e Amicizia hanno entrambi alla base la lealtà che
implica fin il sacrificio di sé per il bene dell’altro, la persona che si vuol
proteggere.
E ritorno ad un altro ricordo personale
quando Daria sa della morte del figlio
Arri e grida: il ricordo è di
quando una camionetta di giovani militari cadde dal viadotto autostradale che
scavalla il torrente Nervi all’estremo levante di Genova. Il capo redattore
delle pagine di Genova de il Giornale andò a raccogliere le testimonianze e poi scrisse: “L’urlo nero
delle madri”, frase che non mi piacque
mentre ora attraverso lo stesso dolore di Daria capisco che meglio non avrebbe potuto dire.
In una pagina precedente Roberto ha parlato dei quattro figli: “Francesca (avuta dalla prima moglie) sfidante compulsiva in faccia al sole” che
per lui padre si può definire l’estate, Caro che “sa reggere di tutto: il germoglio di ogni possibile fiore” e per
lui è la primavera; Dodi “il
suo plagio sfacciato con la sua malinconia spavalda” e che sa studiare da
aquila e per lui è l’autunno, e poi c’è Arri, un inverno di neve dolce, tutto suo madre e lui lo ama proprio come
ama sua madre Daria.
Roberto è poeta anche in questi ricordi familiari.
Chiudo con poche parole sul titolo per
come lo interpreto.
Perché il tuono? È la paura dell’attesa
che si fa felicità del sogno avverato (e lui confessa di aver sempre paura
quando sale su un palco, ma poi arriva lo scroscio, il tuono degli applausi).
E il silenzio: il momento in cui si
concentra in se stesso per inventare, per far sognare
e farsi amare e ci riesce: la gente lo ama.
Seconda parte: il nonno in realtà non risponde ma parla di temi che gli sono
cari come il traffico caotico che gli fa produrre ben due “risposte”.
Mi viene in mente quando una volta ero
davanti alla stazione Brignole di Genova in coda e quando si mosse l’auto
davanti la seguii. Mi fermò il vigile: <<Non ha visto che il semaforo era
rosso?>>, ed io: <<Ho seguito l’auto davanti a me>>. Lui: <<Signora
Bressani ma quando Lei vede un’auto che si muove le va dietro come una pecora?>>.
Per fortuna non mi fece la multa. Vecchioni se la cava
con il vigile con molto più estro di me.
Invece davvero indimenticabili alcuni
suoi ritratti di persone che ha conosciuto come di Carlin Petrin fondatore di Slow food.
C’è una lettera ai professori Delle Piane Confalonieri e Vitulo in cui da grecista parla della democrazia
con questa definizione: <<Il potere, l’ordine costituito, il patto comune
per vivere insieme, in una parola la polis, è degli uomini, dei cittadini>>.
E ancora: <<Un mito, qualsiasi
mito, spiega come dal nulla nascano i comportamenti, i legami e infine le
leggi, quel modo imperfetto di convivere che si chiama democrazia>>. E
aggiunge questo comandamento in greco che suona così: <<S’impara
soffrendo>>. Quindi ci parla del mito di Prometeo che rubò per gli uomini “il
fuoco, cioè l’intelligenza, la tecnica e l’arte”. Si diceva una volta dell’artista che si rivelava con la zampata del
leone, ma per Vecchioni basta
l’unghiata. Conclude da grande professore di greco con l’immagine di Prometeo incatenato alla rupe del Caucaso, ma
“fiero, indomabile, commosso e innamorato delle sue creature” e conclude: <<Come
io di lui>>.
Solo un neo ma importante in questo
libro. Forse da professore scafato lo fa per meglio entrare in sintonia con un
suo allievo dello IULM di Milano: usa qualche parolaccia di troppo, quelle per
cui una volta si diceva: <<Lavati la bocca>> e perché l’ammonimento
avesse più presa qualcuno lavava davvero la bocca al bimbo con il sapone. No,
caro Vecchioni, queste cose non si dicono!