1) Oilé Grotista, Gli speleologi triestini si raccontano 2021
(contributo dei cugini Tullio e Maurizio
Bressani)
2) Paolo
Antognetti, Il vero colpevole (Jaimar Edizioni, 2021 - Antognetti mio compagno
al Liceo D'Oria)
e
ricordo libro Antonio “Tonci" Kovacs di Chiara Fabro con il marito Vittorio
Pinna e de
La
festa di compleanno di Puni Notte: altri due compagni del
mio Liceo.
3) Laura
Boschian Satta, La mia vita con Salvatore Satta (mamma del mio compagno di
Liceo Luigi-Gino)
(Ilisso 2021)
4)
Articolo su Luigi (=Gino) Satta in morte.
5) Mario Zerbarini, Parsunnag’ e Mument' du nostar
"Bobi", (Edizioni Premio
Letterario Internazionale
Città
di Bobbio, ristampa 2019)
6)
Alessandro Ballerini, Occulto e Mistero (Edizioni Lir 2022)
7)
Amarcord e saluto personale ad eventuali lettori.
∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
Oilè grotista!
Gli speleologi triestini si raccontano
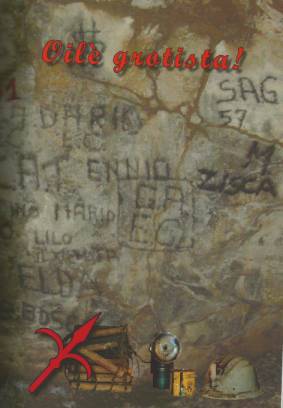
Premessa
Questo libro mi è tanto caro non solo perché riguarda le grotte
del Carso e la mia città natale Trieste – come ben si vede dall’alabarda in
copertina-, ma anche perché tra i grottisti ci sono i miei cugini Maurizio
(nella foto a sinistra), Tullio suo fratello maggiore con il gruppo dei
compagni delle discese in grotta. A
fianco metto la foto di me e Tullio in relax dopo una sciata e mio fratello
Ferruccio a Sestriere perché lì Tullio che studiava fisica a Torino (prima di
diventare docente all’Università in Sardegna e poi al Cern di Ginevra) ci
raggiungeva quando noi vi andavamo per la “settimana bianca”. E proprio questa
foto spiega anche il titolo della pagina “Giovani
sempre” e mi riporta il sapore di “rugiada” di anni così lontani nel tempo.
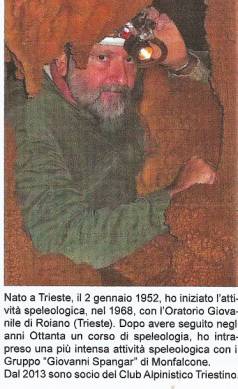
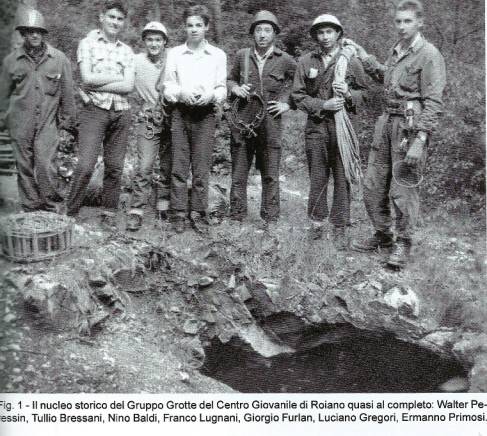
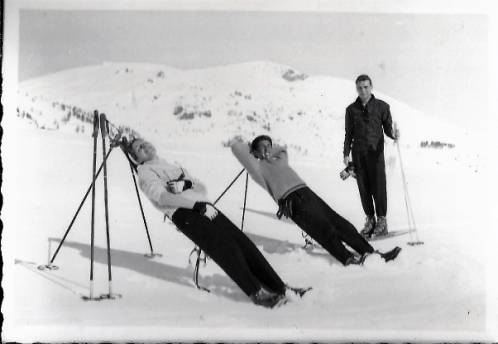
Il cugino Tullio, come il fratello Maurizio, scrive di sé nella
didascalia posta sotto un’altra foto: “Nato a Trieste il 15 luglio 1940/
1956-1965 Gruppo Grotte del centro Giovanile (CGR) di Roiano/ 1965-1979 Libero
grottista/ 1979-1985 Gruppo Grotte del Cai Cagliari/ 1986-2014 Gruppo
Speleologico Mnfalconese "G. Spangar"-CAI/ 2014 - oggi Pensionato
grottista”.
Recensione
L’occasione per il libro è un incontro tra amici durante la
presentazione del libro Muli de Grota
in cui diversi grottisti esprimono a Franco Gherlizza (che suppongo sia stato
loro compagno e maestro nelle discese
in grotta) di dar vita ad un nuovo libro che raccolga le loro
esperienze. Alla presentazione successiva di un altro libro La Caverna sotto il Monte Spaccato (con
sottotitolo Centocinquanta anni di
esplorazioni, tragedie e speranze speleologiche) gli viene di nuovo
espresso questo desiderio e così nasce l’attuale libro che raccoglie
l’esperienza e i ricordi di “tutti gli speleologi triestini”. In 24 hanno
risposto all’appello.
Il libro è tanto più interessante perché questi sono stati e
forse sono tuttora uomini d’azione ed esplorazione e non si perdono ad
infiorare le loro avventure ipogee ma le descrivono in modo quasi scientifico,
proprio come le hanno vissute.
Non solo il ricavato delle vendite del testo va ad una buona
causa e viene devoluto alla Fondazione Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin,
una Onlus che dal 1994 opera a sostegno di bambini feriti o colpiti da malattie
non curabili nei Paesi di origine. E ben sappiamo che sono i nostri “cuccioli”,
nati in ogni parte del mondo, la nostra speranza di futuro.
Il racconto delle esplorazioni in grotta parte dalla spiegazione dell’origine della canzone “Oilè grotista” che dà il titolo a
questo agile volumetto di 120 pagine. Una canzone del 1948 che fu presa ad inno
dal Club Alpinistico Triestino. La musica deriva da <<Oilà! Paisanos!>>, leit motiv del film “Gente allegra”.
Ci viene spiegato che il ritornello rimase legato alle parole
<<Oilè! Grotista, oilè. Sul fondo
te arriverà!>>, ma nell’agosto del 1947, al rientro dall’esplorazione
all’Abisso dei Serpenti, Almerindo
Brena, detto “el Vecio”, venne arrestato dalla <<Milica>> (polizia
jugoslava) e, per 40 giorni, messo in carcere (=canòn nel dialetto triestino e
in questo caso la fortezza di Lubiana), perché quella spedizione nel loro
territorio era avvenuta senza le dovute autorizzazioni. Non solo Brena aveva
raccolto alcune piastrine identificative di soldati tedeschi, i cui miseri
resti erano stati notati alla base del cono detritico di quella famosa grotta.
Così il ritornello divenne: <<Oilè! Grotista, oilè. El Vecio xe in canòn>>.
La canzone è molto spassosa quando ci dice che al ritorno dalla
scorribande in grotta vanno tutti in osteria a comprare tanto vino, “ma tutti
quanti bevi solo un picio bicerin”.
Mi ricordo che un amico, venuto da Pola a lavorare in Ansaldo a
Genova e poi trasferitosi con la famiglia in America, raccontò come la miseria
in quelle zone fosse tale che quando voleva festeggiare con amici si ordinavano
solo un bicchierino di grappa e poi a turno ognuno vi intingeva un dito e se lo passava sulle labbra per
gustarne il sapore.
(Inserisco la foto di Alemerindo Brena e a fianco un’altra per
far ammirare l’ingresso ghiacciato di una grotta: infatti i grottisti devono
spesso lottare anche con temperature molto basse e quindi con un freddo da cui
gli indumenti non riescono mai a proteggere abbastanza).

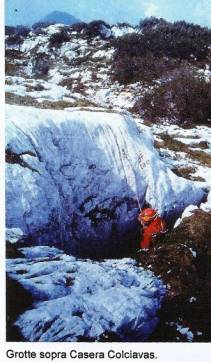
Segue un breve capitolo con cenni storici sulla speleologia
triestina e ricordo sempre Minnie Alzona, ottima scrittrice genovese con
risonanza sul piano nazionale e
all’estero, che mi diede questo insegnamento: <<Nei miei romanzi metto sempre una base storica perché
dà il sigillo della verità alla vicenda e perché la Storia nei secoli non
smette di offrirci lezioni da non ignorare per non ripetere gli stessi errori>>.
Così nel libro ci viene rammentato come nel XVIII secolo Trieste,
che era ancora un piccolo borgo medievale
sempre in lotta nell'Adriatico con Venezia, altra Repubblica marinara,
sotto l’amministrazione dell’Impero Austriaco diventa porto asburgico e conosce
una grande prosperità economica. Uno dei più pressanti problemi triestini
risultava l’approvvigionamento idrico in quanto la morfologia carsica non
permette di avere corsi d'acqua in superficie a parte alcuni a regime
torrentizio come il Rosandra, il Piuca e il Reka che però a contatto del
calcare s’inabissano e scompaiono nelle profondità. Era però credenza nel XIX
secolo che all'interno dell'altopiano
carsico vi fossero grandi bacini sotterranei d’acqua formatisi lungo il percorso del Timavo. Così
fioriscono ricerche ed esplorazioni in questo senso anche con il supporto del
Comune che però nella seconda metà
dell’Ottocento provvede a proprie spese all'approvvigionamento idrico della
città. Questa breve ed essenziale parte storica è molto interessante, però per
campanilismo parto dalle esperienze narrate in questo testo dai miei cugini
grottisti.
Maurizio, il più giovane, dieci anni meno di me, ci racconta di
come a seguito dell’incidente al reattore di Chernobyl del 1986 che liberò
nell’atmosfera una grande quantità di isotopi radioattivi, decise con il fratello
(che aveva la possibilità e la strumentazione necessaria in quanto Direttore
della Sezione di Torino dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) di dar vita
ad una campagna esplorativa nella grotta Lindner (di cui proprio in questo
libro c’è un antefatto interessantissimo sulla scoperta e una precedente
esplorazione). Un primo prelievo del 1986 indica una notevole contaminazione
del suolo nella dolina d’ingresso nel periodo immediatamente successivo alla
pioggia da Chernobyl, ma nel 1987 viene misurato un valore dieci volte maggiore
rispetto a quello del 1986. Scrive Maurizio: <<L’ipotesi più plausibile è
che il fango di una delle parti più profonde della Grotta Lindner non venga
depositato da acque di percolazione provenienti della zona immediatamente sovrastante,
ma da acque di fondo in collegamento con un corso d’acqua che scorre in
superficie per un certo tratto e quindi può trasportare la contaminazione
superficiale…>> Mi fermo a questo punto lasciando a chi legge il piacere
di andare a trovare il libro e seguire tutta l’analisi e i risultati (questo perché il cugino non mi tolga il
saluto vista la mia ignoranza) e passo alla testimonianza successiva del cugino
maggiore Tullio. Questi racconta, che già interessatosi alle discese ipogee
dopo la lettura di Duemila grotte, un
libro della biblioteca del padre professore, su spinta di un compagno di classe
che frequentava l’Oratorio della Parrocchia di Roiano, si aggregò alle attività
organizzate per i ragazzi da un giovane sacerdote, don Guerrino Zangrando, e
così nel 1956 a quattordici anni iniziò a frequentare il CGR (Gruppo delle
Grotte del Centro Giovanile di Roiano). Interessante l’acquisto per
l’attrezzatura che serviva a scendere in grotta e per realizzare ottanta metri
di scalette si utilizzarono come pioli i manici di vecchie scope. Saltando
tanti momenti del racconto vengo a quando Tullio nella Grotta Silvano trova uno strano animaletto, una salamandrina bruna
con macchie rossastre che fatta esaminare dal Direttore del Civico Museo di
Storia Naturale viene classificata come un geotritone e altri ne trovò a mille
chilometri di distanza nella grotte dell’Iglesiente: infatti il geotritone è un
urodelo tipico della Sardegna, presente solo in altre ristrette zone tirreniche
ma non nel Carso Triestino. Tullio si chiese in seguito se si fosse trattato
proprio di un geotritone e in tal caso come fosse finito nella Grotta Silvano. Un altro episodio
riguarda il ritrovamento di un pipistrello in un’altra cavità che mise nella
tasca-schiena della tuta mimetica. Poi si cambiò d’abito con i compagni e
andarono all’osteria di Gropada ma vide che il suo zaino posto a terra si stava
muovendo e poiché aveva dimenticato il pipistrello nella tuta, l’aprì e questo
sgusciò fuori svolazzando per il locale tra le grida degli avventori e gli
improperi della proprietaria. Ultima notizia di questa testimonianza la festa
per don Guerrino nel 2007 per i suoi ottanta anni.
Già da queste due testimonianza familiari potete capire quanto
sia variegato ciò che s’incontra in questo libro.
Un grottista mette solo belle foto perché più esplicative delle
parole, un altro riesce a fare una spedizione in Russia e una in Brasile, un
altro ci racconta di come ragazzino ad una discesa in grotta il suo maestro gli
riempisse lo zaino di pietre per rendere meno agevole il cammino e la risalita
e lui, strafottente, ne aggiunse altre, trovandosi poi davvero a mal partito
con tutto quel peso quando dovette risalire e mi sono venuti in mente i “riti
di passaggio” di antiche tribù, prove che un adolescente doveva affrontare per
esser considerato uomo. Altrove invece la testimonianza si fa più lieve come
nel caso del bimbo di meno di quattro anni, portato dalla mamma in un prato che
profumava di ciclamini all’ingresso di una grotta in cui si calano un certo Tom
e la sua compagna bionda. E il bimbo s’innamora di quella chioma d’oro e dice alla mamma: <<Da grande voglio
fare lo scienziato e sposare una signora come quella di oggi>>. E scusate
l’intromissione personale ma quando a sei anni, a metà anno scolastico,
arrivata da Trieste a Genova, trovandomi tra compagne tutte brunette salvo tre,
mentre le mie triestine erano state tutte bionde, ricordo il profondo senso di spaesamento di allora.
Ormai le nostre classi registrano anche tanti ragazzi africani e ci devono
comunque essere problemi di estraneità prima di far amicizia.
Ci sono poi come la già citata ragazza bionda, altre grottiste:
quella distratta che dimentica sull’orlo del “pozzo” prima di discendere da
sola il sacchetto per la risalita e non avendo avvisato nessuno prova momenti
di sgomento ma poi ingegnosamente riesce a risalire; un’altra che ci narra la
deliziosa storia di Yappi un pipistrello raggiante. Yappi è
abbandonato dai suoi compagni da solo nella sua caverna d’origine e quando
decide di uscire trova in un altro anfratto una merla e i suoi piccoli che gli
fanno compagnia ma poi per nostalgia dei suoi riparte alla loro ricerca
trovandoli infine in una caverna con le pareti ricoperte da centinaia di
pipistrelli. C’è perfino la grottista che va in Israele per studiare ed
esplorare quel territorio entrando in contatto con una archeologa triestina già
lì in forza in un’Università
Israeliana. Ecco la cover del libro che pubblicò su quella esperienza e a fianco
la bella immagine della distratta. E allego anche le firme di grottisti del
gruppo San Giusto.
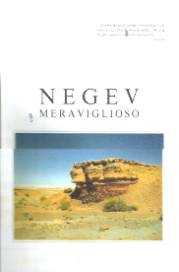

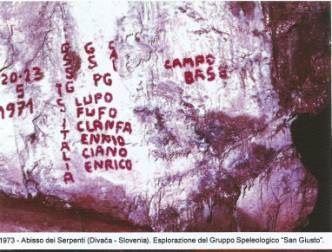
Pregio dl libro è anche aver voluto ricordare tutti i nomi
delle Associazioni speleologiche triestine dagli inizi al 2020, sono 97 e occupano ben due pagine. Mi piace concludere
con alcune frasi.
La prima quanto mai in
tema con il titolo di questa pagina Giovani
sempre:
<<Quando vi si torna con il pensiero, ci si accorge come
sembra siano passati solo pochi giorni e le sensazioni allora provate sembrano
vivide e attuali>>; la seconda:<<La verticalità, in qualunque senso
di marcia si scelga di percorrerla, è qualcosa che non ti lascia più>>;
la terza, non è una frase, ma una pagina struggente a ricordare compagni che
hanno perso la vita quando li travolse una slavina, piccolissima e
invisibile dopo la nevicata della notte. Allora nella conca del Boegan c’erano
undici metri di neve. Gli amici passavano ogni giorno sopra di loro ma solo sei
mesi dopo li ritrovarono,: “i grandi zaini e le ciaspe li avevano immobilizzai sotto
pochi centimetri di neve”.
E uscendo un poco dal contesto ricordo dal libro anche la frase
di un ragazzino, tra i 12 e i 14 anni, che era riuscito a comprarsi
l’attrezzatura per scendere in grotta, ma la
cui la madre (la sua peggior nemica) che non veniva a compromessi,
quando lui prendeva a scuola qualche
voto disastroso, gliela gettava nella spazzatura condominiale e così era costretto a rovistare tra il pattume per
ricuperarla. Aveva però un sostenitore in suo padre, cui fa idealmente un
“braccio teso” in quanto questo papà era stato volontario nella campagna
d’Africa e fra i primi ad entrare con le nostre truppe ad Addis Abeba. Un
innamorato d’Africa per cui “il Duce era un gentiluomo di tutto rispetto”. Nel
suo racconto viene rammentato un compagno che come tutti gli amici delle
discese in grotta aveva un soprannome e nel suo caso era “il Gobbo".
Questi nel 1968 si trasferì in Australia e ciò mi ha riportato alla mente che
il 26 ottobre 1954 Trieste tornò all’Italia ma il 15 marzo del 1953 erano
partiti con la Castel Verde ben 2100 triestini alla volta di quella
terra e quindi può essere che abbia raggiunto qualcuno della famiglia
che vi si era già stabilito quindici anni prima.
Perdonate di nuovo un’intromissione. Mi capitò per un
anniversario di matrimonio di compiere un breve viaggio in Tunisia e la guida
del pulmino ci disse a proposito di Craxi che aveva conosciuto direttamente e
bene: <<Un gran gentiluomo>>. Per cui ci sono tante vulgate, e
alcune molto negative trovano spazio prima nei giornali poi nei libri scolastici, mentre la realtà per
chi la visse fu un po’ diversa. Non solo questo episodio della madre tremenda
mi trova molto partecipe perché anch’io scesi da casa a gettare in spazzatura
una marmitta da moto nuova di zecca e dal rombo potente che uno dei miei figli,
complice un compagno di scorribande, voleva montarsi mentre per me lui doveva
studiare e solo studiare e ben inteso me ne vergogno tuttora.
Ma tornando al libro vi
emergono per me “la bora settembrina e mirti contorti e profumo intenso di
ciclamini e il blu intenso del mare”.
Il vero colpevole
Paolo Antognetti
(mio compagno al Liceo D’Oria di Genova sezione “C”)

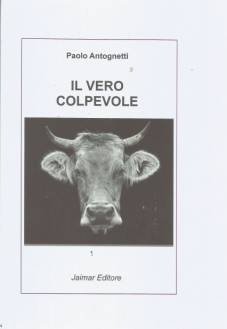
Il vero colpevole
Paolo Antognetti
Premessa lunga ma necessaria.
Paolo Antognetti, mio compagno al Liceo D’Oria, fin dalle medie
quando ancora portava i calzoncini corti e quindi a me molto caro, ha fatto
tante esperienze importanti nella sua vita: iniziò come ingegnere alla Silicon
Valley, poi all’università di Genova è stato docente, da cultore del cibo in
modo che questo non ci danneggi ha avviato attività in questo settore e in tal
senso parla il suo primo libro L’Arte di
vivere a lungo, poi trasferitosi in Svizzera è diventato imprenditore.
Potete trovare notizie più approfondite sul suo sito www.antognetti.it Ha scritto anche importanti libri tecnici ed
ora si dedica a scrivere nel genere che ha avuto più successo nel ‘900: il
giallo. Uomo di multiforme ingegno come
si sarebbe detto un tempo o piuttosto un uomo con molti interessi che ha
cercato di realizzare, pensa sia stato Piero Raimondi, nostro professore d'italiano al liceo, ad
inocularci la passione dello scrivere.
Non a caso dalla nostra
classe sono usciti diversi scrittori:
-
Vittorio Pinna che con la moglie Chiara Fabbro,
nata in Dalmazia, ne ha ricordato l’esodo da quella terra già italiana in Antonio
“Tonci" Kovacs
-
Puni Notte che con la sua Festa di Compleanno tra l’altro arricchita da disegni di un'ottima
illustratrice, ha tracciato un quadro anche satirico di altri nostri compagni
con cui si riuniva a casa di Laura, moglie di mio fratello.
-
Luigi Satta, figlio di Salvatore de Il giorno del giudizio (libro che la nostra insegnante ebrea al
ginnasio Gina De Benedetti definiva il più bello sull’Olocausto). Ha atteso con
cura e passione a far pubblicare dall’Ilisso, la casa editrice sarda che aveva
pubblicato sul noto libro di suo padre, altri scritti sia del padre che della
madre la triestina Laura Boschian.
Spero di non aver dimenticato alcuno di noi scrittori della III
C del D’Oria ma certo Piero Raimondi è stato insegnante per noi molto formativo
e, coltissimo, è stato anche il redattore dei Nobel in lingua spagnola della
Utet.
Quando doveva interrogare -ed era il momento del terrore-
girava per la classe tenendo con una mano ad altezza del suo capo la cantica di
Dante che ci stava insegnando e faceva scorrere le pagine al di sotto con un
dito dicendo: <<Quando mi fermo, dove apro la Divina Commedia sulla prima lettera su cui mi cade l'occhio, quella mi indicherà i cognomi degli allievi
che interrogherò>>.
E’ chiaro che era tutta scena a dispregio delle successive
interrogazioni programmate venute in auge nella scuole però un certo terrore ce
lo incuteva perché quando interrogava non si sapeva mai come saremmo finiti.
Non solo, c’era un nostro compagno di classe che desiderava essere castigato
quando chiacchierava per avere come punizione da studiare molti versi di Dante
a memoria, una volta perfino un’intera cantica, che poi doveva recitare in
classe alla presenza nostra e di Raimondi: quel compagno aveva una buona
memoria e gli piaceva così. Anzi sua madre che talvolta ricuperava lui, me e
qualcun altro che abitava dalle nostre parti, era stata compagna del Professore
che in gioventù si era un po’ invaghito di lei (così si favoleggiava). Si
diceva che le compagne all’uscita dall'aula alla fine delle lezioni la
nascondessero sotto i cappotti in modo che lui non potesse vederla e lei così
evitava di farsi accompagnare senza esser maleducata.
Questa signora una volta di quei tragitti in auto, dato che
faceva molto caldo e si era alla fine dell’anno scolastico e ad inizio della
stagione estiva, sollevava la gonna e si faceva aria come fosse un ventaglio e
ricordo come si spericolò a guardare le sue gambe l'autista del bus che ci
aveva affiancato.
Impagabili ricordi di una giovinezza lontana e ricordo anche
quelle parole di un libro di Daphne du Maurier: <<Odo un canto morire a
poco a poco e dice non sarò mai più giovane, mai più giovane>>. Mi hanno
sempre colpita per la sottesa malinconia che mi s’insinua dentro.
Di Raimondi ricordo pure che arrivò da noi in seconda liceo ed
in prima avevamo avuto un’insegnante supplente che i miei genitori giudicavano
non fosse all’altezza di formarci a dovere come se saltassimo un anno di
preparazione e quindi mi avevano mandato a lezione privata proprio da Raimondi.
Il Professore mi chiese: <<Se io venissi al D'Oria il
prossimo anno e diventassi suo insegnante lei cosa ne penserebbe?>>
Risposi che ne sarei stata felice e lui commentò: <<Strano è l'unica che
lo pensa>>. Quando poi divenne mio professore a scuola alla prima
interrogazione mi fece andare a tal punto nel pallone che invertii perfino le
date di nascita e morte di Dante, fu un’autentica débacle ma poi pian piano mi
ripresi anche perché apprezzava i miei temi definendoli "originali e
divertenti". Avevo anche avuto alle medie un’insegnante di francese Maria
Giulia Quarello che alla prima interrogazione era rimasta molto delusa da
quanto rispondevo, ma alla seconda con tanta buona volontà mi ero messa in pari
e si complimentò con me. Insomma è il solito per aspera ad astra anche se in questo caso gli “astra” sono solo
voti decenti per non passare l’estate a studiare perché giudicati
insufficienti.
Allego la cover del libro di Puni Notte e quella del libro di
Chiara Fabbro ma di questo inserisco
proprio l’articolo che scrissi su il Giornale per il giorno del ricordo del
2013: anch’io venendo da Trieste nel 1948, quando gli slavi al 4 novembre,
giorno in cui mio padre metteva fuori dal terrazzo il tricolore, prendevano a
sassate le nostre finestre rompendoci i vetri, provai il senso di sradicamento.
Fu solo quando due gemelline, Lidia e Marina, figlie del giornalista Emanuele
Gazzo, prendendomi per mano mi portarono dalla loro mamma dicendole: <<E’
la bambina che viene da Trieste>>, solo allora mi sentii accolta e capii
che esser nata a Trieste poteva sembrare quasi un privilegio.
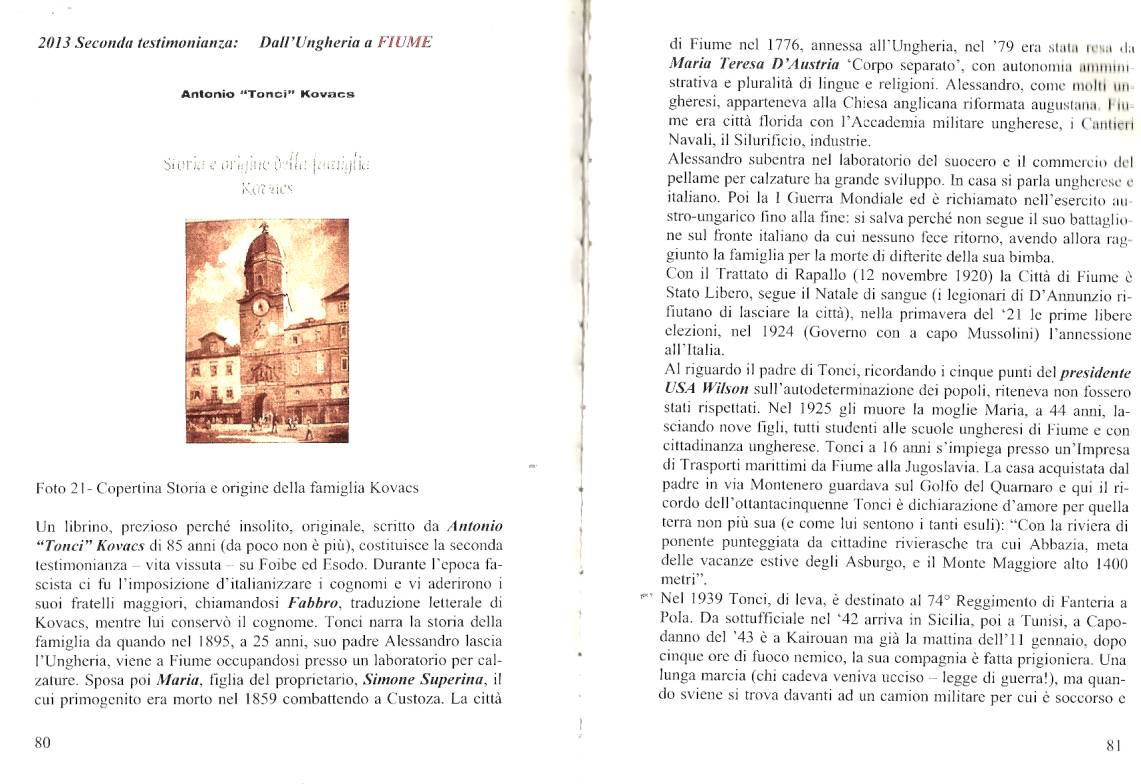
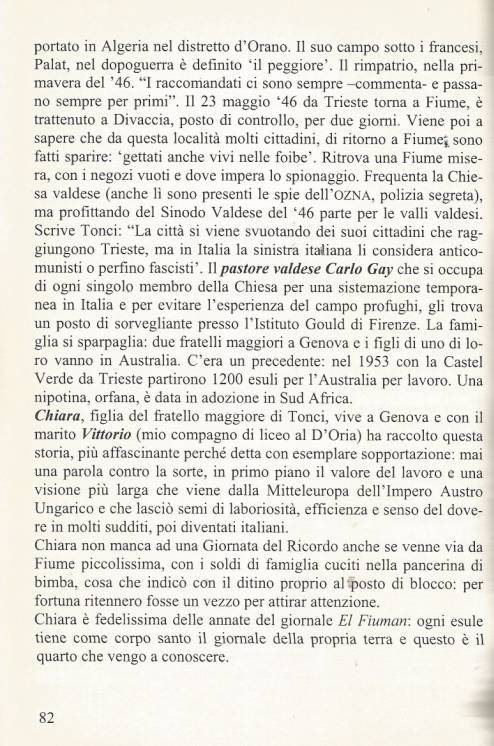
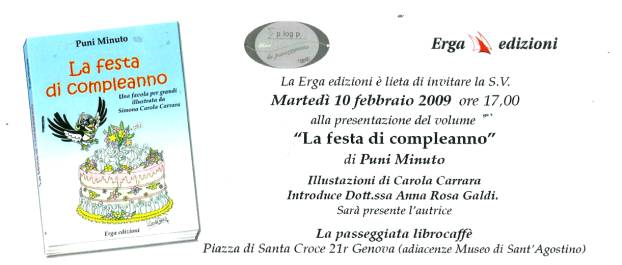
Recensione
Il vero
colpevole
Torna un’altra avventura dell’ispettore della polizia
Giudiziaria Andrea Soldano nel nuovo giallo di Paolo Antognetti (Jaimar Editore
dalle raffinate e semplici copertine bianche con foto al centro).
Lo ritroviamo dopo averlo visto in azione ne Il drago del monte Santeremo, svegliatosi
di nuovo all'alba come allora: ne “Il drago” era il 9 settembre 2012, ora
il 23 febbraio 2013. Un risveglio
bucolico per Andrea quando va in cucina a prepararsi il solito beverone di due
terzi di latte ed uno di caffè mentre
fuori “i cristalli di neve sugli abeti emettono scintille di luci e due
cinciallegre vengono scacciate da un merlo dal becco giallo". La sua
precedente inchiesta aveva riguardato il killer di Grione, piccolo paesino
(tuttora con pochi abitanti privati ma con una ventina di alberghi) in
provincia di Bra (Cuneo), vicino a
Pinerolo. Ora proprio nel <<Prologo>>,
prima del suo bucolico risveglio, lo ritroviamo che guida spericolato verso
l’ospedale di Pinerolo e si sente in colpa per "le morti inutili, per la matassa di nodi che non ha saputo sciogliere
per tempo e ne sente tutta la responsabilità".
Ma a questo capitolo, breve come tutti gli altri (quindi di
agevole lettura), ne segue uno intitolato <<Berlino>> dove ci viene presentato un killer prezzolato,
Litso Steel (che in russo-inglese significa “viso d’acciaio"), personaggio
enigmatico ed affascinante, che aveva lavorato in Russia presso il Servizio di Sicurezza Interna, uno degli
organismi nati dopo la dissoluzione del famigerato KGB, ed aveva lavorato come
guardia del corpo di Boris Eltsin al Cremlino. Era uno degli agenti speciali
utilizzati per missioni molto discrete di spionaggio all’estero. Ora lavora nel
settore privato con parcelle molto più allettanti.
Quindi con tecnica narrativa ad incastro - e bisogna apprezzare
questa ars narrandi dell’Autore - si
ripiomba nella parte vecchia di Grione, nella fattoria di Antonio, caro amico
dell’ispettore Andrea, dove la mucca Jole della razza Simmental (di origine
svizzera) sta per partorire. Dopo che questa ha dato alla luce due vitellini,
Antonio chiede ad Andrea di fare l’accompagnatore della Jole davanti alla
giuria nella “Fiera-Concorso per mucche
da latte" che si tiene ogni cinque anni a Pinerolo. Poiché l’ispettore ha
chiesto proprio in questo momento una quindicina di giorni di ferie non ha
motivo di tirarsi indietro e si presta ad accontentare l’amico di vecchia data.
Intanto però Litso Steel sta operando in un altro scenario, a
Berlino, dove in quel momento la “Branderburger Tor è tutta illuminata tra i
primi fiocchi di neve che iniziano a cadere". Cammina nella parte centrale
del viale sotto i tigli verso il Teatro dell’Opera, con la facciata costruita
ad imitazione di un tempo greco-corinzio. Porta una maschera di silicone e -
dopo l’intervallo tra il secondo e il terzo atto -, pensando che non è per
niente brutto morire all’opera mentre le Valchirie ti portano al Walhalla,
uccide con la sua semiautomatica Makarov due inservienti per arrivare a colpire
un uomo e la sua compagna seduti in un palco: cioè il bersaglio
commissionatogli. E vero coup de Théatre - stile horror! - l’uomo si accascia sulla balaustra per poi cadere nella fossa
dell’orchestra.
L’ars narrandi è
costituita in questo libro nel modo più evidente nella cura e precisione dei particolari e la suspense
che rimane sempre alta è ravvivata qua e là da qualche guizzo d’umorismo come
quando la Jole viene preparata per il concorso e le vengono fresate le unghie
per darle una postura più equilibrata e Andrea, che non manca di stupirsi di
questo rito, lo paragona dal concorso di miss Italia con le donne che vengono
ben truccate..
Ripensando a Piero Raimondi, nostro professore di italiano al
Liceo, corso C, dove Antognetti era mio compagno, mi viene in mente Cecco
Angiolieri (CXIV):
<<Quando mia donn’ esce la man’ dal letto / che non s’ha
post'ancor del fattibello,/ non ha nel mondo si laido vasello/ che, lungo lei
(ndr: al suo confronto), non paresse un diletto/... fin ch’ella non cerne col
buttarello (ndr: setaccio per i cosmetici)/ biacca, allume scagliuol' (ndr.
gesso o similare) e bambagello (ndr: rossetto)/... ma rifassi d'un liscio
smisurato/ che non è om che la veggia 'n chell'ora,/ ch'ella nol faccia di sé
innamorato>>.
Insomma Cecco ama Becchina in modo così romantico che quando la
vede alzarsi dal letto gli sembra davvero brutta ma poi lei prende pennelli e
pittura e fa innamorare chiunque la vede, lui per primo. Ed è quel Cecco
dirompente e distruttivo del <<S’io fossi foco arderei ‘l mondo,/ s’i'
fossi vento lo tempesterei/ s'i' fossi acqua l'annegherei... >>
Torno al libro di Antognetti dove la Jole vince il concorso ma
un allevatore concorrente si trova
d’improvviso la mucca sgozzata e ne nasce una lite tra chi possiede la mucca
vincente e quest’altro che ha perso. Il proprietario della Jole finisce dietro
le sbarre accusato d’omicidio in quanto l’altro allevatore viene poi trovato
assassinato, insomma sembrerebbe una cosa orribile ma connessa ad un ambiente
campestre invece bisogna ricordare il primo omicidio di Litso Steel all’Opera…
Lo scenario si allarga ad un magnate russo che aveva uno chalet a Grione e che
voleva acquisire un pascolo sfrattandone i proprietari o comprandoli con denaro
o facendoli uccidere per costruirvi un Ecomostro, cioè non più chalet ma tante
tante stanze alberghiere da cui trarre un grande guadagno.
Ho già detto troppo a proposito della trama complessa del
giallo che però si legge di corsa alla ricerca del finale e sono convinta che
il lettore debba capire da una presentazione o recensione quale sarà
l’argomento tanto più che molti critici del nostro tempo hanno finito per
tessere su un'opera da commentare una propria performance di autoincensazione.
Gli elementi più apprezzabili del giallo sono: lo stile del
narratore, un giro tra eccellenze italiane dai Principi di Sestriere, alle
Terme di Salice, alle Langhe piemontesi, a via Montenapoleone a Milano che
indicano in Antognetti ormai lontano dall’Italia il suo amore per la terra in
cui è nato. Ci sono altre nostre eccellenze come il pranzare al Biffi di Milano
(l tipico risotto con lo zafferano) o il gustare nostri prodotti tipici. Poiché
la qualità di un libro sta nei dettagli non manca la penna stilo Mont Blanc e
un cane pastore non è il solito che si può vedere negli alpeggi ma un Border
Collie, il primo caffè che l’ispettore Soldano gusta in una baita con il
compagno-giornalista Michele è un Irish coffee versione locale dove il whisky è
sostituito dalla grappa. L’Autore, uomo
forse semplice di carattere ma certo raffinato nei gusti, rivela anche
competenza e passione per la musica classica e l’Opera.
Quando leggo un libro mi chiedo sempre in che personaggio si
può identificare l’autore perché siamo tutti, noi che scriviamo, un po’
autobiografici e il personaggio può corrispondergli come un alter ego o come
qualcuno che lui avrebbe voluto essere. In questo caso dove l’Autore si rivela
più che mai uomo elegante penso che il personaggio da lui creato con più
interesse sia il killer. Questi
conserva anche un’etica di soldato servitore della sua patria: in fondo
tutti noi desideriamo qualche volta poter far fuori persone scomode o invidiose
o improponibili alla nostra mentalità.
Postilla
Ora io ho ripiegato il mio dissenso sui troppi cani che
incontro per strada pur se nell'immagine del mio sito www.marialuisabressani.it
ho in braccio un cagnolino, ma quella è un'altra storia che
riguarda il cagnolino di mia figlia, perso e ritrovato.
Ci sono - a parer mio ma lo ha detto anche Papa Bergoglio - più
cani che umani. E L’altra volta mentre leggevo tranquilla su una panchina mi si
è fermata davanti una cagnolina botolotta e ringhiosa. La padrona l’ha raggiunta
dicendole: <<Cammina, stupida>>, però io ho pensato che la cagnetta
mi aveva letto nel pensiero. Sterminerei volentieri lei e i troppi altri cani e
pur se capisco la solitudine delle nostre città, penso che forse sarebbe più
utile dedicarsi ad un umano sofferente o in difficoltà più che accudire un
cagnetto.
Laura Boschian Satta
La mia vita con Salvatore Satta
Laura è mamma del mio compagno Gino (Luigi) al Liceo
D’Oria, sezione “C”. Il libro è uscito con Ilisso, la stessa casa editrice che
pubblicò Il giorno del Giudizio del padre Salvatore, definito da Gina De
Benedetti, nostra insegnante al ginnasio, “il
più bel libro sull’olocausto” (=sacrificio). Non solo sempre per
l’affetto di Gino per i suoi genitori, ma anche perché era ben consapevole che
queste memorie dovevano restare e un libro è qualcosa di duraturo, con Ilisso
sono usciti del padre Salvatore i Padrigali mattutini (2015),
affettuose rime (talvolta anche piccole lamentele) che lasciava alla moglie e
ai figli, prima di recarsi in tribunale al mattino perché le leggessero a
colazione e le sue lettere a Laura raccolte nel Mia indissolubile compagna (2017).
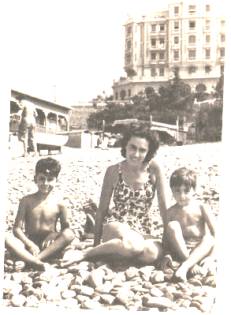
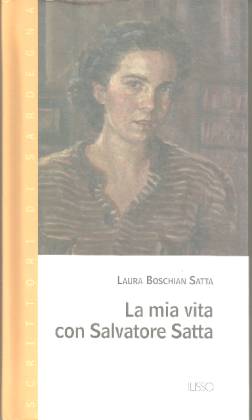
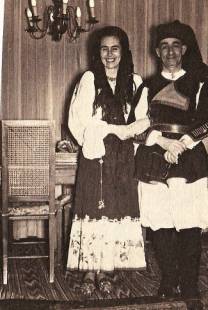
(Le tre foto sono: Laura con i figli alla spiaggia davanti alla
loro casa in Corso Italia 30, la cover del libro, Laura e Salvatore in costume
sardo e si vede di lei uno smagliante e divertito sorriso).
Ho molto apprezzato la lettura di questo libro ritrovandovi la
“scrittura al femminile" che è un'attenzione quasi pittorica ai
particolari ai sentimenti senza perder di vista il contesto storico. Ne nasce un
grande affresco d’epoca.
Ho tanto più apprezzato perché sono nata a Trieste come Laura
Boschian che era dell’età di mio padre. Pur essendo vissuta poco nella mia
città d’origine, tra i quattro e i sei anni, per me sono stati importanti per
la ricostituzione della mia famiglia dopo la prigionia in Africa del papà che
non avevo conosciuto perché partito per
la guerra quando ero in fasce. Così nella prima parte del libro, che narra la
vita triestina di Laura prima del matrimonio, ho ripercorso nomi e fatti che
porto in cuore o che mi sono stati raccontati. Ho riassaporato quel senso
d’identità che non avrei avuto senza la “mia” Trieste dove papà poi
trasferitosi con noi a Genova ci portava ogni anno come in pellegrinaggio per
il 4 novembre (dal 1922 Festa dell'Unità
d'Italia dopo la vittoria della prima guerra mondiale o a fine ottobre). E
quando Trieste tornò all’Italia noi c'eravamo in una piazza dell’Unità gremita
all’inverosimile ad aspettare l’arrivo delle navi italiane il 26 ottobre 1954
dopo che il 5 era stato firmato lo storico accordo.
L’amore per il libro.
Per far capire come nella famiglia Boschian-Satta sia stato
connaturato l’amore per il libro riporto da queste pagine solo due episodi. A
Trieste la mamma di Laura invitava le amiche in un pomeriggio di ogni settimana
e tutte portavano un libro, libri che poi si scambiavano e ne parlavano. Ma si
scambiavano anche ricette di cucina e non bisogna dimenticare che la cultura passa anche dalla cucina.
Ritornano nel libro nomi come i palcinken (sottili crêpes farcite di
marmellata) o la putizza o il presnitz o la gibanitza, prelibatezze della
cucina di confine.
Non solo c’è qualcosa che sembra unire i due sposi come un
retroterra comune: Trieste era un’insula
mitteleuropea al lembo nordorientale dello Stivale, e la Sardegna un’insula non solo dal punto di vista
geografico ma anche culturale.
L’altro episodio che denota l’amore per il libro è che quando
Laura si sposò con Salvatore, questi alla sera le leggeva pagine di buona
letteratura italiana e straniera mentre lei sferruzzava maglioncini per i
figli.
Le storie umane.
Laura in queste pagine ne colleziona tante e ne ricordo solo un
paio, una buona e una cattiva, per esemplificare.
- La “pippanetta":
era l’insegnante di pianoforte di Laura a Trieste. Correva da un lato all’altro
della città “con la bora o con l’afa per farsi assordare le orecchie con gli
stessi esercizi ma storpiati in maniera diversa”. E dietro doveva avere un
uomo, sposato certo e quindi non libero che quando la incontrava per strada le
parlava con gli occhi e poi le mandava "cento rose rosse con in mezzo una
bianca a significare che il suo amore ardente avvolgeva la purezza di lei o
cento rose bianche con una rossa al centro per dirle che la purezza di lei
proteggeva il loro amore". Ma un giorno è Laura a confidarle che si è
fidanzata e sta per sposarsi e allora Pippanetta getta la sciarpa che aveva al
collo sulla tastiera - per farla tacere! -,
con un “parliamo di lui”. E’ stata la conclusione delle lezioni di
piano, che "erano state anche
lezioni di sogni", ma "nella vita bisogna anche imparare a sognare”,
commenta Laura.
-
Il
cooperativo: il commesso della locale cooperativa di Pieris,
alle foci dell'Isonzo dove i genitori di Laura avevano una campagna e dove lei
con Salvatore e i figli vanno per un certo periodo in tempo di guerra. Era il commesso
comunista della locale cooperativa che sul banco non aveva nulla da vendere ma
sottobanco vendeva di tutto...
Penso sia importante chiarire da subito come Laura
considera l’invasione dei titini: "quello che dispiaceva nelle bande di
Tito era l’ostentata insolenza, la pretesa in quell’accozzaglia di uomini e
donne, di essere dei vincitori e dei dominatori. A Trieste però non fu solo
insolenza, solo diffusione di pidocchi e di cimici, fu infamia. Nei 40 giorni
dell’occupazione ben 4000 italiani, uomini e donne, vennero gettati vivi nelle
foibe del Carso".
E quando Salvatore viene eletto rettore
all’Università di Trieste nell'immediato dopoguerra e deve pronunciare il
discorso inaugurale, poi pubblicato nel 1945/46 in Soliloqui e colloqui di un giurista riceve dal Governo Alleato il
perentorio divieto di non nominare l'Italia e dimostra la sua “straordinaria abilità nel non nominarla,
nominandola sempre". Allora gli jugoslavi premevano per avere
un'università almeno bilingue, ma si diceva – precisa Laura - che il colonnello
americano cui spettava la soluzione di quei problemi, avesse un’amante slovena
o croata, fedelissima a Tito.
Avvisaglie di quanto fosse incandescente la
situazione a Trieste quando lei era ancora studentessa nella loro casa di
villeggiatura a Opcina ed avviene l’attentato alla polveriera della Grotta
Gigante che li costringe a radunare le loro cose e ad andare frettolosamente in
strada. Un attentato quasi in città commesso da sloveni antifascisti ma i compagni di liceo poi le chiederanno con
premura solo se aveva fatto i compiti
delle vacanze quella notte, se avesse
potuto salvarli o se dovesse rifarli. E Laura si domanda come potessero giovani
alla vigilia della maturità riflettere solo sui compiti e non su ciò che stava
montando di rabbia, anche se non c'erano state vittime. Ma c’è allora anche un
episodio di rara solidarietà, quasi di affetto: il contadino Malalan che aveva
casa dall’altra parte della strada davanti alla loro villetta e che era
anti-italiano, antifascista e comunista, si fa loro incontro per avvertirli di
star tranquilli che non è successo quasi nulla e che possono rientrare a casa.
Severa ma franca anche nella condanna dei nostri
partigiani comunisti i quali continuavano a ripetere che “i martiri
delle foibe erano stati un errore sia pure tragico, un eccesso nell’acceso
clima bellico, compiuto però dalle forze giuste…" Quando scrive
queste memorie si era in piena dissoluzione della Jugoslavia e lei ricorda
l'entusiasmo dei comunisti italiani per le riforme gorbacioviane, però afferma:
“rivivendo
le ansie passate, penso che i vecchi comunisti italiani farebbero meglio oggi a
tacere”.
Severa anche verso l’Italia che afferma “non
aver capito niente dei triestini". E riguardo al fascismo afferma
che “si posò sulla città come un coperchio che tuttavia lasciava respirare”.
Ricorda che ci fu l'invito (non l'obbligo) ad italianizzare i cognomi e ne
uscirono fuori i Paschi, i Manni, i Vasari, gli Zeno da radici ebraiche
tedesche slave. (Il mio cognome paterno è stato in origine Bresaugig di cui si
trova traccia al Castello di Lucinico). Ricorda che fu proibito il bilinguismo
e ricorda il “civismo" retaggio dell'Austria e di come a Trieste
avessero convissuto in pace tutti imparando a parlare triestino:
ebrei, greci (tutti ricchi), i serbi ortodossi più umili, gli sloveni, i croati
cattolici e i tedeschi della comunità evangelica. Tutto ciò implicava
un pluralismo di culti, il fiorire di chiese diverse. A Trieste si era respirato
civismo e pluralismo. "Però -commenta Laura- la lunga attesa dei
triestini per diventare italiani sembrò all’Italia, divenuta antieroica dopo la
sconfitta della guerra, come una specie di rigurgito nazionale fuori corso”.
Ci parla anche del confine di Sesana a 15
chilometri da Trieste, considerato un confine modello non a separare due mondi
ma ad unirli: “un paese socialista è in contatto fraterno con un altro
capitalista”. E spiega cosa sia questo contatto: “torme di jugoslavi cenciosi
emergono dal cuore più ignorato del loro paese per rifornirsi a Trieste di
merci dozzinali e vi corrisponde un fiotto di triestini che vanno a Sesana per
comperare carne e benzina a buon mercato”.
Conclude questa pagina amarissima con un “sono
tornata a Trieste per la sepoltura della mamma, morta a Roma, un cimitero ormai
assediato da case in cemento. Giusto che i vivi contendano lo spazio ai morti
ma io non tornerò più a Trieste”. Anch’io penso al dolore provato nel tornare
in quel cimitero così inglese con gli ampi viali fiancheggiati da cipressi
quando vidi all’ingresso tantissime tombe slovene (o di gente modesta), tutte
ornate da pacchianissimi fiori finti. Certo la morte ci rende tutti uguali ma
quella grazia di monumenti, di tombe di stile asburgico ora non c’è più e per
ritrovarla bisogna addentrarsi di nuovo lungo i viali.
Mi piace ancora ricordare alcune cose della
giovinezza di Laura: quando grazie a Ettore
Lo Gatto (Napoli 1890-Roma 1983) che introdusse lo studio della
slavistica all’Università e le dimostra fiducia, va come borsista a Praga
iniziando ad approfondire gli studi che la renderanno impareggiabile
conoscitrice della letteratura russa del 7/800. A Praga dopo le lezioni
scendeva nel piazzale davanti all’Università e lo percorreva varie volte di
corsa ma avvertita che la osservavano si astiene dal farlo. Era una “mula"
triestina, esuberante che aveva bisogno anche di scaldare i muscoli come si
dice.
Conosce il futuro marito Salvatore all’Università
di Padova quando voleva parlare con l’amico Gigi, che laureato in legge aveva
iniziato proprio a Padova la carriera universitaria ed aspirava a conquistare
il suo cuore. Ma proprio entrando in quella stanza di Gigi incontra Salvatore.
E’ amore a prima vista anche per le parole di lui che le chiede se sia libera
perché non vuole impegnarsi in qualcosa che potrebbe procurargli dolori. Lei
che doveva destreggiarsi tra un treno e l’altro per poter frequentare Padova da
Trieste, scrive: “ormai avevo preso la coincidenza per Satta”. L’amico Gigi sarà fatto prigioniero dai
tedeschi e morirà a Buchenwald. Ma cosa che ora sembra impossibile quando a
fine guerra attraverso l’Illustrazione Inglese Laura viene a
sapere dei lager attraverso foto inequivocabili commenta: “mai avremmo
immaginato”.
Ci sono alcuni episodi nel libro di grande tenerezza.
-Lei ha
rifiutato l’ennesimo pretendente (c''era chi la voleva solo come brava
mogliettina chiusa in casa e così via) e il padre la chiama e le dà della
“parassita". Insomma se lei rifiuta l’ennesimo buon matrimonio, allora si
mantenga da sé. Laura poco dopo incontra
Salvatore e contrariata
dall’incomprensione paterna, lo tratta bruscamente. Allora lui tira fuori un
piccolo fazzoletto in cui c'era una collanina di corallo rosa, un rosario di
filigrana e le chiede di tenerli come dono in quanto non penserebbe di poter
regalare quelle cose a lui care a nessun’altra.
Poi si spiegano, si sposano e a bordo di una topolino raggiungono Genova
dove è l’Università in cui Salvatore dovrà insegnare.
-
Altro tenero episodio è quando muore Vittorio, figlio di Angelo, fratello di Satta ed ingegnere che lavorava a Genova.
Vittorio aveva voluto diventare aviatore e viene abbattuto nei cieli di Parma.
Filippo, il piccolo bimbo primogenito di Laura e Salvatore quando loro ancora
non sanno né immaginano la notizia, alza gli occhi al cielo stellato e dice: “ho
visto la stella di Vittorio". Telepatia o forse è più che mai vero
come ha scritto Shakespeare che in cielo e in terra ci sono molte più cose che
l’uomo immagini.
A Genova hanno una bella casa in Corso Italia e
Laura e Salvatore passeggiano su quel lungomare come innamorati felici e
dimentichi di tutto, ma quando arrivano dal mare i bombardamenti degli inglesi
accettano l’offerta di Mario Scerni di andare alla Colombarola, sua proprietà
visino a Parma: offerta dovuta anche al fatto che le case vuote erano requisite
dai tedeschi. Di là però vengono confinati a vivere con i mezzadri quando
Scerni vi si trasferisce, avendo dovuto abbandonare sempre a causa dei tedeschi
il Castello di Bressanone dove viveva.
La convivenza risulta difficile e quindi si
trasferiscono nella proprietà dei Boschian a Pieris e di qui, quando insegna a
Trieste, Salvatore ogni mattina porta una bottiglia di latte fresco al suocero:
c’era stata infatti tra loro una vera intesa. Il padre di Laura era un uomo che
si era fatto da sé ed apprezzava questo genero colto gentile spiritoso che aveva abbandonato la Sardegna per
intraprendere la carriera universitaria.
Dei genovesi Laura ricorda alcuni nomi. Di un
amico, molto ricco ma che manteneva un tenore di vita del tutto modesto, quando
gli chiese “a che gli servisse la ricchezza", la risposa è stata: "so
che posso".
Dei genovesi Laura ricorda De Marini, allievo
prediletto di Bob (=Salvatore), che morì a trent’anni di asiatica e ricorda
il giurista Capograssi che ormai viveva a Roma ma con cui Bob era sempre
in contatto per una linea comune di pensiero, per una grande intesa spirituale.
Quando li riceveva nel suo studio sedeva con alle spalle le opere di
Sant’Agostino che chiamava “il Vescovo” e tutto il suo pensiero era dominato da
grandi figure religiose: Dante, Pascal, Manzoni. Anche lui muore all'improvviso
come il De Marini e i Satta si
ritrovano un po’ più soli.
Questo tema della morte domina anche quando a
Genova si ammala di meningite il loro
figlio maggiore Filippo e viene salvato, contro il parere infausto di
una altro luminare, da De Toni con una nova cura sperimentale.
Se la vita quotidiana è fatta anche di queste
grandi difficoltà, resta però intatto
il loro amore e Laura che è stata editorialista di russistica per quotidiani
come Il Gazzettino di Venezia, il Messaggero Veneto di Udine e Il Tempo di Roma, è anche riuscita a
conquistarsi la libera docenza a 52 anni. Laura traduceva perfino al capezzale
del marito quando lo assiste fino alla morte. Dirà che da allora si sentì
“orfana” perché se, ad esempio, "must" del giornalismo è “capire e
far capire”, in realtà sia che si scriva per gli altri e soprattutto nei
rapporti umani la cosa più importante è “esser capiti”, “esser accolti nel
cuore degli altri”.
Non solo, era così grande l’intesa tra Laura e Bob
che nella casa di Roma avevano due biblioteche a Fronte dietro le rispettive
scrivanie e in mezzo il tavolino del salotto con sopra una preziosa scatola
russa, laccata, di Palèch.
Concludo pensando al mio compagno Gino che è
riuscito a compiere questa buona opera di far pubblicare da Ilisso le memorie
della sua mamma. Lo ricordo al liceo come compagno gentile e sensibile. Scopro
nel libro che alle elementari il suo maestro pensava il suo cognome fosse da
modificare facendolo diventare Satana da Satta, tanto era vivace. Scopro sempre
nel libro che Gino verso la fine della seconda liceo quando appunto era ancora
mio compagno di classe ebbe un periodo di ribellione. Comunicò ai suoi genitori
che non voleva più andare a scuola e voleva fare o il sub (bellissimi i fondali
marini intorno a Genova) o diventare aviatore. I genitori si consultano e
quando arriva la notizia della sua faticata promozione gli regalano un viaggio a bordo della Maria Fausta una nave che andava fino in
Canada e, superata Montreal, fino ai Grandi Laghi. Per Gino è il toccasana,
torna tranquillo, più adulto e contento di sé.
A questo punto Laura ricorda anche la sua
esperienza scolastica ben descritta ad inizio libro quando viene iscritta alla
prima liceo della Dante e lì un simpatico professor Tivoli ebreo la fa spiegare
ai compagni facendola sedere sopra la cattedra. Minuta come doveva essere Laura
così poteva meglio farsi comprendere, ma mamma e nonna le dicono: “chissà come
sei sconveniente seduta là sopra”. Non solo, quando mamma va a parlare con
Tivoli e questo le dice: “la sua Lauretta, Signora, mi vuol davvero bene?” E’
probabile che lui volesse sondare se la ragazzina fosse felice di quelle
spiegazioni che le faceva impartire ai compagni seduta sopra la cattedra ma
mamma e nonna si turbano quasi fosse un pedofilo e la cambiano di scuola. La
mandano in un Istituto di Cultura per
signorine di buona famiglia, non tanto interessate alo studio quanto in attesa
di un buon matrimonio. Ma Laura lì segue anche i corsi pomeridiani di
Latino facoltativi nonostante anche in
famiglia le chiedessero “a che ti serve il latino?". Non le piacciono né
il ricamo né le lezioni di danza ritmica e vuole ricongiungersi ai suoi
compagni della Dante che stavano affrontando l’esame di terza. Passa tutta
l’estate sui libri e decide di fare insieme i due anni di quarta e quinta.
Quando si presenta all’esame è rimandata solo in latino e in matematica. Passa
una terza estate sui libri e riagguanta i suoi compagni di un tempo: si ritrova
in una classe di venti ragazzi con una sola compagna con cui stringerà grande
amicizia.
In quel liceo Laura ha come insegnante d'italiano
la medaglia d’ora Giani Stuparich, il cui fratello anche lui medaglia d’oro era
morto in guerra. Lei e la compagna lo trovano algido e severo però quando
leggono di lui la novella Un anno di
scuola e lo scoprono innamorato perso di Edda con cui s’incontrava sulle
alture di Chiadino in vista del mare, diventa “l’uomo ideale col fuoco
interiore”.
In quel liceo hanno anche l’ebreo Sabbadini, insegnante di greco e latino. Questi a volte
sbottava: "non si faccia in quest'aula propaganda di errori!" E di lei dice: "mi fa ridere la
Boschian, mi mette di buon umore anche se le sfuggono certi errori non ne fa
propaganda; è una brava ragazza!”
Riguardo quei suoi anni di studio lontani, ma da
volitiva, e riguardo la trovata di mandare Gino a bordo di quella nave perché
tornasse più uomo e meno ribelle conclude che non sempre le strada canoniche e
ben tracciate sono quelle che portano a migliori risultati. Non solo dato che
Laura ha scritto di grandi autori russi, diceva che per conoscere uno scrittore
bisogna munirsi di mappe e carte topografiche per contestualizzare il luogo
dove viveva e dove si era formato.
Questo libro, con un’ottima prefazione di Rita Giuliani, dovrebbe trovare un
regista come Victor Fleming di Via col vento (libro scritto da una
donna, Margaret Mitchell) capace di mettere in immagini questa saga familiare,
questo romanzo di formazione di una ragazza triestina nata nel 1913 che sembra
una forza della natura come la mitica Rossella.
Ancora un ricordo dal libro: quando alla Domenica
di Pasqua le campane di Trieste tornavano a suonare tutte insieme e le dominava tutte quella di San Giusto,
allora la nonna di Laura (nonna altolocata, rimasta presto vedova ma capace di
ricostruirsi una vita vendendo i suoi ricami e con cui la scrittrice ebbe un
intenso rapporto di ammirazione e comprensione) s’inginocchiava a pregare.

Parsunag’ e Mument’ du nostar Bobi
Mario Zerbarini
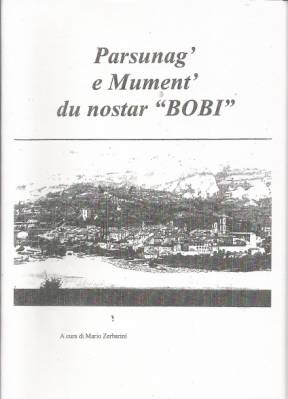
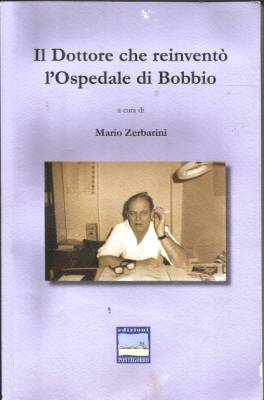
L’amico bobbiese di vecchia data, Mario Zerbarini (fondatore de
L’Assieme, associazione in cui ha ricordato tanti fatti di Bobbio e non solo,
autore del bel libro su Colombetti di cui ho allegato la cover e con Luigi
Pasquali del Nuovo Vocabolario Bobbiese
con ben 207786 parole e anche autore di una divertente commedia dialettale: S’ass pudiss metga ona pèssa di cui uscì
su Libertà di Piacenza un bell’articolo
dal titolo “Le amarezze di un ciabattino”)
mi raccontò una volta questo episodio.
Mia nonna da ragazzino gli dava qualche spicciolo perché
seguisse la sorella minore della mia mamma, la zia Zita, e il fidanzato Egidio
nelle loro passeggiate nei dintorni di Bobbio. E mi sono ricordata del
bellissimo film con John Wayne e Maureen O’Hara Un uomo tranquillo dove viene raccontata la stessa usanza, ma in
Irlanda. Zia Zita per parte sua era così timida che quando da ragazzina veniva
da noi a Genova al mare e mio padre pensò di regalarle un costume da bagno
rosso pianse perché non voleva indossarlo. E come conobbe lo zio Egidio? Quando
andò a Piacenza per vedere sui tabelloni esposti se avesse passato l’esame da
maestra. C’era riuscita ma compagne bobbiesi che erano state bocciate volevano
picchiarla e allora zio Egidio che veniva da una famiglia di artigiani e
intagliatori del legno ed era lui stesso bravo artista ma aveva voluto
diventare maestro dando anche lui quell’esame, la difese.
Non solo, a proposito di questo “primo lavoro" di Mario,
poi studioso di Bobbio in particolare ma anche editore per l’appunto della
rivista L’Assieme, mi ricordo altri ragazzi dei miei tempi o nati poco dopo che
si davano da fare per guadagnare qualche spicciolo come camerieri in bar e
ristoranti, come aiuto agli scaricatori in Porto, anche come dee jay ante
litteram, suonando nelle balere. Insomma italiani con tanta voglia di fare e
progredire e poi diventati anche importanti hanno sempre ricordato con
tenerezza e malinconia questi loro esordi.
Il librino di sole 36 pagine su Personaggi e momenti della
“nostra” Bobbio - Edizioni del Premio Letterario Internazionale Città di Bobbio
- è un gioiellino: elegante per il sapore d’epoca che si apprezza nel disegno il Borgo (collana “Bobbio una volta”) o
nella foto di Paola Fagnola U Blac,
soprannome di Natale Zerbarini ma anche
in altre immagini preziose come nella china di Giorgio Pipitone con Bobbio
vista dall’altra parte del Ponte Gobbo.
Il librino inizia con un disegno della professoressa
Pierantonia Larceri “U dacquadu" che ritrae il carretto che portava
l’acqua ed inizia con versi dialettali ad esprimere la gioia per i ragazzi di
bagnarsi i piedi quando esso arrivava nella via principale e c'è da subito
un'affettuosa precisazione: il cavallo che tirava il carro si chiamava Pino ma
Pino era anche il padrone che lo guidava. E talvolta scoppiava tra i ragazzini
un litigio perché uno diceva: <<tu mi hai fatto bagnare>>, l’altro
rispondeva <<no sei stato tu>> e la conclusione era la rissa
<<io ti rompo il muso>>. Riporto non in dialetto perché questo mi è
ostico e ritengo quasi una villania dell’amico Mario aver voluto scrivere il
testo senza traduzione, anzi ho dovuto farmi aiutare da mio marito (più duttile
di me) nella comprensione e mi è quasi sembrato di trovarmi nello stesso
affanno che mi procurò all’Università un breve corso di sanscrito. La data di
questi versi è il 7 maggio 1979.
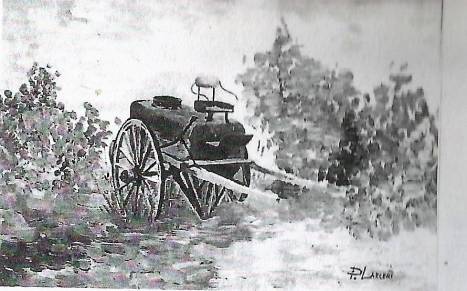
Il secondo racconto riguarda un signore Armelio, capitano
d’industria che veniva a Bobbio per riposarsi e un dialogo con Franco in cui
gli chiede come facciano a vivere al Poggiolo (al di là del Trebbia), così
eleganti e ben vestiti, Mario e tutta
la sua famiglia. Si scopre che a Bobbio si vive anche di caccia dei grilli
lungo il Trebbia: questi catturati vengono messi in gabbiette e i maschi hanno
delle sotto ali con una riga rossa mentre le femmine l’hanno cilestrina. I
grilli si riproducono e si vendono bene.
Segue nel terzo racconto una lite per una quercia di quasi
cento anni che "u Blac" (alias Natale Zerbarini) vuole tagliare per
farne legna. Questo caratteristico personaggio è citato anche nell’ultimo libro
di Sandro Ballerini (un altro bobbiese e trovate la mia recensione nella pagina
Amici cari del mio sito). La quercia
sorgeva vicino all’osteria della Micona, ma arriva in bici Peppino, di
tutt’altro avviso sul taglio, che vedendo lo scempio dell’albero fatto dal Blac
diventa “mezzo morto dal dispiacere”. E litigano…
Anche l’osteria della Micona è stata un nome cult per Bobbio e
i miei genitori da ragazzina mi portavano lì per acquistare uova e formaggio
genuino. Ora è stata abbattuta e vi hanno costruito un enorme condominio.
Non manca l’omaggio a Mentina Orsi, una donna nata il 4 ottobre
1907, che ha raggiunto i 99 anni quando questo il libro va in stampa e mamma
del bravo meccanico Gianni Ballerini, capace di far ripartire moto e auto che
sembravano aver esalato l’ultimo respiro. Questi versi pervasi di tenerezza
sono un evviva alle nonne, perché tale
era Mentina, ma a lei si sovrappone anche il ricordo della nonna
di Mario che qui si firma come “Malli ad Rampon”. Questo perché
Maria Aimé la bis-bis-bisnonna paterna,
nata a fine 1700, era vissuta per tutto l’Ottocento, arrivando a 102 anni e si
era sposata due volte. Il suo secondo marito era stato un militare francese di stanza a Bobbio, di
cognome Ramponne con cui poi lei si trasferì a Parigi per una dozzina d’anni
prima di tornare alla sua città natale dove appunto il cognome francese
veniva pronunciato “Rampon”.
Per me la parte più decifrabile del libro sono i capitoli
finali, dedicati ai cibi bobbiesi, vere eccellenze. S’inizia dalla polenta che
l’Autore ricorda cucinata dalla nonna in tre padelle come se a mangiare
dovessero ritrovarsi in trenta: in una la cucinava con il merluzzo, nell’altra
con il coniglio, nella terza con la lepre.
Anch’io ricordo la polenta fatta dalla sorella della mia nonna,
Maddalena Rolleri, al mulino del marito, cotta sul fuoco in un paiolo di rame e
per me è rimasto il piatto preferito della mia vita pur se non l’ho mai più
assaporata come la faceva lei.
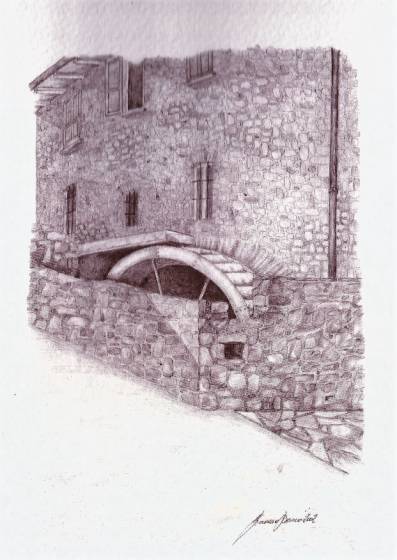
A me quella mitica
polenta piaceva con il latte e qui Mario descrive i modi in cui la condiva la
sua nonna: con il burro, con il formaggio, possibilmente il gorgonzola, e
piccola nota umoristica di quella polenta si era così golosi che qualcuno
finiva per bruciarsi le dita nell’addentarne le fette.
Seguono I Macaron
(maccheroni) e subito viene precisato che venivano preparati in tale quantità
come fossero mille le bocche che li avrebbero gustati e una piccola
precisazione ci ricorda che la pasta doveva essere molto molto sottile.
Anch’io rammento che quando mia madre impastava (e ho imparato
da lei) tirava la sfoglia alzandola tra le dita per assottigliarla e sembrava
che si dovesse vedere filtrare la luce attraverso essa.
In queste squisitezze d’antan si finisce con i Bustarne’ di nonna Carolina (le
caldarroste) e l’ultima poesia ha un titolo molto esplicativo dopo quanto
abbiamo “assaporato” mentalmente attraverso questa pagina “Pass par Bobi…e
g’avriss fam” dove Mario ricorda una volta che arrivò a Bobbio affamato e si
fermò alla trattoria-ristorante dei Cacciatori.
Pagina che però sta a significare per tutti: “a Bobbio si viene a mangiar
bene e quindi una volta arrivati si prova una dirompente fame di cose
buone". A quella trattoria con i miei genitori, arrivando da Genova a
Bobbio, era la sosta canonica prima di aprire casa. Vi s’incontrava Battista
(soprannominato Peppi, che già non era più al momento di queste pagine) e che
qui viene ricordato con affetto e nostalgia. Anzi il libro finisce con una
risata perché chi si fermava a desinare da Peppi (Battista) chiedeva vino
e ancora vino e pane fatto in casa e
tanta “buzèca” (trippa) da mangiarne fino a morire.
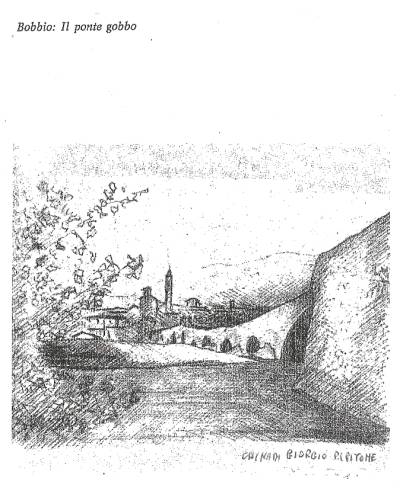
Storie Leggende e Tradizioni
tra
Occulto e Mistero
Alessandro Ballerini
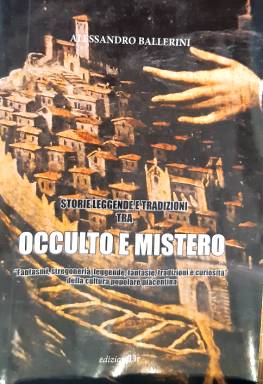
(La cover del libro è un particolare dell’antica
città di Bobbio, tratto da un quadro di San Bernardino opera del pittore
Salvatore Pozzo, esposto nella Chiesa della Madonnina dell’Aiuto a Bobbio).
Per capire questo libro bisogna partire da tre considerazioni
che vi sono contenute.
Per prima la frase di un anonimo poeta della steppa russa: “Un popolo, che non racconta più leggende, è
destinato a morire di freddo”.
Quindi la considerazione di Padre Amorth, capo esorcista della
Chiesa Cattolica, con nomina diretta dal Papa: “Il Diavolo a Piacenza ha fatto
cose che non ho mai visto in vita mia nei 163.000 esorcismi di cui mi sono
interessato e dare una spiegazione sull’accaduto è pressoché impossibile”.
E forse l’input per l’Autore a scrivere questa sua 33esima pubblicazione -e ne deriva la terza
considerazione- è il suo ricordo di Einstein “che avrebbe formulato la Teoria della Relatività proprio sotto il limpido cielo stellato della Val Trebbia”.
“Gli studiosi Mauro Casale (genovese) e Fiorenzo De Battisti
(pavese) affermano – come ricorda appunto Ballerini – che
Einstein abbia passato una nottata a Bobbio. Sostengono che in gioventù lo
scienziato abitasse a Pavia dove il padre era impegnato a installare la
pubblica illuminazione. Un giorno Albert decise di andare dallo zio a Nervi,
passando per ‘il grande itinerario di canale della cosiddetta Via del sale’ che
nel 1800 era ancora in uso. Quattro giorni di cammino e l’escursione viene
ricordata in una lettera in occasione del suo cinquantesimo compleanno, in cui
Einstein parla delle emozioni avute osservando il cielo stellato di Bobbio”.
Se questo ricordo dello scienziato segue al rammentarci che per Bobbio passarono altri illustri come
San
Francesco, Dante, Leonardo da Vinci, in realtà ciò che risalta riguardo
l’Autore stesso è la sua fascinazione per il cielo stellato di Bobbio. E
risalta l’amore, la devozione filiale che sente per questo luogo dove nacque (e
a Bobbio ha tuttora una casa) pur sentendosi anche piacentino d’adozione avendo
vissuto a Piacenza dal 1953 al 2000.
Anzi per meglio presentare l’Autore, Sandro per gli amici, mi
piace inserire alcune foto dal libro.





Queste foto sono un po’
la sintesi dell’uomo. C’è la sua esperienza di politico, nel 1986 assessore al Bilancio di Piacenza in quella
sfilata a Bobbio in contrada di Porta Nuova per la Festa degli Alpini, ma lo vediamo anche nella serata di musica fine degli anni ottanta con il M.o. Bruno
Morsia alla chitarra e Marilena Massarini che canta il motivo “Bobbi, l’è Bell”
Sandro infatti s’intende di musica ed ha composto molte canzoni
nostalgiche d’amore per la sua Bobbio. Poi le foto lo ritraggono con la madre,
con la moglie Anna e con la nipote Isabella
Non solo a fine libro riporta in dettaglio la sua biografia a
partire dallo Sport che lo ha viso valido atleta in diverse attività:
lanciatore e decatleta in atletica leggera come pugile della Salus
et Virtus dove nel 1963 partecipò
(squadra dell’Esercito ai campionati militari italiani con un ottimo
piazzamento…) Ma la sua carriera sportiva ha continuato in vari campi facendolo
apparire come un giovane desideroso di cimentarsi e molto eclettico e per
queste notizie rimando il lettore a fine libro.
Torno al nocciolo del testo quando per il capitolo “Le leggende” Sandro dichiara di voler
iniziare dalla Val Trebbia ed in particolare da Bobbio e in particolare
dall’Abbazia di San Colombano con quella frase che sovrasta l’ingresso “Terribilis est
locus iste” .Ricorda che tante sono le testimonianze storiche di
misteriose entità presenti all’interno di occulti sotterranei conosciuti e/o
sconosciuti della Basilica.
In realtà l’altra domenica alla Messa un giovane sacerdote
piacentino, don Diego, ha citato la scritta spiegando il terribilis come
“meraviglioso è questo luogo” Uscendo dalla Basilica si vede il millenario
maniero Malaspina-Dal Verme dove si dice si aggirino ombre o spiriti e si
sentano gemiti perché anticamente gli ospiti non graditi o i nemici catturati
venivano gettati nel “pozzo del taglio” che però anche in questo castello(e in
molti altri) non si sa dove sia. Non solo nel libro si parla anche di un
camminamento sotterraneo dove i nobili a cavallo andavano dal Castello
all’Abbazia.
Una leggenda bobbiese riguarda il ponte Gobbo o Vecchio o del
Diavolo. Lo fece costruire San Colombano promettendo al demonio la prima
creatura che vi avesse transitato e si trattò di un orso bianco poi ingentilito
e trasformato dalla fantasia popolare in un cagnolino bianco che ancora vi si
aggira in notti di plenilunio. Le 12 arcate del ponte per una lunghezza di 280
metri sono disuguali perché i diavoletti costruttori erano alti, gobbi, piccoli. Belzebù in queste storie
diventa fin simpatico in quanto sempre gabbato come nei famosi Sassi Neri che si trovano lungo la
strada da Bobbio al Monte Penice e che
furono lanciati da lui per ammazzare San Colombano e restano tuttora come
attestazione di una frana lavico-morenica. Lo stesso accadde al povero diavolo
all’orrido di Barberino dove sono presenti “neri profili di lava” e sarebbero diavoli scolpiti nelle rocce
lanciate da lui contro il Santo per impedirgli di andare a dormire nella sua
piccola grotta.
Il libro però non consta solo di leggende pur se alcune sono
davvero interessanti ma contiene molta storia con date precise: 1743 Bobbio
diventa Provincia, 1860 nasce la Provincia di Piacenza che riceve da Re Carlo
Alberto di Savoia il titolo di “Primogenita” dell’Unità d’Italia e che nel 1923
assorbe tre comuni: Sant’Antonio, San Lazzaro, Mortizza.
Sandro ricorda il primo stemma di Piacenza del 1281 arrivando
dopo sei varianti all’attuale (1938) sempre con i simboli del dado che secondo alcuni rappresenterebbe il
“qurterio” cioè la città con le sue mura oppure semplicemente una focaccia (che anticamente veniva chiamata
Placenta) e con la lupa che sta ad indicare la
città come antica colonia romana. Ma alla storia dello stemma segue quella
patriottica della Bandiera italiana ricordandoci che nacque grazie a Napoleone
il 15 maggio 1796.
Sandro non manca di riproporre le storiche maschere di
Piacenza: Tullèin Cuccalla e la Cesira, Vigion e la
Lureinsa.
Pregio del libro e della ricerca storica sono foto d’epoca e
foto degli splendidi castelli del piacentino. Ognuno narra storie di sangue per
tradimenti e di spiriti che ancora vi si aggirerebbero. Anzi Sandro cita il Medico Professor Bernocchi, già primario
del reparto di psichiatria dell’Ospedale di Piacenza che in materia ha
pubblicato un testo sulla sopravvivenza dei defunti. Volume scritto nel 1969 e
pubblicato dalla Utep di Bologna con titolo:“Prove
inconfutabili della reale sopravvivenza dei defunti”. Sandro stesso ricorda
di aver partecipato ad una seduta di spiritismo con la moglie Anna e altre tre
coppie di amici e la medium che veniva da fuori e quindi nulla sapeva riportò la voce di Fausto che diceva di aver
freddo e che chiamava la mamma. Non spiega per il lettore chi fosse Fausto però
è evidente la sua sorpresa e la sua riflessione dopo quell’esperienza.
Per tornare alle storie riportate molto interessante è la
vicenda dei Chiapparoli e dei tre mulini
che si trovano a distanza tra loro di non più di 500 metri ancora attivi negli
ultimi anni del ‘900: Erba Grassa, Ca’
dl’om fort e Bucca di Riv. Località che hanno un’origine
leggendaria in quanto tra il 1400 e il 1600 vi si stabilirono alcuni fratelli
dediti al banditismo e alla pirateria: veri e propri guerrieri combattenti
ingaggiati dai marchesi Malaspina di Pregola, su richiesta dei Doria (storici
Signori di Genova) per le loro battaglie come fossero “lavoratori stagionali”.
Però delle storie leggendarie raccontate ne estrapolo due: una
drammatica,l’altra divertente per finire con un sorriso ad esorcizzare i
fantasmi.
La stria ‘d Tursella, Rosa Poltini,
era una bella ragazza innamorata corrisposta di Alberto Leccacorvo, discendente da una delle più illustri
famiglie patrizie piacentine che per evitare la famigerata Coscrizione francese
si diede alla macchia in montagna. Ma in un confronto a fuoco con i francesi
Leccacorvo fu fulminato da un colpo di fucile. Rosa disperata viene ad abitare
a Piacenza in via Torricella in una casetta nei pressi della Cappella dei
Giustiziati. La si diceva capace di realizzare filtri magici d’amore o fatture
malefiche. Ad ogni esecuzione per un’impiccagione la si vedeva ritta in piedi
sulla finestra a guardare. Viveva ormai brutta e vecchia con un corvo ed un
gatto nero che poi si prese la rabbia e la morsicò facendola morire di
idrofobia. I vicini sentirono le sue urla strazianti per il dolore ma nessuno
la soccorse.
L’altra storia
si svolge a Cerignale. A fine ‘800 alcuni
abitanti del luogo avevano avvistato vicino al camposanto una figura bianca che
si lamentava: un fantasma. Il sacerdote della predica domenicale spiegò che
forse era un’anima dle purgatorio bisognosa di opere di bene, messe e
preghiere. Così le messe di suffragio aumentarono molto, ma alcuni cacciatori
chiesero al parroco di poter trascorrere la notte in canonica perché dal primo
piano si vedeva la zona di azione del fantasma. Volevano caricare i fucili con
pallottole caricate a sale. Se fosse stato qualche buontempone che si prendeva
gioco dei compaesani il sale gli avrebbe fatto bruciare gambe e sedere. Da
allora il fantasma non apparve più, però dopo un’abbondante bevuta un certo
Giuppin confessò agli amici di essere stato lui il fantasma e di essersi
accordato con il prete che così aveva più
introiti con le messe di
suffragio.
Non solo il tema dell’occulto che Sandro sviscera in questo
libro, ha in lui un “esperto” nel senso che negli anni ’90 presentò la commedia
in due atti “Al fantasma ‘d me muier” recitata dalla storica compagnia
filodrammatica “Turris” di Santa Maria in Torricella, diretta dal grande
regista piacentino Giorgio Brolli.
Quindi pur se di scorcio in questo finale di recensione potete
apprezzare un altro aspetto di successo di Sandro, autore di ben cinque
commedie dialettali tutte dirette dal Brolli.
Questo libro è molto vario e per lunga esperienza di scrittura
consta di capitoli brevi e ci racconta anche come nacque certe superstizioni
come che il passare sotto una scala porti male e altre, ma c’è anche una
testimonianza drammatica sulla trasmissione di pensiero. Sandro era a Teatro ma
pensava ad un amico a lui molto caro ricoverato in ospedale e di cui si diceva
fosse in miglioramento. Sente l’impulso di andarlo a trovare ed arriva quando
l’amico è appena deceduto: è come se questi lo avesse chiamato, gli avesse
mandato un ultimo saluto. E succede spesso che prima della morte nei pazienti
ricoverati si noti un’improvvisa ripresa…
Per concludere, ho solo sfiorato il tema della fede con la
burla contenuta nell’aneddoto del fantasma e del prete che ci guadagnava, ma
Alessandro Ballerini ha un così profondo senso religioso che ha voluto mettere
la foto della piacentina Basilica di Sant’Antonino in una foto proprio nel
cuore del libro che ne occupa due facciate con il massimo risalto.
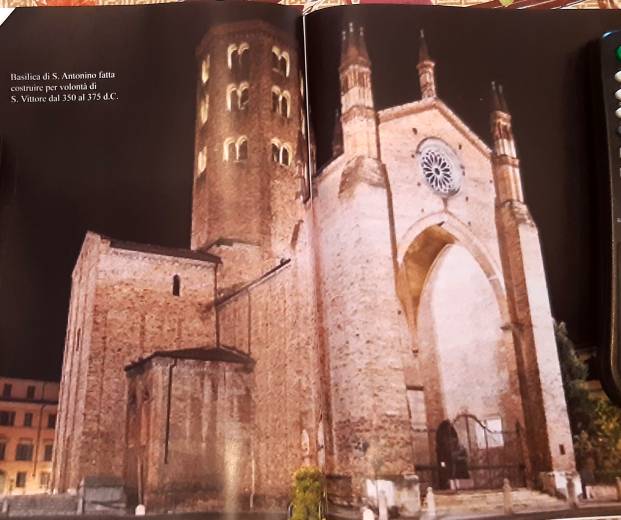
Amarcord e Saluto personale
Non penso che scriverò ancora recensioni e il mio
sito si chiuderebbe qui, però “ mai dire mai”, infatti è intervenuta la guerra
in Ucraina ed ho aggiunto la pagina “Guerra”.
Per il motivo del saluto personale allego una foto dei miei 19
anni al veglione di Capodanno al Possetto di Sestriere e di fianco una foto del
mio futuro marito ruzzolato nella neve durante una sciata ma sorridente. In
testa ho un cappello/cotillon di quelli che distribuivano.
Al Possetto la clientela era fissa e a quel veglione m’invitò a
ballare un arzillo vecchietto con diversi anni più dei miei genitori che era
l’anima della festa. Mio marito che avevo appena conosciuto a teatro a Genova
alla rappresentazione di Uomo e superuomo
di Shaw e gli avevo detto che saremmo andati con la mia famiglia in montagna a
Sestriere, ci accolse al nostro arrivo sulla porta del Possetto (lui alloggiava
ai Duchi) e partecipò anche lui al veglione. Si avvicinò all’arzillo vecchietto
e gli disse: <<vecchio mandrillo tieni giù le mani dalla mia ragazza (non
la ero ancora)>>. Seguì una risata ma fece un pochino più breccia nel mio
cuore quando durante una sciata lo vidi in questo ruzzolone, steso sulla neve
ma sorridente.

