INDICE
1) Ludovica Radif, Soldo Bifronte (Tilgher, 2004)
2) Annamaria De Marini, Emanuele Brignole e l’Albergo dei Poveri di
Genova (Termanini, 2016)
3) Claudio Papini, Marx 1969, Attualità e Inattualità del Pensiero di
K.H.Mark (De Ferrari, 2020)
4) Dino Frambati, Io volo (Termanini, 2020)
5) Claudio Papini, La Repubblica lungo il viale del suo tramonto (De
Ferrari 2020)
6) Giglio Reduzzi, Il declino del Parlamento (Suo blog su wix del
7/12/2020)
7) Martina Salvante, La paternità nell’Italia Fascista (Simboli,
esperienze e norme 1922-1943), (Viella 2020, dhi, Ricerche dell’Istituto
Storico Germanico di Roma).
8) A cura di Claudio Papini, Ezio Flori, Dell’Idea Imperiale di Dante,
(De Ferrari 2021)
Book Crossing
9) Charles Bukowski, Seduto sul bordo del letto, mi finisco una birra
nel buio,
(Edizioni
minimum fax,2002)
10)Trinh Xuan Thuan, La pienezza del
vuoto (dallo zero alla meccanica quantistica, tra scienza e spiritualità),
(Ponte alle Grazie, 2017)
11)Gianpaolo Benincasa, Einstein e il
Sasso – L’impossibile e la scienza (Mursia,2010)
12)Alan Lightman, L’universo accidentale
– Sette riflessioni cosmologiche sul mondo che credevi di conoscere, (Sironi
Editore 2017)
LUDOVICA RADIF
SOLDO BIFRONTE

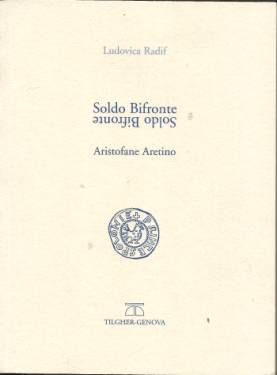
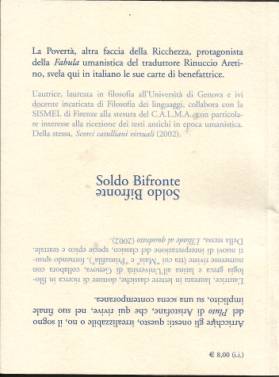

Ho intitolato
“I classici” la pagina del sito dove come prima recensione inserisco
questa mia del libro che la professoressa Ludovica Radif, nel 2004, mi mandò in
dono. Sono loro, I classici, ad insegnarci come si diventa uomini, sono
loro ad indicarci la strada tanto più che pur in epoche diverse l’uomo rimane
uguale a se stesso in coscienza, paure,
voglia di migliorare.
E inizio la pagina appunto con Soldo Bifronte di
Ludovica Radif.
Notate anche la dedica dell’Autrice con il mio nome
nel contorno di un immaginario soldo e
con al centro la sua firma come compare in apertura del piccolo, elegantissimo
libro pubblicato dalla raffinata editrice Tilgher: un particolare per farvi
capire la sua fantasia, la sua voglia d’invitare alla lettura con un sorriso
perché Radif è un’Autrice mai banale. La professoressa ha collezionato titoli
di studio e tanto, tanto sapere, ma appunto questa sua foto dove è in dialogo
con un'amica, una collega, ce la presenta com'è: moderna, simpatica, che sembra
invogliarci a parlare con Lei. Nessun distacco cattedratico da parte sua pur se
si è laureata all’Università di Genova in Filosofia (storia della Filosofia
Antica) nel 1993 e poi nel ‘96 in Lettere Classiche (Glottologia), conseguendo
il dottorato di Ricerca in Filologia greca e latina nel 2000. Dal 2002 è
docente a contratto, dal 2016 Ricercatore-Assistente specializzato e, da
allora, ha tenuto moltissimi corsi di Pragmatica, Sociologia della
Comunicazione, Linguistica generale, Filosofia e Teoria dei Linguaggi presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Genova. Le sue competenze linguistiche
spaziano dal Greco Moderno allo Spagnolo, all’Inglese. I suoi interessi vanno
dalla Filologia e Interlinguistica, alla riscoperta della commedia antica nel
Quattrocento e nel Cinquecento, dal codice alla scena. E’ esperta di tecniche
di traduzione e problemi d’adattamento del testo alle differenti epoche. Ha
avuto incarichi all’estero come sulla Commedia umanistica presso l'Università
Masarykova di Brno (Czech Republic).
Forse
pensate che potevo tralasciare di darvi tante notizie, da me reperite su
Internet, tanto più che da sempre sostengo sia il libro a dover parlare da sé
al di là di presentazioni, prefazioni ecc. Ho fatto un'eccezione per due
motivi: il primo che pur non avendo mai conosciuto di persona Ludovica, il suo
delizioso libretto mi è rimasto nella mente e nel cuore.
Nella vita ci sono dei debiti. I miei non sono mai
stati materiali, dato che fin da bambina m’insegnarono ad entrare in un negozio
per comprare solo se già avevo deciso cosa
e quanto spendere, ma sento debiti morali e sono fin molto più
pressanti.
Non ricordo a che giornali collaborassi nel 2004,
ma non sempre quando si è sotto padrone si può scrivere di ciò che si vuole.
Perciò ora che sono anziana consiglio a chi intraprende la professione del
giornalista di battersi fino a sopraffare il proprio caporedattore (colui che
decide cosa metterà in pagina) per proporre e scrivere proprio ciò che lui
stesso vuole, ciò in cui lui stesso
crede.
Non solo – e questo è il secondo motivo – Soldo
Bifronte mi ha portato anche un soffio di nostalgia: Sarei diventata così brava
come Ludovica se mi fossi fermata all’Università per migliorare la mia tesi? Me
lo aveva chiesto il mio correlatore Enrico Turolla che per la laurea ottenne
per me il 110 e lode e medaglia d’argento, ma non volli. Per un attimo,
leggendo Ludovica, ho visto campi sconfinati di sapere in cui addentrarmi, però
allora ero troppo attratta dal dar voce all’umanità degli altri cosa che ho
potuto fare con trent’anni di giornalismo. La mia vocazione è stata scrivere,
soprattutto scrivere per gli altri e degli altri (dimenticandomi della
banalissima me stessa). Non solo, dato che mi laureai in Lettere Classiche
all’Università di Genova nel 1965, se avessi continuato forse sarei stata
insegnante di un’allieva così dotata come Ludovica, laureatasi rispetto a me 28
anni dopo.
Ancora una piccola divagazione. L’elegante edizione
Tilgher del libro dell’Autrice (da allora ne ha scritti molti, molti altri), mi
ha riportato alla memoria la raffinatezza del negozio di porcellane fondato da
Luigi Radif, che dal 1820, da sette generazioni, continua ad abbellire via San
Lorenzo a Genova, dove tanti giovani di buon gusto e in procinto di sposarsi da
sempre decidono di fare la loro lista nozze. Però quando mi sposai io, - ero al
terzo anno d’Università e Turolla quando gli dissi che per quindici giorni di
quella lontana primavera non avrei potuto frequentare le lezioni perché mi
sposavo, commentò assorto “Povera bambina!” -, allora in quel lontano 1963 le
liste nozze erano ancora cosa quasi sconosciuta e non praticabile. Ogni dono
sarebbe stato ben accetto dagli sposi, anche il più orrido o improbabile, ma
comunque perché fatto con il cuore nel tempo sarebbe divenuto così caro da non
potersene più separare. Pensando al negozio Radif ritengo che come si dice “la
classe non è acqua”, lo stesso si può pensare per l’eleganza di scrittura e di
presentazione connaturata a Ludovica e pur se applicata a tutt'altro settore.
Ma bando ora alle nostalgie per ciò che poteva
essere e non è stato.
Inizio da una frase, che porta dritto nel cuore del
testo da lei tradotto e commentato. Le parole di Penia (la Povertà) rivolte a
Farfuglio ne La commedia della ricchezza (o il Pluto) di Aristofane: “Rispetto
a Pluto io li rendo migliori gli uomini, di mente e di aspetto. A contatto con
lui prendono la podagra e la pancia, hanno le gambe gonfie e sono schifosamente
grassi, vicino a me magri e sottili come vespe, e molesti con i nemici”.
Risposta scherzosa, ma non troppo, di Farfuglio:
"Con la fame, è probabile sì che tu procuri loro la vita da vespa!”
L’elegante sapienza di ricercatrice di Ludovica
risalta nella scelta di mettere a fronte il testo di Aristofane, ultimo fra le
commedie superstiti dell’autore e rappresentata nel 408 a.C., e poi nel 338 a.
C. , con il testo di Rinuccio Aretino che nel 1415-16, durante il suo soggiorno
a Creta, si accinse a tradurlo in latino.
La trama è presto raccontata: Cremilo (cioè
Farfuglio, il personaggio citato del dialogo con Penia) per poter dare un
futuro migliore al proprio figlio, va a consultare a Delfi l’oracolo per
eccellenza dell’antichità, Apollo. Il dio gli risponde di affiancarsi alla
prima persona che incontrerà e di non
lasciarla prima di averla convinta ad accompagnarlo a casa. Questa persona è il
dio Pluto (la ricchezza). La favola antica c’insegna da subito che Pluto, è
stato accecato da Zeus per invidia degli uomini onesti e di qui deriva
l’apparente ingiustizia della distribuzione del denaro. Dall’Aretino la sezione
del Pluto che corrisponde all’entrata e alla permanenza in scena della Povertà,
è stata chiamata Fabula Penia con un rovesciamento del nome del protagonista.
Attraverso l’Aretino, uomo dell’Umanesimo, abbiamo l’occasione per riflettere
sulla vera centralità della commedia, sospesa tra Povertà e Ricchezza.
Ci spiega Ludovica: “L’architettura narrativa
esposta nelle prime righe della Fabula (31-130) è da noi riutilizzata nelle sue
linee essenziali, come cornice per una nuova commedia dei soldi, sintesi delle
due”. Una tragicommedia, dunque e quant’è bello questo "noi" del
plurale maiestatis, naturale per me
dai tempi dell’Università e usato da me
talvolta in famiglia per darmi un po’ di tono, ma provocando solo sconcerto.
“Sei tu che parli o chi c’è con te?”, mi prendevano in giro marito e figli.
Tre i brevi capitoli del libro cioè la traduzione de La commedia della ricchezza di
Aristofane, La Tragicommedia dei soldi, La Commedia della Povertà di Rinuccio
Aretino. E l’idea sostenuta dall'Autrice è “una sostanziale natura bifronte del
denaro: visto da Aristofane, visto da Rinuccio; conquista attraverso il duro
lavoro o bottino di un furto, bene effimero o patrimonio duraturo,
Ricchezza-Povertà, Povertà-Ricchezza". E ancora: "Il soldo è una terminologia
ricca di storia e d'esperienza, che affonda le radici nell’idea di solido,
(oro) massiccio di romana ascendenza, e diviene comune in ambito europeo
all’epoca di Franchi e Longobardi, giungendo fino al secolo scorso a indicare
un sottomultiplo della lira, ma anche traslato ai giorni nostri come sinonimo
di denaro, ricchezza.
Delizioso!, e ricordando come possano essere
fulminei certi giudizi su di noi, ricevuti da persone che poco o niente ci
conoscono, mi colpì quello di un anziano ingegnere, collega di mio marito in
Ansaldo. Con sua moglie c’invitarono con altri amici a casa loro, una villetta in riviera. L’ingegnere mi disse
mentre conversavamo in un prato verdeggiante che circondava la casa: “Lei mi
sembra una fachira..." Aveva ragione, nella vita spesso mi comporto come
se il mio giaciglio fosse un immaginario e spartano letto di chiodi. Perciò il
bel soldo con intorno il mio nome - la dedica
insolita e preziosa di Ludovica Radif, premessa al suo antico dono - mi
fa pensare di me che appartengo a madama Povertà. Questa, Penia, divenne Pluto nella versione umanistica e,
non a caso, proprio in Aristofane c’è la distinzione tra povero e accattone.
“La vita di un mendicante è vivere senza aver nulla, mentre il regime del
povero è quello di risparmiare e portare avanti un’attività, senza che niente
gli avanzi, ma senza che niente gli manchi". Condivido!
Annamaria De Marini
Emanuele Brignole e L’Albergo dei
Poveri
di Genova
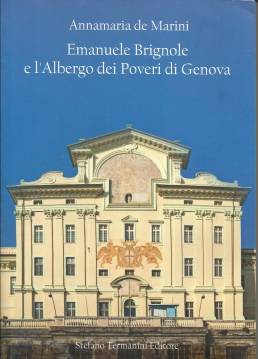
Un grazie alla professoressa Annamaria De Marini
che ha ripubblicato nel 2016 con Stefano Termanini un libro scritto 20 anni or
sono e la differenza è già evidente nei due titoli: con Termanini Emanuele Brignole e L’albergo di Poveri di Genova, con
Giuffrè, nel 2000, il titolo è stato L’Albergo
dei Poveri apre le porte all’Università. La nuova pubblicazione è ricca
d’importanti approfondimenti ed è incentrata
sulla figura e la famiglia di Emanuele, il lungimirante fondatore.
Termanini a Genova gode prestigio avendo tra
l’altro edito una monumentale opera sul cardinal Siri, tanto caro alla memoria
dei genovesi, e altri libri di genovesi cattedratici e non solo, però sempre
brillanti scrittori.
Questo testo ci ricorda l’importante Storia della
Carità in Genova. Non a caso la prima pagina riporta una lettera d’encomio da
parte del cardinal Angelo Bagnasco ed ha un’introduzione di Giovanni Toti,
presidente della Giunta Regionale della Liguria.
E’ singolare, ma non raro, come talvolta i nipoti
raccolgano - e lo vogliano fare con tutti se stessi – il massimo insegnamento
dei nonni e pur se Annamaria non conobbe il suo, questi è stato un medico
genovese, un luminare, che curava gratis chi non poteva permettersi di
contribuirgli adeguata parcella e per questo nell’Albaro bene di un tempo ebbe
molta stima.
In questo libro spicca la figura del fondatore
dell’Albergo, Emanuele Brignole, oggetto d’invidie così grandi che venne
accusato di aver troppo abbellito l’edificio con statue splendide e splendida
architettura senza però aver impiegato quei soldi nella vera carità per i
poveri.
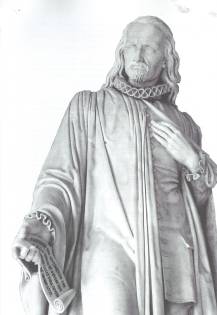
(Emanuele Brignole di Giuseppe Molinari, atrio superiore, 1857)
E dovette risponderne davanti al Senato e con tutta probabilità
in questa occasione padre Massimiliano Deza compose la famosa Difesa dell’Albergo dei Poveri che si va
edificando in Carbonara. Il Brignole rimase così colpito dalle accuse da
ammalarsi e farsi curare sotto il falso nome di Gabriele Mennuo. Annamaria
ricorda in proposito il libro del
prof. Paolo Moruzzi, Stanislao Omati da
Borgo San Donnino e il Signor Ipocondriaco, una disputa medica del Seicento
intorno al caso di un paziente illustre, in cui racconta nel dettaglio la
storia della depressione che colpì Emanuele dopo le accuse che gli furono
rivolte.
Noterei la differenza di comportamento tra il gentiluomo
Emanuele e i tanti facce-di-tolla che si aggirano inverecondi nella politica
nostrana, restando non solo indenni, anzi quasi corroborati dai disastri che
generano: tali politici continuano nelle loro stucchevoli passerelle come di
recente a Bergamo dove si sono recati tutti, ma a contagio finito.
Invece durante la costruzione dell’Albergo (1656-1835 con
aggiunte posteriori al 1835), Genova conta sei epidemie di peste nel solo
ventennio dal 1493 al 1510. Quella del 1493-94 fu così devastante da contare
5000 vittime, ma nel 1656 in un’altra terribile epidemia di peste, durata un
anno e mezzo, su una popolazione di 70mila abitanti i morti furono ben 50mila.
E’ il Seicento genovese un secolo di splendore
dell’architettura e delle arti con il filone della pittura legato al Barocco e
alla Controriforma (Bernardo Strozzi, Valerio Castelli, i Carlone, i Piola cui
si affiancano in quanto operarono per alcuni anni al soldo di committenti
genovesi Rubens e Van Dyck). Non solo, precedentemente durante la pestilenza
del 1524, fu inaugurato il Lazzaretto alla Foce in cui perse la vita a 54 anni
lo stesso Ettore Vernazza che lo aveva attuato. Nella pestilenza del 1493 era
entrato in contatto con la nobildonna genovese Caterina Fieschi Adorno (Santa
Caterina da Genova) e a seguito di questo incontro, per lui determinante nel
confermarsi nella sua opera caritativa, aveva fondato la Compagnia del Divino
Amore i cui adepti, appartenenti alle migliori famiglie genovesi, si chiamavano
Fratelli, operavano in segreto e con le loro ricchezze e nel loro tempo libero
realizzavano opere non solo di carità anche di respiro sociale ed economico.
Questa storia antica non manca di ricordarci quanto siamo fragili pur in
momenti storici di cosiddetto splendore come fu il Seicento per Genova.
Nel libro Annamaria ci ricorda che ad inizio di quel secolo, quasi a presagire un nuovo spirito,
mutò l’atteggiamento nei confronti del povero. Prima era considerato quasi
“sacro” nel senso che il sistema assistenziale ecclesiastico prevedeva per i
benestanti l’obbligo di soccorrere “il povero di Dio”, rappresentante di Cristo
in terra. La sua figura venne degradata e criminalizzata e si arrivò alla
scelta della reclusione, separando fisicamente i poveri dal resto della società
e mettendoli nei reclusori dove potevano svolgere lavori: il lavoro con la
preghiera li avrebbe redenti. Il primo reclusorio era sorto a Lione dove già
nel 1614 l’Ospedale di San Lorenzo era stato adibito ad accogliere i mendicanti
della città. A metà del Seicento Genova fu la prima a dotarsi di un proprio reclusorio,
cioè l’Albergo dei Poveri. Ma esperimenti di reclusione erano stati realizzati
in Olanda, Inghilterra e anche appunto in Italia, a Roma e Bologna e con il
Lazzaretto alla Foce, una delle soluzioni trovate per il pauperismo dilagante.
Quando i poveri entravano nell’Abergo erano divisi in uomini e
donne ed avviati ai laboratori dove veniva loro insegnato un mestiere.
Questo libro è un’affascinante Storia della Carità in Genova
con i nomi di Bartolomeo Bosco (che costruì il primo nucleo dell’Ospedale
Maggiore di Pammatone (una delle prime forme europee di ospedale civico), con
imprimatur della bolla Pia quaelibet
(1472) del ligure papa Sisto IV (Francesco della Rovere). Fu l’accorpamento in
un unico ente di tutti gli ospedali cittadini ad esclusione di San Lazzaro
riservato ai lebbrosi. Seguono in questa “esplosiva” storia genovese della
solidarietà i nomi di Caterina Fieschi, Ettore Vernazza, Gaetano di Tiene,
Virginia Centurione Bracelli, San Gerolamo Emiliani. C’è il ricordo anche degli
Ordini ospedalieri cavallereschi.
Una grande compassione suscita quel settore critico della
carità che riguarda gli “esposti” cioè i bimbi abbandonati che attraverso “la
ruota”, dove venivano lasciati, confluivano all’Ospedale di Pammatone. Ettore
Vernazza dispose che fossero accolti in appositi locali nei pressi del Ridotto
degli Incurabili in modo che protettori benestanti si occupassero della loro
istruzione: i maschietti venivano poi trasferiti in botteghe artigiane, la
bambine erano seguite da donne di onesta fama. Poi potevano abbracciare la vita
religiosa, sposarsi o restare per assistenza agli infermi presso l’Ospedale di
Pammatone. Se si sposavano i protettori le fornivano di dote. Grazie a Giovanni
Battista Salvago, uno dei Fratelli della Compagnia del Divino Amore, questi
bimbi abbandonati, cioè gli esposti, detti anche i “Putti spersi” ebbero una
loro sede in una villa nella zona del Bisagno.
Tornando al protagonista Emanuele, affascinante è la storia
della sua famiglia originaria di Val d’Aveto e il suo consolidarsi in fama e
ricchezza anche attraverso una politica oculata di matrimoni. Non a caso, il
pensare in grande di Emanuele volle dare un
nome appropriato all’Albergo che occupava ben 60mila metri quadri: “Reggia dei Poveri!”
Un libro da leggere e rileggere per entrare a fondo in quei due
secoli di crescita di Genova che iniziò a
declinare dopo il grave bombardamento del 1684 da parte della flotta
francese di Luigi XIV. La costruzione dell’Albergo durò appunto quasi due
secoli e durante la Grande peste del
1656-7 morirono anche Cristoforo Monsia, il direttore dei lavori e due degli
architetti, Girolamo Gandolfo e Giovanni Battista Ghisa.
E’ dunque anche una storia di
uomini e donne, coraggiosi e determinati, al di là delle proprie
fragilità umane (si pensi una volta di più a quanto soffrì anche fisicamente
Emanuele per le accuse che gli furono rivolte davanti al Senato).
La mia conclusione e molto accorata è che i politici moderni, i
nostri nuovi santi, si muovo solo a tempesta passata: non prendono nemmeno in
considerazione l’idea di poter essere contagiati in un’assistenza diretta:si
sentono troppo importanti e necessari.
Ora l’Albergo dei Poveri è in parte in uso all’Università di
Genova con parti destinate a sede delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze
politiche e vi sono progetti sia per la fruizione da parte del pubblico del
patrimonio artistico presente negli ambienti di rappresentanza sia per la
realizzazione di una nuova biblioteca con 250 posti a sedere e capienza per
100mila volumi e cinque nuove aule con un totale di 360 posti a sedere.
Ancora un elogio alla professoressa De Marini, oltre che per la
ricerca storica, per il suo stile chiaro, senza fronzoli o sbavature, che rende
la lettura di agevole e veloce
comprensione accrescendone l’interesse.
Un pregio del libro, dato che ormai abbiamo acquisito che le
immagini sono l’occhio della pagina, consiste
nelle foto d’epoca d’inizio del
Novecento: come il laboratorio di ricamo,
la
tipografia per l’insegnamento, la cucina a vapore, il refettorio dell’asilo
affollato da circa cento bambini. Quanto ai numeri, cosa assai importante, per
darci la dimensione dell’opera se gli assistiti registrati nel 1676 erano 971,
salgono a 1169 nel 1678 e a 1377 nel 1679. Tale crescita fu anche dovuta alla
carestia del 1678 che causò un’ondata di miseria e però i decessi nel 1679 per
epidemie interne furono di 218 persone oltre i 51 anni e nel 1693 morirono 150
bambini sotto i 10 anni.
E gli ignoranti del nostro tempo strepitano contro i tanti
decessi da covid 19 nelle strutture per anziani senza capire la logica di
quanto è avvenuto e che quasi certamente non si poteva evitare.
Una foto da segnalare per intensa bellezza è l’Immacolata
Concezione di Pierre Puget sull’altare maggiore nella Chiesa dell’Albergo, ma
un’altra di strepitosa bellezza è la veduta dall’alto dell’Aula Magna che
sembra una nave quasi a dover simbolicamente sfidare nuovi eventi calamitosi
perché la cultura è certo un modo per superare le avversità.
Infine nel retro di copertina è questo suggestivo Ritratto di
Emanuele Brignole, probabilmente ad opera di Giovanni Battista Merano, che è
nella sala delle adunanze dal 1678: il nobiluomo genovese indica sullo sfondo
la sua grande opera assistenziale: L’Albergo dei Poveri.
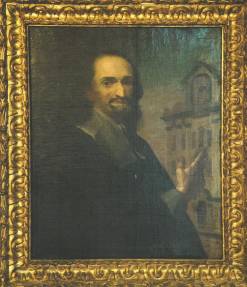
Claudio Papini
Marx 1968 V
Attualità e inattualità del pensiero di Carl
Marx

E’
arrivato anche il V libro su Marx del professor Claudio Papini, che dopo 25
anni d’insegnamento nei licei quasi sempre
classici, ora dirige la collana Amici
del Libero Pensiero per De Ferrari, Editore laureato in filosofia e quindi
meglio in grado di apprezzarne il valore.
La copertina è in stile pop art e strizza l’occhio alla celebre serigrafia su
Marilyn di Andy Warhol.

In breve la Pop
(= Popular Art) nacque nel Regno Unito e in USA tra fine anni’50 e inizio anni
’60. Gli artisti desideravano rappresentare oggetti della quotidianità e quando
Warhol, illustratore pubblicitario di successo, si entusiasmò alla stampa-serigrafia-fotografica e ritrasse
Marilyn era il 1962 l’anno della morte della diva, ma la foto apparteneva ad
una pubblicità del film Niagara del
1953.
Aria di novità
in contrasto con immagini più togate che Claudio Papini ha usato per le
precedenti copertine degli altri suoi 4 volumi su Marx. Potrebbe averlo fatto
per una reminiscenza inconsapevole oppure, con un pizzico di gogliardia, con
questa cover ha messo a confronto Marx, filosofo-icona e Marylin, struggente
icona di bellezza femminile. Marx/Marylin gran bella coppia!
In questo volume
Papini ricorda la sua tesi di laurea e
quelle di specializzazione su Karl Marx.
Nel primo volume
Marx 1968, edito come i quattro
successivi con un’elegante copertina nei colori del rosso e del nero, come per
gli scritti di Daniel Massé sull’origine delle religioni e in particolare della
nostra cristiana, che l’autore ha rivisitato,
Papini precisava proprio nella Nota
introduttiva di avervi voluto raccogliere, in occasione del bicentenario (2017) della
nascita del filosofo, tutti
gli scritti che lo riguardavano e che aveva composto tra il 1970 e il 1977.
“Questo perché Marx -e non per una mozione d’appoggio alle formazioni politiche
che si richiamano con maggior o minor sincerità e coerenza al suo pensiero!-
non è certo 'un cane morto’ – precisava -ma è da considerarsi ‘un classico’ per
i suoi testi: Il Manifesto del Partito
Comunista (scritto con Engels), Il
Capitale (Critica dell’economia politica), le Teorie sul plusvalore”.
In questo volume
che ha per titolo Attualità e inattualità
del pensiero di Karl Marx, solo a p.92 cioè alla metà del volume di 180
pagine, Papini ci spiega perché ha voluto scriverlo, con questa Avvertenza: “i due capitoli che seguono
(con le rispettive premesse) e la conclusione costituivano l’appendice alle
Tesi di perfezionamento in Filosofia ‘Sul
rapporto fra la filosofia e il pensiero di Karl Marx’, discussa nel maggio
1976. Si tratta dunque di pagine legate a quelle che rappresentavano uno
sviluppo e un approfondimento dell’originaria tesi di laurea”. Concludeva l’Avvertenza con una domanda “che cos’è
l’Italia?” per farci riflettere che “solo a questa nostra variegata totalità di significato va commisurata
ogni ideologia o teoria politica non autoctona”.
Il libro non è
di facile lettura pur se lo stile è chiarissimo.
Il libro è
complesso come lo è la riflessione sull’uomo e sul suo esistere perciò scelgo
di estrapolare dal contesto un pensiero di Giovanni Pico, conte della
Mirandola, nel suo De hominis dignitate. Papini
ne cita queste parole (p.23 in nota): “Dio accolse l’uomo come opera di natura
indefinita e postolo nel cuore del mondo così gli parlò: ‘Ti posi nel mezzo del
mondo perché di là meglio tu scorgessi tutto ciò che è nel mondo. Non ti ho
fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale perché di te stesso quasi
libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti
prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori, tu potrai, secondo il tuo
volere, rigenerarti nelle cose superiori che sono divine”. Parole improntate
allo spirito religioso rinascimentale però nelle pagine successive viene
approfondito il concetto di coscienza
con questa riflessione: “il processo storico-sociale che è costituito da un nesso triadico di individualità,
intersoggettività, oggettività articolandosi in questi tre momenti viene a
mostrare tutta la difficoltà che scaturisce da un suo possibile inquadramento
concettuale… Lo spazio del conoscere e del significare che risente dell’apporto
frammentario e organico della realtà dell’individuale, dell’intersoggettivo e
dell’oggettivo… non ci fa raggiungere facilmente l’unità organica di questi tre
momenti”.
Ancora con
parole del Professore: “per Marx la capacità di prevedere e d’ideare è un fatto
essenzialmente storico che riposa sullo sviluppo stesso, lunghissimo,
dell’azione, del fare per migliorare le condizioni della sopravvivenza”.
Continua
l’analisi: “come già in Feuerbach la dialettica sensibilità–sovrasensibilità si
risolve a tutto vantaggio della prima … Il pensiero non è secondo l’accezione
tradizionale della riflessione filosofica, un principio autonomo ma soltanto un
modo (nemmeno co-originario) nell’ambito del processo cosmico dove la storia
della natura e la storia dell’uomo si collegano in modo inscindibile…Di natura
sensibile è pure l’elemento stesso del pensiero perciò la realtà sociale della
natura, la Scienza umana della natura, la
Scienza naturale dell’uomo sono espressioni equivalenti”.
Mi sono
soffermata su queste parole per far capire il cuore di questo libro sul
pensiero di Marx.
Ma prima e dopo
c’è una carrellata su concetti fondamentali:
-bene economico che è il contrario di
bene libero. E i beni economici si dividono in beni di consumo per soddisfare
direttamente bisogni (cibo, vestiario) e beni di produzione (come gli utensili)
usati per produrre altri beni e quindi soddisfare indirettamente bisogni.
-lavoro come fondamento del valore
(divisione fra lavoro manuale ed intellettuale) e in corollario lo sfruttamento…
-economia politica
-le classi
Pagine
interessantissime sono costituite dall’analisi di Potere assoluto, Terrorismo.
Il Professore
precisa a questo riguardo: “Le realtà storiche in cui il potere
politico è di fatto (se non di diritto) assoluto sono purtroppo casi frequenti
ma eccezionali” e derivano “da un
disordine nell’ambito di un determinato ordinamento istituzionale”. “Ciò che ebbe a dire Goethe parlando dei suoi
connazionali e cioè che preferivano l’ingiustizia al disordine, può essersi
mostrata accentuata caratteristica in determinati periodi della storia
germanica”. Allo stesso modo “appena
comincia a salire l’onda del disordine, i meccanismi latenti nei gruppi sociali
che si sentono minacciati, cominciano a porsi in azione… Le ideologie del terrorismo (che non è solo ‘affaire’
di pochi) sono degenerazioni di una realtà nelle quali
una dottrina per determinate condizioni e circostanze storiche viene imposta come realtà di giudizio, come metro di valori
e il fatto che trovi
consenso mostra la tragica necessità che viene
a legare arbitrio, consenso e sudditanza”.
Quindi segue una
conclusione su “Autocomprensione" e "Realtà" che arriva giusto
alla pagina già citata con la domanda “cos’è l’Italia?”
Infine due
capitoli basilari: “Sulla società
cristiano-borghese” e “Sul problema
del crollo del sistema capitalistico”.
A p.147 un
illuminante parallelo tra Croce e Marx. Il primo (Croce) dà come avvenuto il
progresso tecnico e non ce lo spiega nel suo divenire, inoltre si sofferma
sulla devalorizzazione che il capitale subisce per effetto del progresso
tecnico. Ne consegue l’accrescersi del saggio di profitto e non la sua caduta.
Il secondo
(Marx) non ha mai trascurato la devalorizzazione del capitale derivante dal
progresso tecnico, ma lo ha concatenato come fenomeno interno al processo di
valorizzazione e che genera una posizione preferenziale per l’impresa
nell’ambito della concorrenza.
Seguono pagine
ardue su questo tema con citazioni da Smith e Bauer.
Però la
conclusione ci riporta al nucleo del discorso con queste parole “Marx ebbe a
disdegno qualsiasi accusa di idealismo e di messianismo, rivolta alla sua
concezione che considerava scientifica
senz’altro. Identificando sulla scia del pensiero di Feurbach, genere umano con
società, Marx fa oggetto della propria
indagine lo sviluppo e il funzionamento della società civile e afferma che
l’anatomia della società civile è da ricercare nell’economia politica.
Per concludere: “Scienza
della società, Scienza della storia ed Economia
politica (criticamente reimpostata secondo il pensiero di Marx) fanno
parte di quell’esteso territorio del sapere che oggi possiamo riconoscere, con
qualche forzatura, articolato nelle varie Scienze
sociali, nervature del sapere che ha per oggetto il macrocosmo Società.
Mi scuso innanzi
tutto con l’Autore, ma anche con i Lettori, per questa recensione che è andata
avanti a “colpi d’accetta” su pensieri e riflessioni molto, molto articolati e
profondi, cercando però di rendere il senso e il nesso del libro stesso.
Dino Frambati
Io volo
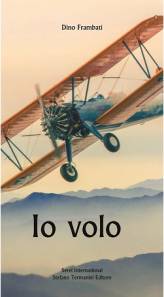
“Volo perché
volare t’insegna e ti costringe ad un ordine mentale rigoroso e t’insegna che
non si può e non si deve mai sbagliare” è questa la frase che meglio
rappresenta la passione per il volo del giornalista Dino Frambati. Io volo è il titolo del suo nuovo libro
per ora solo in ebook e in audiolibro, i cui agili capitoli sono da lui letti.
Alle spalle una
notevole carriera: storico corrispondente da Genova di radio Vaticana,
direttore di “Buongiorno” edito dal
Gruppo Sogegross, collaboratore de “Il
Piccolo” di Alessandria, responsabile delle comunicazioni Unicef Liguria,
corrispondente dal 1984 di “Avvenire”,
per 17 anni vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti ligure per cui ha
organizzato molti corsi formativi e sostiene che l’Ordine aveva bisogno di una
sveglia per non scaldarvi solo sedie.
Collaboratore de “il Giornale” di
Indro Montanelli quando nacquero le sue pagine genovesi. Ora è consigliere
dell’Ordine nazionale dei Giornalisti e fa parte del Centro Studi per
Giornalismo nelle scuole in ambito del Comitato Tecnico Scientifico.
Non solo
dell’Editore Stefano Termanini con cui ha già pubblicato Quando la notizia è buona, Il virus e il Direttore, dice scherzando
che questi lo definisce uno produttore “seriale”: ma questo splendido libro ci
insegna cos’è la fiamma di una passione e serve a distruggere nel lettore
pregiudizi e la paura del volo che tuttora affligge molti, me compresa.
Perdonate una
digressione: ricordo quando con i miei genitori andammo a trovare a Lecce alla
Scuola Allievi Ufficiali mio fratello che la stava ultimando e, partiti da
Roma, nel trasvolare l’Appennino, ci trovammo in un fortunale. I miei genitori
sedevano nei posti davanti a me, io dietro e al mio fianco c’era un signore.
Ero così spaventata che trovai un sacchetto infilato nella retina del sedile
davanti a me e lo rigiravo tra le mani per darmi un contegno. Il mio vicino si
alzò e, mentre l’aereo traballava e molto, si mise a passeggiare avanti e
indietro. Solo dopo scoprii che quel sacchetto doveva servire a chi fosse
assalito da un improvviso conato di vomito. Il mio vicino aveva creduto che
fosse la sua presenza ad inibirmi.
Però Dino ci
ricorda anche parole di un suo maestro di volo e di vita, Albino Ferretto,
collaudatore Piaggio: “il pilota che non ha paura, non è un buon pilota”. E
cita pure una massima aurea di Stanley Kubrick: “non sono mai stato sicuro che
la morale della storia di Icaro dovesse essere “non tentare di volare troppo in
alto, come viene intesa in genere, e mi sono chiesto se non si potesse
interpretare in modo diverso: dimentica la cera e le piume e costruisci ali più
solide”. “E oggi i moderni aeroplani - chiosa Dino quasi a fugare ogni paura–
hanno ali solidissime e strumentazioni eccezionali che impediscono persino
l’errore umano”. Non solo, quanto al
rischio di volare, da buon giornalista Dino non manca di portare la giusta
statistica: “l’aereo è il mezzo più sicuro. Mi pare avvenga un incidente ogni 5
milioni di ore di volo, ma per l’opinione pubblica l’aereo che cade, uno ogni
morte di Papa, è una catastrofe, mentre la strage di 5-6mila morti sulle strade
italiane pare essere nulla”.
Non solo,
portando un argomento inossidabile per convincerci, afferma: “superare la forza
di gravità è un momento psicologico che ti stravolge. In terra, in mare, ti
senti sicuro, in aria no. Ti senti instabile”,
ma nello stesso tempo ci rassicura sul pilota: “non deve mai sentirsi un
top gun, altrimenti è un pessimo pilota, ma deve avere sempre la massima umiltà
e consapevolezza”.
Però anche in
questo libro, nonostante la passione per il volo, c’è la descrizione di qualche
viaggio più che avventuroso. Come quello di Dino sul Pa30, bimotore dell’Aero
Club di Genova, quando porta con sé due signore e un ragazzo di 14 anni. Tutto
bello e tranquillo con una maliarda vista di Portofino, ma arriva inaspettata
una nube che li avvolge e non permette di vedere all’esterno. L’aereo inizia a
ballare e Dino sa che 300 m. sotto c’è il mare e bastano pochi secondi per
raggiungerlo. S’impegna mentalmente per uscire da quel fortunale e intanto
spiega ai passeggeri le sue manovre, rassicurandoli. Quando mancano 100 m. a
quota zero gli appare il mare increspato di Genova “mai tanto bello per me come
in quel momento”. L’atterraggio al piazzale Nord dell’Aero Club di Genova è
morbido. I passeggeri gli dicono “che non hanno mai avuto paura”. Lui però l’ha
avuta proprio per timore di non poter corrispondere alla loro fiducia.
Il libro è anche
una galleria interessantissima di piloti che Dino ha conosciuto e frequentato e
non manca, quando ci racconta di aver voluto prendere anche il brevetto per
idrovolante, di raccontare il suo incontro con Bud Spencer, pilota a sua volta,
che ne possedeva una flotta e la metteva a disposizione dei film che
interpretava.
Ci racconta pure
una storia esemplare dove l’aereo viene definito “suolo italiano” quindi
inviolabile quando il comandante Gianpietro Garbagna, 18mila ore di volo alle
spalle, atterra a Tunisi il 14 gennaio 2011 ed è il pomeriggio in cui scoppia
la cosiddetta “primavera araba”. “Evento –scrive Dino - che ha fatto
Gridare al mondo
degli evviva come dovesse diventare un altro mondo quello arabo, strano e
affascinante. L’evolversi dei fatti e la cronaca degli eventi hanno invece
dimostrato che è stato un inferno ed un
inverno più che stagione primaverile, e che ha dissestato gli equilibri di
quei bellissimi Paesi. Senza portar vantaggi”. Saggio questo giudizio critico
fuori dal coro di quei tanti, tantissimi evviva: e questo denota di per sé la
caratura del giornalista.
Di quel
pomeriggio all’aeroporto di Tunisi Garbagna racconta di aver fatto scendere i
passeggeri dall’Airbus 320 e sta per imbarcare quelli in partenza ma appena
questi sono saliti a bordo arriva un pulmino tra il fuggi fuggi del personale
di terra. Ne scendono quattro armati di mitra con sulla tuta la scritta
“Polizia” e dicono che devono controllare a bordo perciò deve far discendere
tutti. Garbagna obbedisce però nota che uno degli agenti saliti a bordo alza la
voce e malmena qualcuno, allora dice: “A bordo dell’Airbus è suolo italiano”, e
la frase serve da deterrente. Quando i quattro se ne vanno, i 123 passeggeri lo
supplicano: “portaci a casa, portaci a casa”, e ci sono bambini che piangono e qualcuno
degli adulti sanguina. Garbagna chiede l’immediato decollo e aggiunge per la
Farnesina:”se non mi mettono un blindato in pista, decollo”. Pochi secondi e
l’Airbus del volo OP 805 è in aria. All’arrivo a Malpensa è nebbia fitta ma
cos’è questo impedimento di routine rispetto a ciò che hanno passato? Poco dopo
il suo decollo a Tunisi è stato chiuso lo scalo e in pista c’era anche l’aereo
presidenziale in fuga.
Tra le vicende
ricordate da Dino, se questa è senz’altro la più drammatica, c’è pure il racconto
dei voli che servono a salvare vite, al trasporto di malati in sedi più
attrezzate e il pregio assoluto di questo libro è proprio che si sta con il
fiato sospeso senza mai annoiarsi. Una volta per descrivere un libro che ti
prendeva si usava una frase scontata: si legge tutto d’un fiato e questo è
proprio così.
Un aspetto non
manca mai di colpire chi legge Frambati la sua umanità, la sua sensibilità. Ed
ecco lo splendore della nostra terra: dal lago di Como (che gli fa ricordare il
suo amato Manzoni), allo svettare del Bianco definito “una delle creazioni più
belle della natura”), alla dorata Madonnina di Tortona (e quando la sorvola non
manca mai di rivolgerle una preghiera), ma anche i suo senso vivo degli
affetti: il ricordo indimenticabile della sua mamma sepolta a Novi Ligure,
l’amore l’intelligente moglie Marina che non ha mai ostacolato la sua passione
per il volo. Infine un’affermazione: “volare non è roba da ricchi, come
vorrebbe la leggenda metropolitana ricorrente e persino ignorante. Chi vola non
passa notti brave tra fumi di alcol
droga, ci tiene alla sua salute e sta bene non per una pasticca letale
ma piuttosto perché ama vedere il mondo
dall’alto. Il
volo è tecnica, scuola ma anche alto valore morale soprattutto per i giovani”.
E conclude: Il
volo è il futuro del mondo, augurandosi e augurandoci che l’Italia acquisti una
sensibilità moderna ed adeguata al
settore aviazione. La frase finale che ci comunica un po’ di adrenalina al di
là di ogni nostra paura è: “pronti al decollo in tutti i sensi della vita!”.
Con
l'editore abbiamo deciso il prezzo politico di 5 € per diffonderlo quanto più
possibile.
Questo il link per accedere ed acquistare, in allegato la copertina.
http://www.stefanotermaninieditore.it/portale/prodotto/dino-frambati-io-volo-ebook-audiolibro-2020/
Claudio Papini
La Repubblica
Lungo il viale del suo tramonto
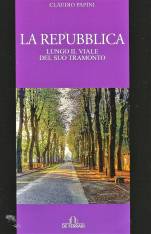
Avventurarsi
nella lettura dei libri del Professore richiede riflessione, leggere e
rileggere. Questo non perché lo stile e quanto esposto non siano più che chiari
ma perché la sua cultura si diversifica e approfondisce diversi campi: storia e
filosofia (che sono state le sue materie d’insegnamento per 33 anni), inserite
però in un contesto universale e quindi politico, ma anche economia e passione
per il cinema.
Non a caso è
stato il suo Ben ritrovato Ernst Ingmar, saggio sull’opera cinematografica di
Bergman, pubblicato con De Ferrari che ha fatto sì che fosse scelto
dall’editore – anche lui con interessi filosofici - per dirigere la collana
Amici del Libero Pensiero. In questa ben sette titoli sono per Daniel Massé ed
il primo è L’enigma di Gesù Cristo. Non a caso un altro interesse fondamentale
di Papini è per la Religione e l’importanza che “una Chiesa intrigante (per sua
specifica natura) sempre pronta ad intralciare l’attività politica dello Stato”
ha avuto nella storia italiana. Non a caso già nelle prime pagine del libro
(p.20) ricorre questo pensiero: “è fin troppo noto nella storia italiana che
gli interessi della Chiesa Cattolica
Apostolica Romana spesso non coincidano con quelli dell’Italia e il Risorgimento
(quello autentico) fu fatto certo (con l’aiuto dei dei Francesi e dei Prussiani
e l’appoggio dell’Inghilterra) contro la Santa Alleanza, contro l’Impero
Asburgico, contro lo Stato Pontificio (e anche contro gli altri sovrani molto
più fragili della Chiesa stessa).
E per venire al
momento attuale il Prof. definisce la Chiesa davvero matrigna verso l’Italia
perché con il pontificato del papa Francisco ha fatto intendere quali sacrifici
debba la nostra penisola in ossequio alle direttive delle Nazioni Unite e
dell’Europa guidate dall’asse franco-germanico.
Nel papato
odierno di Francisco s’inserisce anche la questione dei migranti su cui la
Chiesa mostra di scontrarsi decisamente con il sentimento dell’utilità nostra e
della nostra Patria, perché questa immigrazione “è una vera e propria invasione
in larga misura contrassegnata da caratteri religiosi”. L’accoglienza a tutto
campo batte sul senso di colpa che dobbiamo provare verso i fratelli
sfortunati, quel senso di colpa che fece sì che i cristianesimo (vendicatore di
Israele sotto messa anzi storicamente cancellata dei romani) penetrasse in Roma
nel momento delle invasioni barbariche, rendendola una propria suddita. Ma
giganteggia ancor oggi l’antico monito di Guicciardini di trovarsi sempre dalla
parte di chi vince per essere lodati anche di cose in cui non si è avuta parte
alcuna, mentre chi si trova dalla parte di chi perde è imputato di infinite
cose di cui non ha avuto colpa.
Ma per dare un
po’ d’ordine alla mia rivisitazione di questo libro di Papini, segnalo che il
primo capitolo ha come titolo Il mitico ’68 e con parole sue: “a cinquant’anni
di distanza dal mitico (si fa per dire) ’68 e 200 anni dalla nascita di Marx
resta non facile dire cosa sia stato nel profondo quell’anno (così
controverso)... I "reduci" (detto ironicamente di quel periodo
vorrebbero imporci i loro ricordi, ma reduci da cosa? Dalla propria giovinezza?
Senz’altro! …ed è difficile credere che Milano e Roma siano stati i due
maggiori centri dell’esplosione sessantottina”
Da subito però
nella sua rivisitazione di anni lontani Papini introduce la Cina, in cui la
rivoluzione culturale fu fenomeno prodotto dall’alto, chiamata alle armi dei
giovani da parte di Mao-Tze-Deng per contrastare i propri avversari nell’ambito
del Partito Comunista Cinese.
L’indagine del
Professore tocca argomenti italiani scomodi, esemplificandoli con titoli
ulceranti: “Cottarelli e i sette peccati capitali”, “l’inarrestabile
desertificazione industriale”, “Mattarella contro Paolo Savona (critico del
Trattato di Maastricht)”.
Si sofferma sulla
Organizzazioni non governative che ci hanno portato in casa sei milioni di
profughi e migranti economici, parte dei quali hanno avuto il diritto di
cittadinanza più che per volontà loro per impegno di forze politiche e governi
di centro-sinistra. E mentre le “ingenue" sardine strillavano in quel di
Bologna “accogliamoli tutti” e se si parlava di “invasione” si gridava al
“razzismo”, invece alcuni leaders aricani, senza false remore, dicevano
apertamente “invasione, sì invasione!”
Quanto alla
Chiesa definisce come “distillato di melassa" ciò che è l'attuale clima
francescano e che è venuto realizzando un ritornato ‘600.
Il Professore
spazia però a tutto raggio anche fuori dalla nostra terra e nei suoi rapporti
globali (Usa, politica filo-araba, Cina che Napoleone definì un gigante
addormentato che una volta vegliatosi avrebbe cambiato la storia del mondo),
ecc. E la Russia, citando il profetico libro
Sopravvivrà l’Unione Sovietica fino al
1984? di Andrei Amalrik. Quando nel marzo 1985 con l’arrivo di Gorbaciov,
vennero al pettine i nodi di quel continente “reso muto”: si cominciò a
promuovere trasparenza (glasnost) e
ristrutturazione (perestroika), ma
quel processo finì per travolgere in tre anni il Partito Comunista e l’Unione
Sovietica. E Amalrik che era stato profeta con un anticipo di qualche anno su
quella dissoluzione ha anche scritto: “i razzi sovietici hanno raggiunto
Venere, ma nel villaggio in cui vivo si fa ancora a mano la raccolta delle
patate”.
Questo il succo
amaro che il Professore trae dalla sua profonda indagine: “non stiamo vivendo
all’interno di un suggestivo film hollywoodiano, percorrendo appunto Il viale
del tramonto (Sunsetboulevard del 1950)
ma dovremmo reagire con la serietà e la severità necessarie pur se, oggi
come oggi, è arduo sparare in un risorgimento della Patria.
C’è anche una
pagina esemplare tra altre della stessa caratura, in cui in una lunga nota
ricostruisce retroscena storici sulla base di quanto ha denunciato Nino Galloni, docente universitario, manager
pubblico e alto dirigente di Stato, che insiste sulla necessità di archiviare
gli “specialisti del disastro” Angela Merkel e Mario Monti e rovesciando la
politica europea tornare alla sovranità monetaria, cancellando il debito
pubblico come problema. E ricorda sulla base di quegli scritti Andreotti che
temeva la riunificazione tedesca, non per “provincialismo storico” ma per la
coscienza di un sottofondo reale, cioè “un piano contro l’Italia” che portò al
rovesciamento del Trattato di Maastricht, concorrendo ad inguaiare un’Italia
sempre più indebolita. Maastricht infatti impone all’Italia un ulteriore aumento dell'avanzo che nel 1995 era di
15 miliardi, per la parte corrente della bilancia dei pagamenti con l’estero,
mentre consente alla Germania un disavanzo
(cioè l’opposto di quanto prescrive la logica economica). Quando crolla il muro
di Berlino, la Germania si è giocata la riunificazione a spese della
sopravvivenza dell’Italia come potenza industriale; ricattati dai Francesi per
riconquistare l’Est, i Tedeschi accettano di rinunciare la marco per aderire
all’Euro, a patto che il nuovo assetto europeo elimini dalla scena il lor
concorrente più pericoloso: noi.
Infine ci ricorda
come nei rapporti dell’Italia con l’Europa abbia pesato “un cattolicesimo che
vive in bello sposalizio cum sineristate (e quivi è perfetta letizia, frate
ovvero papa Francisco)”.
Tante le
riflessioni del libro e nona manca il pool di Mani Pulite, timoroso di dover
consgnare il governo del Paese alla Lega Nord e alle forze politiche di Destra
(“che pure erano escluse dall’area della ragguardevole corruzione che
affliggeva la Repubblica”) finì per graziare la Sinistra e ciò giovò a
Berlusconi quando nel 1994 scese in campo politico.
Il caso
Berlusconi, –scrive il Professore-, “marachelle” personali a parte è stato il
simbolo più significativo fino ai nostri giorni di una persecuzione giudiziaria
realizzata quasi esclusivamente per cause politiche.
Su questo libro,
così ricco di intelligenza, di cultura storia mondiale, ma anche di diagnosi
personali sugli avvenimenti che ci hanno accompagnato, si può essere d’accordo
o non sempre, però “la palla” ora è in campo e può passare ad altri per
confutare o approvare.
Poiché è indubbio
che stiamo vivendo un momento di decadenza della nostra Repubblica, allego qui
il mio commento – come sempre mettendo in risalto il pensiero dell’Autore più
che le mie personali convinzioni – ad uno scritto Il declino del Parlamento che
è molto in linea con i nostri mali denunciati da Claudio Papini.
Giglio Reduzzi
Saggista Politico
Il declino del Parlamento

In sintonia con
il precedente libro La Repubblica sul viale del tramonto è questo saggio che mi
piace riportare solo un poco in sintesi, perché la chiarezza di Giglio e la sua
mancanza di ridondanze è magistrale.
Inizia così
Reduzzi (e potete seguire il suo blog su wix):
“Tutti
citano
il 1968, considerato l’anno della rivoluzione dei costumi.
“Pochi parlano
del 2018, che
rivoluzionò la politica.
“Entrarono nel
Parlamento italiano i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle (M5S)fondato
da Beppe Grillo i cosiddetti ‘grillini’.
Fino ad allora i
deputati erano persone di una certa età, con lunga esperienza lavorativa,
invitati a metterla a disposizione della società entrando in Parlamento.
“Destra e
Sinistra vi mandavano i migliori, che fossero De Gasperi o
Togliatti (che ebbe appunto questo appellativo). Un onore avere un parente in
Parlamento ed io lo ebbi. C’erano anche giovani idealisti oltre ai portatori di
esperienza.
“I ‘grillin’ del
2018 (poco più che trentenni alla Camera, e poco più che quarantenni al
Senato)erano invece per lo più giovani in cerca di primo impiego. Appartenevano
però alla generazione che meglio smanetta su computer e così andarono a nozze a
presentare la propria candidatura sulla piattaforma telematica Rousseau ed ottennero un terzo
dei seggi disponibili.
“Quando dovevano
parlare erano proprio come noi bambini messi sulla sedia per recitare la
poesia. (Impagabile
l’umorismo di Giglio Reduzzi).
Ma per tal motivo
Grillo e Casaleggio, artefice della piattaforma telematica, proibirono loro di
concedere interviste.
“Quanto al reddito: se prima avevano un reddito medio di 1500 euro se lo trovarono decuplicato!
“Perché? Ricevono
15mila euro a
mese con tanti benefit che lo fanno lievitare a 20.000.
“Conseguenza: finché la vita di un esecutivo è legata a
persone che se andassero a casa guadagnerebbero un decimo di quanto ora
percepiscono, questa vita è assicurata.
“Non solo, il PD
che ama stare al potere ha nel M5S il partner ideale.
“Finché
l’indennità parlamentare sarà uguale per tutti, e non rapportata alle
esperienze precedenti come accade in ogni azienda o impresa, l’elettore non
potrà contare sulla fedeltà dei suoi eletti: a loro interessa solo la poltrona al di là di
ogni meta o programma.
“Lo stesso
Giuseppe Conte tornando al privato dovrebbe compiere una grave rinuncia sul
piano economico e gli mancherebbero anche tutti i suoi fringe benefit e i salamelecchi (che con
evidenza adora!!!).
(Per inciso: Conte ha dovuto andarsene ma appunto è già
rientrato in forza nei M5S e sembra che la politica per lui sia ormai
indispensabile!!!).
“Cosa ha inventato Conte pur di restare al posto di Premier?
1)
la task force, ricorrendo a tecnici esterni
all’Amministrazione dello Stato.
2)
Il DCPM per aggirare il Parlamento.
3)
La clausola ‘salvo intese’ a fine dei decreti per cui non si
dimetterà nel caso dovessero decidere altrimenti.
4)
La tecnica del rinvio (e al suo confronto il cunctator
Quinto Massimo è stato quasi un principiante o solo un apripista. Il peggio
–storicamente- può sempre avvenire, basta che la pista sia aperta).
Il Covid 19 è stata la Fatalità.
Avrebbe richiesto
il migliore dei governi possibile e giovani inesperti non sono stati
all’altezza.
Conclude
Giglio:
il 2018 è data indimenticabile perché quel massiccio ingresso in
Parlamento
d’inesperti ha mutato:
sia l’identikit del Deputato che svilito il ruolo
dell’Istituzione.
E –aggiungo-
come diceva l’indimenticabile Govi: “e io pago, io pago!"
Gli Italiani tutti stanno pagando, a carissimo prezzo, e
pagheranno non solo
i vecchi che muoiono come mosche ma soprattutto i nostri giovani,
cui si è
tolta perfino la speranza di quel “io speriamo che me la cavo”.
Martina Salvante
La paternità nell’Italia fascista
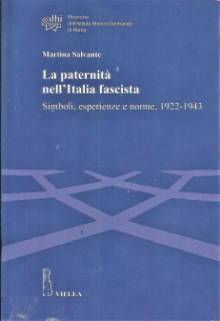
 (L’Autrice)
(L’Autrice)
Questo libro -
con copyright dell’Istituto Storico Germanico di Roma & Viella, Libreria
Editrice, (via delle Alpi 32, I-00198 Roma, tel.068417758)- a me sembra
indispensabile per capire il fascismo, per conoscere Mussolini, uomo ma anche Padre
della Patria come fu considerato.
L’autrice Martina Salvante,
di cui potete ammirare il bel volto serio, è Assistant Professor
of Twentieth-Century European History presso l'Università di Nottingham nel
Regno Unito. Ha conseguito il dottorato presso l’Istituto Universitario Europeo
ed è stata docente al Trinity College Dublin, all’Università degli Studi di
Firenze e all’University of Warwick.
La professoressa si occupa di fascismo, prima guerra
mondiale, storia delle disabilità e storia di genere e delle maschilità.
Un curriculum che
fa comprendere la sua preparazione ma che non può rendere in nessun modo il
piacere che si prova in questa lettura: chiara, ricca di spiegazioni però
sempre essenziali, documentata e affascinante.
Impariamo a
conoscere un Mussolini quasi inedito, che va cavallo a Villa Torlonia (in
quelli che definisce “anni indimenticabili”), che fa pedinare i figli per
capire chi frequentano, che si rammarica di non aver seguito abbastanza la sua
famiglia (“io
ero assente", ammette) e che soffre per la perdita del
figlio Bruno.
‹‹Parlo con Bruno›› è l’unico testo in cui Mussolini svelò
alcuni dettagli della propria vita in famiglia come ci spiega Salvante. Forse
Bruno seguì la carriera militare per cercare l’attenzione del padre, per non essere solo
suo figlio ma anche soldato del Duce. Bruno era il terzogenito,
fu aviatore, anzi a 17 anni il pilota militare più giovane d’Italia, poi anche
dirigente della compagnia aerea Ala Littoria e l’ideatore della LATI (linee
aeree transcontinentali con tratta Italia-Brasile); ebbe la medaglia d’Oro al
Valore Aeronautico e due volte quella d’Argento al Valor Militare, morì a soli
23 anni perché durante un volo di prova nei cieli di Pisa, i motori del suo
aereo militare in fase di atterraggio subirono un calo di potenza e si schiantò
in un campo di granoturco.
Il padre lo
ricorda così: <<Bruno!, Il mio Bruno! Brunone ti chiamavo quando ti accarezzavo con
violenza i capelli>> e
commenta che il figlio avrebbe certo preferito una morte in combattimento.
Da subito però in
queste pagine Salvante ricorda pure la relazione del Duce con Ida Dalser e la
nascita del figlio Benito Albino. Il commento della storica è che tali vicende
parallele al matrimonio erano frequenti nella società dell’epoca. La vicenda è
stata ripresa dal regista bobbiese Marco Bellocchio (che iniziò al Centro
sperimentale di cinematografia di Roma sotto la guida di Andrea Camilleri) nel
film del 2009 <<Vincere>>. Il regista mise in luce i reiterati e
disperati tentativi della Dalser di veder riconosciuta la paternità del figlio
da parte del Duce finché non venne dichiarata “malata di mente”.
Ma se questi sono
stati alcuni risvolti della vita del Duce, una parte molto avvincente del libro
riguarda i suoi genitori. Il padre Alessandro proveniva da una famiglia di
piccoli proprietari terrieri danneggiati dalla crisi agraria di fine Ottocento,
faceva il fabbro e si avvicinò al socialismo internazionalista diffusosi nelle
campagne dell’Emilia Romagna; la madre Rosa Maltoni era una pia maestra
romagnola.
Scrisse di lei
enfaticamente Carlo Delcroix, scrittore e politico: <<La casa del fabbro ebbe la sua Madonna e
quelle mura videro la sua pietà ma non seppero il suo strazio ed ella si affinò
nelle mani e si asciugò nel volto senza dar segni di stanchezza>>.
La letteratura
agiografica mussoliniana andò equiparando la famiglia del Duce alla sacra
famiglia biblica che la stampa cattolica proponeva come esemplare.
Per non farla
troppo lunga nel seguire il cammino delle leggi a favore della famiglia, i
rapporti con il Vaticano che furono buoni, mi appello a parole della stessa
Autrice quando in un capitolo finale <<Epilogo. Continuità>> ripercorre ciò che ha incluso e scandagliato
nei VII capitoli precedenti.
- Nel II ha
trattato i modelli familiari proposti dalla Chiesa cattolica attraverso le
encicliche papali ed altre pubblicazioni;
- nel III le
conseguenze della partecipazione bellica sull’assetto familiare; - nel IV ha
esaminato i cambiamenti introdotti dal regime nel regolamentare i rapporti
familiari con la riforma dei Codici Penale e Civile;
- nel V le forme
di censura <<feroce>> contro quelle maschilità considerate <<nocive>> e spesso quindi
destinate al confino(oppositori politici, coloni italiani che allacciavano
rapporti con donne autoctone, ebrei).
Da notare che era
intervenuta la conquista dell’Eritrea, ampia quattro volte l’Italia. Il confino
era in sette isole più la località Pisticci in provincia di Matera. Ad esempio,
il giornalista Giovanni Ansaldo fu confinato a Lipari e quando tornò in libertà
continuò a pubblicare sul <<Lavoro>> di Genova con lo pseudonimo Stella Nera.
Ma il racconto è
arricchito da storie umane e reali come la preoccupazione di un padre di
Trieste per la lontananza dalla sua bimba. Non solo, Mussolini era sentito come
un padre e a lui inviavano le richieste per togliere dal confino i propri cari.
Anzi queste erano mandate anche a membri della sua famiglia come la lettera di un
balilla al balilla Romano (altro figlio di Mussolini).
Non solo, Mussolini
proteggeva le madri nubili e qualcuno si adirò e il confinato
Giuliano M. fu fermato dalla polizia per aver pronunciato queste frasi: <<La colpa è di quel porco (Mussolini) che
protegge le puttane quando partoriscono>> e ancora <<quel mascalzone ha rovinato e sta rovinando
l’Italia>>.
Quanto ai
matrimoni con le autoctone dei luoghi dove si stava estendendo la
colonizzazione, sui giornali anni addietro uscirono articoli di esecrazione per
Montanelli, il principe dei nostri giornalisti, che in quei tempi lontani aveva
sposato un’eritrea di dodici anni. Giornalisti disinformati e pretestuosi, se
proprio in questo libro una testimonianza di uno dei numerosi italiani emigrati
nelle colonie africane in cerca di lavoro ci parla così: <<C’era una legge che proibiva la convivenza
con le nere, per proteggersi dalla malattie e per questione di prestigio, anche
se non era osservata. Si faceva tutto di nascosto. Nacquero anche dei figli, ma
non erano legittimi. Anch’io avevo una nera. La presi che aveva 13 anni, io ne
avevo più di 20, l’ho tenuta per due anni e poi l’ho lasciata. Era considerata come
donna di servizio ma la tenevo anche di notte, anche se non si poteva>>.
Ma questo libro
di approfondita ricerca per me ha un di più perché nel sottocapitolo <<Famiglie in guerra>> (a p. 97) vengono riportate parole di mio
padre Edgardo Bressani a mia madre Ida mentre era impegnato in Africa contro
gli Alleati: era
il febbraio del 1943.
E poiché questo è un libro sulla paternità ma
l’altra parte sono i figli è naturale commuoversi nell’affiorare di tanti
improvvisi ricordi e lo constatai anche per una figlia illustre: Maria
Gabriella di Savoia che era stata invita a Palazzo Ducale di Genova e le portai
ad autografare il primo dei due volumi sulla Storia di Casa Savoia che uscirono
nel 1955 in 400 copie e con la firma di Re Umberto. Gabriella mise la firma
sotto quella di suo padre commuovendosi e per me quei due volumi erano stati
importanti: li avevo chiesti in regalo a mio padre dopo l’esame di terza media
ritenendo che noi tutti italiani avessimo un debito con I Savoia che fecero
l’Unità d’Italia.
E queste parole di mio padre sono di un uomo
sposato e fedele che aveva messo la famiglia al centro della sua vita, che
partì per la guerra per senso del dovere e quando tornò nell’ottobre 1945 era
tutto fasciato causa un eczema diffuso dopo essere stato nel campo di prigionia
di Saida, tenuto dai francesi (e quindi male e ben diversamente da come stavano
i prigionieri di guerra presso gli inglesi). Per mangiare spesso mio padre e
altri compagni di prigionia si dedicavano alla caccia delle cavallette. Sul treno
del ritorno in patria per raggiungere mamma che aveva continuato a fare la
maestra elementare nei dintorni di Bobbio, un
controllore gli consigliò di togliersi la divisa perché i reduci non erano
amati. Sceso a Piacenza seppe solo
allora che era morta sua madre, nonna Gisella e che l’ultima volta l’aveva
vista a Trieste quando lo aveva accompagnato in stazione per partire per la
guerra.
Scrive mio padre:<<Non so perché Ida ma spesso in me affiora la disperazione.
Non vedo via d’uscita. E’ terribile. Terribile non per me, ma per te, per i
miei pupi che volevo rendere felici, sorreggere durante tutta la vita…Prega
tanto, Ida, Per me. E più grave è il pericolo, maggiore è il pensiero per te.
E’ in quei momenti che io ti ricordo con più intensità. Non mi si toglie la
vita, capisci, mi tolgono te, i miei bambini».
In nota questa
parole vengono riportate come prese dal mio libro Lettere d’amore e di guerra, giunto alla II
Edizione e pubblicato dalla Lint di Trieste. Ma il fascicolo
delle lettere dei miei genitori era stato tra i dieci finalisti al Premio
dell’Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano dove era stato messo in gara con
un romantico titolo scelto dagli esaminatori <<Tu sei per me l’aria che respiro>>, frase in una lettera di mio padre.
Allora mi chiesero
di poterne trarre un libro, però pensai che il compito toccava a me che meglio
avevo conosciuto i miei genitori. Comunque da quell’Archivio (era il 2002) erano
già uscite più di cento tesi universitarie. Donai le lettere dei
miei genitori all’Archivio stesso: ogni documento può servire ad altre
ricerche.
E il loro
ritrovamento era stato quasi inaspettato per me: quando era morto papà, Ottavio
suo uomo di fiducia che veniva a tagliare l’erba e a curare il vigneto nella
casa di campagna che aveva voluto costruire a Bobbio in onore alla mamma,
bobbiese, mi chiese: <<Cosa devo farne di questa cassetta militare di suo padre che lui aveva
carissima>>. Mio marito riuscì ad aprire il lucchetto e dentro c’erano legate in due
pacchetti le lettere di mio padre a mia madre e quelle di lei a lui, da quando
si erano conosciuti nel 1934 fino al 1945 al suo ritorno dalla guerra. Scusate
la lunga digressione personale, ma i padri coinvolgono anche i loro figli.
Il libro della
Salvante è da centellinare perché ricostruisce un quadro d’epoca molto
dettagliato ma in questa ricerca sul concetto di paternità mi piace concludere
con la voce di una donna.
Mussolini aveva
concepito una serie di misure per garantire il rinvigorimento della stirpe
italica e nel 1926 creò l’ONMI, un ente parastatale con ampia autonomia
amministrativa per la difesa e il miglioramento fisico e morale della razza. L’ente faceva le
veci del padre incoraggiando la formazione di nuclei familiari stabili e
legittimi. Si occupava pure del riconoscimento legale dei figli naturali, ma la
responsabilità dei padri di fronte all’abbandono fu raramente affrontata.
Insomma era una sorta di doppio binario o doppia morale come era il caso di
Mussolini con la Dalser e il figlio Albino pur essendo protettore delle madri
nubili. Una studiosa femminista Teresa Labriola, proprio dalle pagine del
bollettino ONMI, deprecò l’indegna noncuranza dei padri nei confronti dei figli
illegittimi in uno <<Stato di tipo maschile e quindi con diritti e doveri paterni>>.
A concludere riporto
il senso del libro con parole della Salvante: <<Quello che ho inteso fare è stato
de-naturalizzare la famiglia, mostrandone la varietà, non solo di forme, ma di
significati nel tempo e nello spazio. In particolare ho presentato i
significati che furono assegnati alla paternità in un preciso momento storico,
accostando simboli, esperienze e norme>>.
E concludo a mia
volta osservando che proprio le tante esperienze o storie umane riportate fanno
luce su quel periodo e ce lo fanno capire più a fondo.
A cura di Claudio Papini
Ezio Flori
Dell’Idea Imperiale di Dante
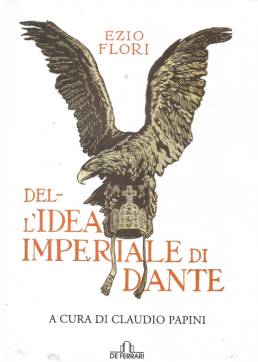
Nel 1921 Ezio
Flori pubblica a seicento anni dalla morte di Dante questo libro,nel 2021 a
settecento anni dalla morte, Claudio Papini commenta quel testo in una Introduzione dove la storia italiana
s’inserisce in quella europea. Scopriamo che Dante non solo fu costretto
all’esilio ma in successive epoche storiche, “durante la Riforma cattolica e la
Controriforma, fu considerato una sorta di ‘bestia nera’ pur non senza
resistenze – commenta il Professore - all’interno della Chiesa e delle élites
colte”.
Questo
ostracismo terminò sotto il pontificato di Leone XIII nel 1881 quando le
fortune del potere temporale della Chiesa erano tramontate e non risorsero
nemmeno alla fine della I guerra mondiale da cui l’Italia per “suo destino,
valore e sacrificio” uscì vittoriosa. Bastano queste parole virgolettate a far
capire la partecipazione ideale del professore ai nostri eventi storici ed è un
suo stile per renderci la storia
passata come la stessimo rivivendo.
Continua Papini:
“fu una felicissima conclusione del nostro Risorgimento, in parte modificata
dalla II guerra mondiale perché la sistemazione dell’Italia da parte dei
vincitori assicurò alla Democrazia Cristiana (emanazione filoccidentale –
U.S.A.- della Chiesa cattolica) il controllo maggioritario della nostra
penisola in coabitazione contrastata
con il Partito comunista (filorientale – U.R.S.S.).
Per tornare a
giudizi su Dante tratti dal libro di Flori colpisce questo di Giuseppe Mazzini:
“chi lo fa Guelfo, chi Ghibellino e quasi tutti lo vogliono cattolico
ortodosso. Ora Dante non era né Cattolico, né Guelfo, né Ghibellino: era
Cristiano ed Italiano”. Ma segue anche una frase lapidaria di Francesco
Lanzani, scrittore milanese su La
Monarchia di Dante del 1864: “è guelfo nel Comune, è ghibellino
nell’Italia, è monarchico nell’Umanità”. Non a caso per far capire il substrato
politico e filosofico della Commedia, seguendo il testo del Flori, il professor
Papini dà spazio a quell’opera del “vate” ad essa propedeutica.
Nell’Introduzione mi è sembrato molto
interessante “il sogno giudaico-cristiano di potere politico, cioè liberare
Israele dal dominio romano e impadronirsi dell’Impero”. La città che divenne
centro degli scontri tra popolazione ebrea e quella greca, fu Alessandria
d’Egitto. Sembra importante, riguardo quei tempi antichi, una frase di Louis
Rougier, che a Roma nel 1921 scrisse: “l’Impero romano d’Occidente è morto di
malattia interna e tra le malattie interne figura al primo posto la nuova fede:
il cristianesimo”. Non solo, se i culti ammessi nell’Impero furono tutti
considerati veri dal popolo, ma dal
filosofo come ugualmente falsi e dal magistrato come ugualmente utili, la
tolleranza manteneva la concordia. Perfino Cicerone, membro del Collegio degli
auguri, scrisse però il De Divinatione
dove stabilisce l’inesistenza della divinazione, pur riconoscendo la necessità
di conservare gli auguri per non turbare credenze popolari.
Su questo
substrato di tradizione s’innesta la Commedia di Dante che considerò “il
monarca come un magistrato supremo in una repubblica di più stati
indipendenti”, Dante per cui come per il Medioevo l’Impero era nella coscienza
comune “la pace”, il suo capo Imperator Pacificus e i Paesi del mondo erano
grandi feudi che i re tenevano da lui come principi feudatari, “debitori a lui
di omaggio, di fedeltà e di servizio militare contro gli infedeli”. La vita del
Nostro non fu certo pacifica pur se per lui l’Italia avrebbe dovuto formare il
centro dell’Impero universale, costituire essa stessa contro l’impero e di
fronte a questo uno Stato autonomo unitario. Come potete constatare ogni parola
ha un peso nelle lunghe contese che accompagnarono sia la formazione della
lingua italiana (grazie alla Commedia) sia nei rapporti politici e passarono
secoli prima di arrivare all’età moderna.
Non solo bella,
ma importante e doverosa questa ripresa da parte di Claudio Papini del testo
del Flori. Il professore non è mai solito ad esternazioni personali ma qui
ricorda come ad inizio del suo insegnamento dividesse il tempo tra questo e la
visita di Roma e della biblioteca della École de Rome al Palazzo Farnese. Dice
a questo riguardo: “andare alla scoperta in una nuova biblioteca è uno dei
regali dell’esistenza”.
E permettete un
ricordo personale di quando al Liceo D’Oria Piero Raimondi, mio prof. di
Lettere, e impareggiabile prefatore degli autori in lingua spagnola dei Nobel
della Utet, girava in classe come “una bestia nera” mutuata da Dante, nel senso
che reggeva alta la Divina Commedia passando tra i banchi e poi la apriva e
dove gli cadeva l’occhio interrogava tutti gli allievi il cui cognome iniziava
con la lettera che aveva visto per prima. E c’era un compagno chiacchierone che
per “penso” doveva portare una cantica di Dante a memoria (e non ricordo quanto
ne abbia collezionate), ma poiché non è più lo immagino nell’al di là seduto ai
piedi di Dante a ripetergli i suoi indimenticabili versi con il Vate che lo
bacchetta se per caso sbaglia.
Da notare che il libro è stato da lui rinvenuto nella cabina
telefonica di piazza Tommaseo (book crossing)
BOOK CROSSING
C’è una bella
iniziativa che si chiama Book crossing e consiste nello scambio di libri in
punti fissi della città.
Dove vivo io, a
Nervi di Genova, proprio la biblioteca della zona, la Virgilio Brocchi, porta i
suoi libri in eccesso o presso la Gelateria Giumin (gelati squisiti: fatevi una
gita per gustarli!) o dove c’è una pensilina degli autobus davanti ai giardini
comunali di piazza Duca degli Abruzzi. In questo secondo luogo, al coperto,
ogni giorno quando passo lì davanti guardo i libri che sono a disposizione. Il
giorno dopo è difficile reperirli: sembra vadano a ruba. Mi sono informata e mi
hanno anche detto che un libraio del centro storico qualche sera passa per
farne incetta e rivenderli, ma ho anche chiesto ad una signora anziana: “E’
possibile che ci siano così tanti lettori accaniti e che i libri scompaiano nel
giro di poche ore. Non sarà qualche extracomunitario che viene a prenderli per
rivenderli come carta?" Risposta: "Non saprei, è possibile. So solo
che io li porto e mio marito mi segue per riprendersene qualcuno e così il
libro mi ritorna a casa”.
Comunque grazie
a questa intelligente iniziativa a casa mia sono arrivati questi tre libri
citati nell'Indice, che ho letto con grande interesse. Confesso che per ì poeti
"americani" come Bukowski mi ero fermata tanti anni or sono a Bob
Dylan che mi era piaciuto da subito moltissimo e avevo trovato conforto a
questa mia scelta d’anima in un’ottima professoressa di lettere nei licei
(commentava Dylan ai suoi allievi), mia coetanea e compagna in un’altra sezione
del Liceo D’Oria. Lei, Laura Dedone Bisio, è poi diventata anche
un’affascinante conferenziera in occasioni letterarie organizzate dal Municipio
IX Levante di Genova. Insieme abbiamo presentato alla Biblioteca Universitaria
di Genova, lunedì 23 aprile 2007, Diari ed Epistolari
di guerra (1934-1946): Laura ha parlato di Immagini
d'esilio di Antonio Mor (Grecia-Egitto-India), io ho commentato Il testamento del Capitano(Mio padre disperso
in Russia sul Don, 1942) di
Piero Gehddo, Giuseppe Benelli il mio Lettere d’amore e di
guerra, tratto dall'epistolario dei miei genitori (Edgardo ed
Ida Bressani – Trieste, Kairouan, Saida, Bobbio), già tra i dieci finalisti nel
2002 al Premio dei Diari di Pieve Santo Stefano (vicino ad AR, Toscana).
Quanto al
secondo e al terzo libro, arrivati con il book crossing a casa mia, cioè La pienezza del vuoto e Einstein e il Sasso,
hanno interessato soprattutto mio marito, ingegnere. Ne è rimasto affascinato e
quando è passato salutarci un suo
fratello minore, Peppi, dottore in economia e commercio, gli ha messo in mano
il primo dei due e lui si è appassionato alla lettura al punto che dopo la mia
recensione, mio marito ha deciso che glielo spedirà in modo che lo possa
“centellinare”. Questo mio cognato è stato da sempre un poco appassionato di libri,
soprattutto però dal lato commerciale, nel senso del come diffonderli e farli
acquistare. Ciò avvenne, grazie a lui, con The American Peoples
Encyclopedia (A modern reference Work, Grolier Incorporated -
New York, venti volumi più quelli di aggiornamento dal 1967 al 1975, uno per
annata).
Mio marito
l’acquisì perché proposta da suo fratello ed io allora, giovane sposa, piansi
perché era costosa e avevo già altre insigni enciclopedie in casa, Il grande dizionario enciclopedico della Utet
(XII volumi più la Cronologia universale, più sette Appendici) e, sempre della
Utet l’Enciclopedia universale dell’Arte
(XVI volumi). Però nel tempo ho ben apprezzato l’enciclopedia The American… in
quanto di agile consultazionee forse più dinamica delle mie.
Da sola io mio
sono regalata solo la Biblioteca Romantica
di Mondadori e I Nobel della Utet.
Quanto alla
Biblioteca Romantica trovo nell’ultima pagina di Guerra e Pace un nota
dell'editore Arnoldo Mondadori. Questi precisa che nella Nota di seguito alla
Certosa di Parma, primo volume della Biblioteca, pubblicato nel 1931, venivano
illustrati i criteri della scelta dei testi e delle traduzioni. La Nota
era di Giulio Antonio Borgese e conteneva il progetto d’insieme della
collana. Alcuni autori (pochi9 non venero poi pubblicati e Guerra e Pace e il
Don Chisciotte previsti in un vlume furono pubblicati in due: queste le sole
modifiche rispetto al progetto iniziale. La ristampa avvenne nel 1970. Acquisii
la collana grazie alla segnalazione sulla rivista Grazia cui mi abbonava zia
Pina e ne fui oltre modo lieta anche perché i libri erano accompagnati dagli
Ex-librise ne allego la riproduzione di uno intestato a Marisa Ferrero, mio
nome in famiglia e cognome da sposata, mentre poi per i miei scritti ho sempre
adottato il nome di battesimo e il cognome d’origine: Maria Luisa Bressani (mi
sembrava più in linea con i
miei studi pregressi e notate l’eleganza di questo ex-libris
come la carta avariata delle pubblicazioni che portavano sempre in apertura una
foto
dell'autore.
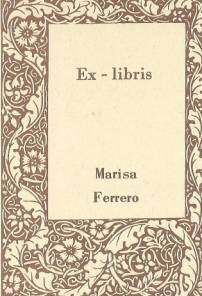
Ho anche un
biglietto da visita di un libraio, Bardini Libri, che l’autunno passato
esponeva in Galleria Mazzini I classici italiani, latini, greci e della scienza
(sempre editi Utet e a me regalati da mio padre) e se mai i miei nipoti non li
vorranno dato che i libri portano via spazio e comunque se sono tanti si
rischia di non leggerli come ho fatto io per
la maggior parte di questi, questo libraio sarebbe interessato ad
acquisirli. Altra soluzione, potrei far erigere con disposizione testamentaria
una gran pira di tutti questi libri e farmi bruciare lì sopra come usava in
India. Non so se i nostri crematori oltre al corpo accettino anche i libri:
penso proprio di no tanto più che ora sono al collasso per le tante vittime del
Covid 19.
Mi viene in
mente quando una volta da giornalista di quartiere ero andata per le scuole
locali per scriverne e mentre mi attardavo a prendere appunti, un bidello,
desideroso di chiudere al più presto, mi si avvicinò per dirmi, imitando
Carducci: "E scrive e scrive e ha poche altre virtù". Un modo per
farmi andar via al più presto ma anche un modo simpatico e da uomo che ricorda
ciò che a scuola gli hanno insegnato.
Bando alle
chiacchiere, ora torno alle mie recensioni e dopo queste scenderò nella cantina
comune del mio caseggiato dove c’è un armadietto che a suo tempo spostammo
dalla nostra per far spazio alle moto dei due figli maschi. In quell’armadio ci
sono I Classici stranieri della Utet libri
carissimi a mia madre che ereditai da lei e ne ho letto solo alcuni, trovandone
qualcuno molto, molto attuale pur se scritto molti anni prima. Intendo
completare questa pagina (il mio esteso libro
on line) con le recensioni a qualcuno di essi.
Charles Bukowski
Seduto sul bordo del letto mi finisco una
birra nel buio.
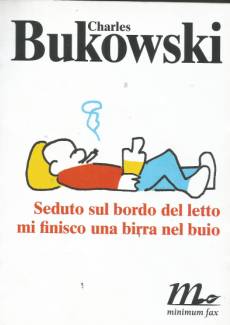
Non ho mai
amato i “ribelli", cioè coloro che pur avendo incontrato -come i tanti di
noi- le difficoltà della vita, di queste si fanno un vanto come
fossero degli incompresi. Penso, da sempre, che l’esser
ribelli paghi nel senso di notorietà, accoglienza o pentimento dei
tanti - i più - per non aver da subito individuato il “genio ribelle”.
Amo molto di
più, da sempre, coloro che faticano come tutti, giorno per giorno, ma non se ne
fanno un vanto, anzi ritengono che sia dovere d’Uomo.
Però ora che,
grazie al “book crossing”, ho scoperto Bukowski,
un po’ mi devo ricredere. In passato già ho molto amato Bob Dylan quando era
considerato solo “un ribelle", ho molto amato Leopardi, che a sua volta si
sentì incompreso e indirizzò tutta la sua poesia come la sua
“ribellione” e con infinita sensibilità, malinconia, umanità.
Credo che una
delle doti massime e incontrovertibili del Poeta sia la
“veggenza", cioè la dote di camminare avanti a noi anni luce. La prima
poesia di questi “Sotterranei 50” di Bukowski, è
intitolata "Il Mondo dello Spettacolo" ed inizia così:
"io non posso farcela/ e tu non puoi farcela/ e noi non/ ce la
faremo". Parole profetiche e in contrasto con i messaggi che vengono
diffusi durante la pandemia di Covid 19 (una delle tante che ha afflitto
l’umanità). I messaggi che ci propinano sono sempre: "tutti
insieme ce la faremo”, invece Bukowski sembra
avvertirci già allora e malinconicamente che “così non
è". Leggo ancora in modo metaforico questa prima poesia in cui il
poeta dice che l’unica cosa nelle nostre possibilità è “alzarci da letto ogni
mattina, vestirsi e poi salire in auto, felici nel constatare che questa non ti
è stata rubata e non ha le gomme sgonfie”. E “poi entri/dentro/ e se
lei/ parte – tu/ parti”. Ed è come un film ma dentro ci sei
tu. Continua: “e la più lunga/tenuta in sala/ in cui /puoi mai
sperare/è/ un solo/giorno”. Ecco ci ha descritto la nostra
vita ricordandoci la sua durata massima: “un solo giorno”. Sono passati forse
tanti, tanti anni da quando siamo venuti al mondo ma sembra ieri. Un attimo…
Nell’attuale
pandemia di Covid 19 alcuni sono stati multati, specie giovani, perché sono
saliti in auto dicendosi: “non contagiamo nessuno,andiamo solo in giro per
vedere com’è”. Quattro della Lombardia, dalla zona rossa, si sono spinti a
Recco per mangiare la focaccia al formaggio e sono stati multati. Così è questo
nostro giorno che corre veloce.
La seconda
poesia del libro sembra un divertissement del poeta e s’intitola “Tenebre & ghiaccio”. Anch’essa inizia
con un richiamo alla precarietà delle vita, quindi alla morte: “passo per
Westerm Avenue e guardo le lapidi/ piazzate per terra invece che all’impiedi
sul prato del cimitero:/la nostra dignitosa/modernità non vuole turbarci con le
cose definitive anche se poi/ paghiamo il 22% di interessi se compriamo con la
carta di credito…/ abbiamo bisogno dei nostri punti di riferimento (tipo i
cimiteri)/ abbiamo bisogno del nostro liquore e delle nostre responsabilità/
abbiamo bisogno di così tante cose di cui pensiamo di non aver bisogno”.
Il poeta sta
guidando verso la sede de Il Mondo è quadrato, una S.p.a.,
un’istituzione in ci s’incontra e si discute sul fatto che il mondo è quadrato
con il Polo Nord al centro a far sì che tutto non scivoli al di là
del margine.
Dice: “Il
MARGINE in realtà è un MURO DI TENEBRE E GHIACCIO”. Pensa che forse i
pianeti che crediamo rotondi sono illusioni e la luna e il sole in realtà sono
quadrati e si fa forza per entrare nel luogo del convegno sperando nel Polo
Nord che gli impedisca di cadere al di là della Curva o del Margine. Strana
questa poesia ma riflette l’ansia di entrare in un luogo dove forse o si fanno
chiacchiere “impegnate” o forse solo “da bar” e quella porta, che esita ad
aprire per entrare, potrebbe pure essere quella di casa al rientro serale
quanto la moglie può metterlo davanti alle proprie responsabilità. Potrebbe
anche essere un centro di ricupero per alcolisti dato che l’Autore aveva il
vizio di bere assai, ma ciò che colpisce e ci fa sentire uno con lui è la sua ansia da
cui qualcosa deve salvarci: Curva o Margine o Polo Nord, qualcosa
che non ci lasci cadere fuori, piombare nel vuoto, anche quello di noi stessi.
La terza poesia
è proprio dedicata alla Morte che però qui è un vero colpo di reni della vita e
s’intitola “La grande corsa.
Bukowski sta
andando in bici (una bici a dieci marce – e si sente il suo orgoglio nel
dirlo…) lungo il belvedere sul mare. Sente di avere il viso intenso come un
melone e sa che nello zaino ha una bibbia con un panino alla salsiccia e alla
mela rossa rossa. Pensa tra sé che la giovinezza è passata nel senso che mai
più bacerà una vergine. Ormai ha “faccia mal rasata e peli che fuoriescono dal
naso”. Pensa: “vado avanti/liscio liscio/ preparandomi alla tomba…" Poi
incontra un gruppo di ragazzi seduti nella loro decappottabile (che abisso
sociale con la sua bici…) ed uno commenta nel vederlo: “sapete chi era quello?”
“era? era?” l’Autore si scuote, non accetta di buon grado queste parole tombali
e grida di rimando: “ehi voi,/scorreggette rumorose!/ voi pezzi di/ cacche/ di
coniglio!" Quindi come spronato per fargliela vedere:
“metto la marcia/ alta,/ salgo su una collina/m'infilo in una macchia/ di
nebbia,/ le gambe/pompano e/ il/ mare/s'infrange..." Insomma respira di
nuovo a pieni polmoni lontano dall’annuncio di morte.
Entro però nel
cuore dell’artista, di ciò che lui pensa sia la sua creatività. La
poesia è “Tra una corsa e l’altra”. Un impiegato
dell'ufficio postale lo contatta come fanno quasi tutti, quelli ancora in cerca
di gloria, con i famosi: "so che non dovrei disturbarti..." Ruvida
risposta: "dici bene". L’altro gli spiega che ha passato la notte a
leggere un suo libro e vorrebbe intervistarlo. Risposta sempre ruvida: “sono stanco
delle interviste, non hanno niente a che fare con niente”. Replica
dell'altro: "guarda che l'intervista non è per il nostro giornale ma per
me che voglio uscirmene dall'ufficio postale". Bukowski: “devi solo prendere una sedia/
e sederti/davanti alla tua/ macchina da scrivere…” E quando l’altro
gli “toglie il disturbo”, di cattivo umore definisce
così tutti gli aspiranti scrittori: “non erano/abbastanza fuori/ di
testa/ da sedersi a una/macchina da scrivere/ e lasciare che le parole battano/
i tasti./
non volevano
scrivere
volevano
diventare
famosi
scrivendo.
In queste
parole c’è il suo credo d’artista e altrove parlerà del foglio bianco
appallottolato quando l’idea non arriva e le dita non fluiscono sui tasti, ma
ci parlerà anche del suo amico, il Budda, che gli tiene compagnia sullo scrittoio
e che è ormai così impolverato da fargli senire il bisogno di lavarlo. Hanno
sopportato tanto insieme in lunghe notti e sembra lo guardi con un sorriso: "sta
ridendo di questo schifo di vita”. Il Budda sembra dirgli: “perché
pulirmi, tanto mi sporcherò di nuovo” e ancora: “beviti il tuo
vino, che è quello che sai fare”. Poi l’amico torna
zitto. Il pensiero della morte prorompe come non mai nel ricordo
di Céline. Sulla parete della sua stanza ha una
foto di quest’altro scrittore “maledetto” come lui. “Ha un bastone e un cesto,
indossa un cappotto troppo pesante, è stremato dalla vita: i cani l’hanno
assalito e non ce l’ha fatta più”. E’ morto in questo 1988 – dice Bukowski - e ricordando
l’amico “tutti questi mesi li ho sentiti in modo tremendo come non mi era mai
capitato prima. Accendo una sigaretta e aspetto”.
Per lui la
morte arriva nel 1994 a Los Angeles, quindi a 73 anni che pochi non sono.
L’amicizia con Céline era iniziata quando gli aveva scritto una lettera
dopo aver letto il suo Viaggio al termine della
notte e lo definì un maledetto maestro che mi sussurra nella testa e che
lo aveva fato vergognare della sua pochezza. E ancora a chi gli
chiese perché gli fosse piaciuto così tanto rispose: “perché si è
tolto le viscere e ci ha riso sopra”.
Bukowski, nato nel 1920
in Germania, dove il padre svolgeva il servizio militare e dove conobbe la
madre, dopo la fine della Prima guerra mondiale, poiché l’economia tedesca era
al collasso, i suoi genitori si trasferirono con lui negli Stati Uniti. Lì era
nato suo padre poiché il nonno vi era emigrato negli anni ottanta
dell’Ottocento. Quanto al vino iniziò a bere a 13/14 anni e scrive: “se succede
qualcosa di brutto si beve per dimenticare, se succede qualcosa di bello si
beve per festeggiare, e se non succede niente si beve per far succedere
qualcosa”. Frequentò l’Università per due anni seguendo corsi di Arte,
Giornalismo e Letteratura. Fu disinteressato alla politica nel senso come
evidente da questo suo pensiero: “la differenza tra dittatura e democrazia è
che in democrazia prima si vota e poi si prendono ordini, in dittatura non
dobbiamo sprecare il nostro tempo andando a votare”.
Ha scritto sei
romanzi, centinaia di racconti e migliaia di poesie. A 24 anni il suo primo
racconto, ma non riuscendo a sfondare nel mondo letterario, per altri dieci
anni non mise giù una sola parola. Ottenne un lavoro come postino, ma dopo tre
anni si dimise, però nel 1960 ritornò a quell’ufficio come impiegato archivista
e vi restò per oltre dieci anni. Nel 1969 accettò una proposta dell’editore
John Martin della Black Sparrow che gli contribuì 100 dollari al mese purché si
dedicasse a scrivere a tempo pieno. Meno di un mese dopo pubblicò per lui Post office che gli
diede fama e perciò – riconoscente (dote rara)- pubblicò tutti i suoi altri
scritti sempre con questo editore. Nel 1988 si ammalò di Tbc ma continuò a
scrivere fino alla morte. Ultimo suo romanzo Pulp e il suo
funerale fu officiato da monaci buddisti, disciplina spirituale cui si era
avvicinato (ricordate il Budda sullo scrittoio, non era quindi a caso, ma del
tutto autobiografico). Ci ha lasciato questa massima: “La verità profonda per
fare qualunque cosa, per scrivere, per dipingere, sta nella semplicità. La vita
è profonda nella sua semplicità”. Finisco ancora con la
sua poesia “Sguazzare”:
“certe persone
sono così cretine che le senti sguazzare dentro la loro cretinaggine…
hanno quasi
tutti pezzi: mani, piedi, orecchie, gambe, gomiti, intestini, unghie, nasi e
così via
ma
non
c’è niente
lì
dentro
anche
se
sanno
parlare,
costruire
frasi –
…loro sono il
deposito di tutte le banali stupidaggini di cui si sono imbottiti e mi urta
guardarli, mi urta ascoltarli, vorrei correre a nascondermi, vorrei sfuggire
alla loro fagocitante inutilità…
…non
c’è film dell’orrore più brutto né omicidio così irrisolto
ma
il mondo va avanti e loro vanno avanti.
Concludo
sull’assoluta modernità del Poeta e scrittore Bukowski e non a caso la copertina di questa raccolta
di poesie, da me ora un poco commentata, porta una figura da cartone
animato che è un suo disegno, una sua elaborazione elettronica.
Se penso
all’Infinito di Leopardi immagino ascoltando i suoi versi un quadro
ottocentesco in tutto il suo splendore di paesaggio, ma il mondo cammina in
fretta e ogni Poeta coglie il colore del suo tempo.
E proprio per
concludere il poeta e uno dei suoi gatti (ai gatti dedicò anche una poesia
definendoli “suoi Maestri”).
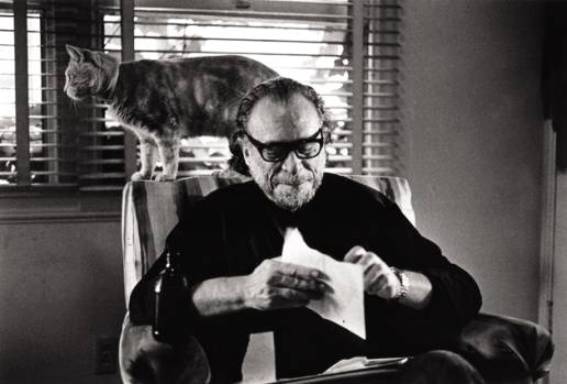
Trinh Xuan Thuan
La Pienezza del Vuoto
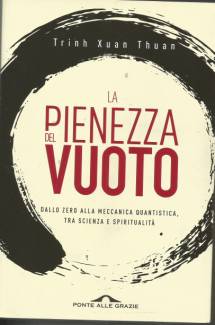
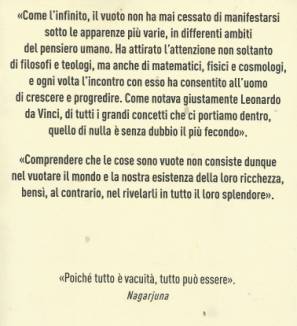
In via del tutto eccezionale dopo questo libro che
mi ha affascinata, facendomi capire tante cose sull’Universo e sull'Uomo
inserisco due foto dell'autore: una al suo scrittoio e una durante una
conferenza.
L’Autore, nato ad Hanoi nel 1948, ha studiato al
California Institute of Technology e lal’Università di Princeton, Insegna
astronomia all’Università della Virginia ed è ricercatore all’Institut
d’Astrophysique di Parigi. Ha ricevuto il premio Kalinga dell’Unesco nel 2009 e
il Prix Mondial Cino del Duca nel 2012 (www.trinhxuanthuan.fr)
Mi ha fatto capire con il libro che sto per
recensire quanto siamo provinciali culturalmente e capaci di credere l’Italia
che è nel “cortile” del Mediterraneo come tuttora al centro del mondo. Per
spiegarmi meglio vi prego di leggere sia questa recensione sia la successiva di
uno scienziato palermitano che ha lavorato al CERN di Ginevra: entrambi
sull’Universo arrivano più o meno in base alle più avanzate conoscenze attuali
alle stesse conclusioni, ma tra i due c’è una diversità abissale. Il vietnamita
di Hanoi dà spazio anche a ciò che è l’uomo nella sua essenza spirituale, il
palermitano si ferma alla Scienza come verbo incontrovertibile e come non ci
fosse altro al di là di essa.


La pienezza del vuoto
inizia con un capitolo intitolato “Il vuoto matematico” che nella prima pagina riporta una
definizione del dizionario Petit Larousse: “Uno spazio che non
contiene niente” o anche dal Dicionnaire culturel: “Uno spazio
che non è occupato dalla materia”. Definizioni entrambe profondamente in
contrasto con la sua dedica di questo libro che è alla memoria di genitori e
sorella, ma anche a chiunque sia alla ricerca di un vuoto fecondo.
L’Autore ci suggerisce di fare il vuoto nella
nostra mente giungendo alla conclusione che, dopo aver scartato tutto,
comprendiamo di dover smettere di muoverci, di agitarci, comprendiamo di “non
agire soltanto per fare, ma di agire anche per essere”. Ritrovimo così il vuoto
della piena consapevolezza e della “coscienza attenta”.
Da scienziato ci fa osservare che nel regno della
matematica il vuoto assume la forma della cifra zero e che questa parola trae
origine dal termine indiano sunya che significa vuoto o nulla,
parola che in arabo è diventata sifr, anch’essa con il significato
di “vuoto” e zephirum in latino dando origine al termine zero.
Ci ricorda che il pensiero matematico è nato dal
desiderio dell’uomo di contare gli oggetti che possedeva e che l’uomo si è
servito anche del suo corpo per contare. Non per incidervi tacche
(corrispondenti a numeri) come sulle ossa, sul legno o sulla pietra ma per far
corrispondere un numero a determinate parti del corpo. Le dita della mano sono
state associate al numero cinque e i cinesi hanno utilizzato un calcolo
digitale basato sulle dita delle due mani, mentre alcune tribù indiane
d’America utilizzano un sistema di numerazione a base 8 che è il numero totale
di intervalli tra le dieci dita. I Sumeri (la loro è una delle più antiche
numerazioni conosciute e risalente al 3000 a. C.) adottarono una base decimale,
ma anche una base 60 e ancor oggi usiamo quest’ultimo sistema per contare il
tempo: un’ora è di 60 minuti, un minuto di 60 secondi. Il sistema degli Egizi,
che si sviluppò circa alla stessa epoca e faceva ricorso a geroglifici,
utilizzò una serie di disegni.
La cosa da notare è che in tutti
questi sistemi lo zero è assente.
E’ stata la numerazione
posizionale a rendere necessario lo zero.
Prima dell’invenzione dello zero per calcolare si
usavano abachi, pallottolieri e i quipo (cordicelle intervallate da nodi, usate
dagli Incas a partire dal tredicesimo secolo, 1200/1300).
Vi sono stati tre zero nella storia della
matematica:
1) Con i Babilonesi,
nel 300 a.C. e con il sistema di
numerazione a base 60 (simile a quello dei Sumeri). Però compresero che ci
potevano essere ambiguità d’interpretazione in quanto rappresentavano lo zero
con un chiodo verticale e lo spazio delle migliaia, riservato al chiodo, era
solo più ampio di quello riservato ad esso nelle decine, per cui diventava
soggettivo interpretare questo spazio.
Perciò lo zero fu poi da loro rappresentato con un doppio chiodo
inclinato.
Due chiodi verticali che si susseguivano indicavano
61, due verticali separati di uno doppio chiodo inclinato rappresentavano 3601.
Ingegnosi!
2) Con i Maya compare
il secondo zero (500-925 d.C.). Usavano una numerazione a base 20 e una
separazione a forma di conchiglia indicava lo zero.
Questi zero babilonesi e maya svolgevano il ruolo
di marcatori di spazi vuoti.
3) Con i matematici
Indiani lo zero diventa numero. S’ispirarono al sistema
posizionale babilonese, da loro scoperto quando li aveva invasi Alessandro
Magno. Il loro zero è quello che utilizziamo ancor oggi e la parola sunya
(vuoto) appare per la prima volta in un trattato di cosmologia indiana
- 458 d. C. - scritto in sanscrito.
Aggiungendo nel V secolo d. C. lo zero e usando la
base decimale, la numerazione indiana segnava una nuova e decisiva tappa
posizionale ed è poi diventata la numerazione universale.
A questo punto l’Autore ci pone e
si pone una domanda: come mai lo zero è nato in India e non in Occidente
dove i Greci dal VI secolo a.C. al V d. C. avevano compiuto grandi progressi?
Spiegazione: Per
loro lo zero era come un anatema perché se si somma un numero a se stesso esso
cambia, mentre resta uguale se si aggiunge lo zero che si “rifiuta
ostinatamente di modificare tutti gli altri numeri”. La divisione per zero
porta in scena l’infinito, mentre se si divide qualsiasi numero per l’infinito si
ottiene zero. Al contrario nella coppia Yin (pieno) e Yang
(vuoto) lo zero e
l’infinito sono indissolubilmente legati.
Paradossi della filosofia greca come quello di
Zenone su Achille e la tartaruga (che l’eroe sfidandola in una gara di corsa
non può raggiungere) fanno sì che
perfino Aristotele ritenesse che lo zero fosse un concetto da tener lontano in
quanto entità che sfidava la ragione. Aristotele dominò la cultura del mondo
occidentale e l’Occidente bandì per venti secoli l’infinito e lo zero, mentre
così non fu in Oriente. Mentre il concetto di nulla e di vuoto non erano ben
accolti dall’Occidente, nella civiltà indiana il vuoto svolge un ruolo
importante nella religione induista. Il dio Siva rappresenta il vuoto supremo
che ha generato l’universo. Un libro Al-Hsab
al-Hindi, il cui autore, un matematico di Bagdad, al-Khuwarzmi
(vissuto tra il 780 –850 d.C.),
spiegava il funzionamento di numerazione indiano e si diffuse assai nel
mondo islamico. Gli scienziati arabi conoscevano le idee di Aristotele e la sua
avversione per lo zero e l’infinito però accettarono la concezione indiana
dello zero come rappresentazione del vuoto. Dopo tre secoli arrivò la prima traduzione latina del libro di al-Khuwarizmi, cioè
Algoritmi de numero indorum, diffondendo questa conoscenza del
calcolo indiano nell’Occidente cristiano. Nel 1277 l’arcivescovo di Parigi
Étienne Tempier decise di abolire alcune dottrine aristoteliche in contrasto
con l’idea di un Dio onnipotente e sdoganò il vuoto di cui da allora si parlò. Ci furono riluttanze come a Firenze
dove nel 1299 furono proibiti i numeri arabi perché con un semplice tratto di
penna lo 0 poteva esser convertito in 6, ma in Occidente si diffuse il termine
algoritmo per una serie finita di istruzioni che portano alla soluzione di un
problema.
Dopo questa affascinante ricostruzione del cammino
della numerazione decimale e con lo zero, da noi adottata, il secondo capitolo
spiega il perché di questa ostilità antica per il vuoto o il nulla o lo zero: “L’horror
vacui”. Trinh ci offre una splendida carrellata sul “miracolo greco”
che per otto secoli produsse menti speculative eccezionali con la convinzione
che doveva essere esistita una materia primordiale a partire dalla quale era
nato l’Universo, il Caos era diventato Cosmo quando vi aveva trionfato l’ordine
e il vuoto fece il suo ingresso ufficiale nella scienza con la nascita della
teoria atomista. Leucippo (circa 500 a.C.) fu il primo a formulare l’ipotesi
che la materia fosse composta di unità
fondamentali invisibili chiamate atomi (che
etimologicamente in greco significa “indivisibile”). Ma la voce di atomisti e stoici fu
sopraffatta da Platone e dal suo allievo Aristotele (384-322 a.C.) che
ripresero l’idea di Empedocle cioè che lo spazio dell’universo non fosse vuoto
ma immerso in una sostanza informe, l’etere,
che si aggiungeva ai quattro elementi: aria,acqua, terra,
fuoco, costitutivi dell’universo. Quello di Aristotele era un
universo finito con al centro la terra e codificò il principio dell’horror
vacui: “la natura ha paura del vuoto”. “L’universo non era stato creato, c’era
sempre stato ed avrebbe continuato ad esserci per l’eternità”, era un concetto
molto rassicurante.
Verso la fine del II secolo a.C. la Grecia fu
annessa all’Impero romano e i Romani erano poco inclini alle astrazioni e non
s’interessarono della cosmologia. Nel V e VI secolo le invasioni barbariche
diedero a Roma il colpo di grazia, la sapienza greca scomparve dall’Occidente,
il testimone della scienza passò ai califfi di Bagdad che tra il 750 e il 1000
fecero tradurre in arabo le grandi opere greche.
Nel mondo medievale il sapere divenne appannaggio
della Chiesa e i teologi cristiani sostenevano che Dio avesse creato il mondo
ex nihilo, dal nulla, facendolo passare dallo stato di inesistenza a quello di
esistenza. E alla domanda “Che cosa avesse fatto Dio prima di creare il
mondo?”, Sant’Agostino, aggirando il problema, rispondeva che Dio aveva creato
il tempo (e lo spazio) simultaneamente al mondo e quindi la domanda non aveva
senso perché il concetto di anteriorità non si poteva applicare prima della
creazione del tempo.
Nel sedicesimo secolo (il 500) la riscoperta del De rerum natura di Lucrezio, cantore e divulgatore
dell’atomismo, fece rinascere l’idea di uno spazio vuoto tra gli
atomi e Lucrezio celebra anche la pluralità dei mondi.
Tra Cinque/Seicento fu Galileo a riflettere sul
problema del vuoto…
Vengo però al punto fondamentale: circa 14milioni
di anni fa avvenne una spaventosa deflagrazione, il Big Bang che diede origine
al nostro universo. E’ stato nel 1929 che l’astronomo americano Edwin Hubble si
è accorto dell’espansione dell'Universo e se con un esperimento ideale
invertissimo il corso degli avvenimenti tutte le galassie si troverebbero nello
stesso istante nello stesso punto, ma con il Big Bang si è costituito un
universo dinamico in perpetua formazione, il cui movimento di espansione
trascina con sé galassie ferme.
Un fatto dobbiamo fissarci bene in testa: il Bang è
avvenuto nella quiete assoluta perché quando la materia non aveva ancora fatto
la sua comparsa non c’era mezzo che trasmettesse le onde sonore. Il film dei primordi è muto, senza suono.
L’Universo è stato plasmato da
quattro interazioni fondamentali: la
nucleare forte che tiene insieme protoni e neutroni, i “mattoni”
dei nuclei atomici; l'interazione elettromagnetica
per cui le cariche opposte si attraggono e quelle uguali si respingono (e le
molecole e la struttura a doppia elica del DNA dipendono tutte da essa); l’interazione nucleare debole che agisce come
un'anticolla ed è responsabile della disintegrazione della materia, processo
che si chiama radioattività (senza essa il Sole non produrrebbe energia per una
decina di miliardi di anni, ma vivrebbe pochi milioni di anni, cioè un battito
di ciglia nella storia cosmica); infine l’interazione
gravitazionale, mille miliardi di miliardi di miliardi di
miliardi (1039) più debole dell'elettromagnetica.
Poiché tuttora l’Universo è in espansione e il suo
spazio continua a rarefarsi e raffreddarsi, tutto ha avuto inizio da uno stato
di calore e densità elevatissimi concentrati in uno spazio infinitesimo, però
le fluttuazioni del campo di energia primordiale non si stabilizzano sul valore
zero e quindi lo spazio non potrà mai essere vuoto.
Attraverso affascinanti sotto capitoli come “La
cristallizzazione del campo di Higgs e l’origine delle masse”, “La particella
di Dio”, “Il Bang: un espansione inflazionaria”, “Un Universo in
accelerazione”, “Un Universo nato dal vuoto”, “Susy (cioè SuperSymmetry)
e la teoria delle stringhe”, “Il Multiverso” viene introdotto questo
concetto: in una delle centinaia di miliardi di galassie dell’Universo
osservabile, quella dal dolce nome di Via Lattea, vicino ad una stella di nome
Sole, su un pianeta chiamato Terra, circa 3,8milioni di anni fa degli atomi si
aggregarono in catene di DNA che diedero origine alla vita, poi alla coscienza
e a uomini capaci di interrogarsi sull'Universo che li ha generati.
E sorge la domanda: è
possibile che l’energia del vuoto sia determinata dal mero fatto che noi
esistiamo?
Gli astrofisici si sono accorti che l'esistenza
della vita e della coscienza nel cosmo dipendono da una calibratura precisa
delle costanti fisiche e delle condizioni iniziali. Se questi parametri
numerici variassero di pochissimo, l’universo sarebbe del tutto diverso: non
potrebbe ospitare la vita e noi non potremmo esistere. L’astronomo
anglofrancese Brandon Carter (1942) ha proposto di chiamare tale constatazione “Principio antropico”. Si è in seguito
considerata l’idea di Universi paralleli in cui però è
solo il nostro a possedere le condizioni richieste.
Non solo, trascinate dall’espansione accelerata
dell'universo, le centinaia di miliardi di galassie oggi osservabili,
diventeranno per noi invisibili entro duemila miliardi di anni circa, cioè
cento volte l’età attuale dell’Universo, e tra quattro miliardi di anni la Via
Lattea si fonderà con la vicina Andromeda. I nostri discendenti potranno
osservarla per dedurne che il nostro Universo attraversò una fase in cui era
molto piccolo, caldo e denso ed è nato da una deflagrazione, il Big Bang? No,
non potranno più farlo e l’espansione dell’Universo della materia oscura e
dell’energia del vuoto apparirà loro il mito di un’antica civiltà scomparsa,
concepito per descrivere l’origine del mondo, ma privo di qualsiasi riscontro
concreto: tale concezione corrisponde in maniera
sorprendente a quella delle maggiori tradizioni spirituali d’Oriente:
l’induismo, il taoismo, il buddismo. (Ed è su questo tema religioso la
conclusione del libro).
Nella splendida carrellata di conquiste
scientifiche riguardo l’Universo, un nome di questi straordinari inventori, mi
ha intenerito: Blaise Pascal, morto a soli 39
anni, afflitto da disturbi di salute tra cui violente emicranie (e bisogna
averle provate come me per capire cosa significhino).
Diede un contributo fondamentale a settori della
fisica come calcolo delle probabilità, geometria, algebra e studio dei fluidi e
dei gas sotto pressione. Era nato in una famiglia della piccola nobiltà di
toga, suo padre era magistrato ed aveva deciso di educarlo personalmente,
desiderando si dedicasse allo studio del latino e del greco più che alla
matematica. Ma il bambino “prodigio” scoprì a dodici anni le proprietà
geometriche dei triangoli che Euclide aveva enunciato duemila anni prima, a 16
pubblicò le sue prime scoperte di geometria nel Saggio sulle coniche, a
19 inventò una delle prime calcolatrici meccaniche, la “pascalina”, per aiutare
il padre nella riscossione delle imposte…
Non mi dilungo a ripercorrere le sue scoperte
(perfino quando troppo ammalato per procedere ad un esperimento si rivolse al
cognato perché lo eseguisse e con successo), ma riprendo le parole a suo
riguardo che Trinh riporta dal Genio del cristianesimo di
Chateaubriand:
“C’era un essere umano che, dodicenne, aveva creato
la matematica con sbarre e tondi, uno che, sedicenne, aveva scritto il più
competente trattato delle coniche che si fosse visto dall’antichità, uno che,
diciannovenne, ridusse in macchina una scienza che esiste tutt’intera
nell’intelletto, uno che, ventitreenne, dimostrò i fenomeni del peso dell’aria
e distrusse uno degli errori più gravi della fisica, uno che all’età in cui gli altri uomini incominciano
appena a nascere, dopo aver finito di percorrere il cerchio
dell’intera scienza umana, si accorse del suo nulla e volse i pensieri alla
religione… Un uomo che da quel momento, fino alla morte arrivata
quando aveva 39 anni, sempre ammalato e sofferente, risolse teoricamente uno
dei problemi più complessi della geometria e buttò giù su foglietti di carta pensieri che hanno tanto del divino quanto dell’umano:
questo spaventoso genio si chiamava Blaise Pascal”.
Mi sono dilungata a ripercorrere la vita di Pascal
perché nelle parole sopra sottolineate in azzurro c’è il concetto stesso di
questo libro: il non fermarsi alla scienza ma capire che
l’infinito o l’ansia d’infinito dell’uomo spazia molto più largamente.
Pur se l’Autore scriverà alla fine: “Quelli della
scienza e della spiritualità sono due Magisteri diversi, come ha sottolineato
il biologo americano Stephen Jay Gould”. “La scienza funziona benissimo – ci
ricorda ancora Trinh – e raggiunge lo scopo che si è prefissa – lo studio e
l’interpretazione dei fenomeni senza alcun bisogno di sostegno da parte di una
tradizione spirituale o di una religione, mentre queste ultime mirano a indurre
in noi una metamorfosi interiore profonda a livello di percezione del mondo e
d’interazione con esso, e ad aiutarci a pensare e agire in modo corretto.
Che sia la Terra a girare intorno
al Sole o il contrario, che all’origine dell’universo ci sia il Big Bang o
un’altra causa, per la religione non cambia niente. Ma scienza e spiritualità
s’ispirano entrambe a una ricerca della verità i cui criteri sono l’autenticità
e il rigore. Le rispettive maniere che hanno d’immaginare
il reale non devono condurre tanto ad un’opposizione irriducibile, quanto ad
un’armoniosa complementarietà”.
E se queste sono le parole finali del libro, prima
c’è un interessantissimo capitolo “Il Tao del Vuoto” che indaga le
religioni trovando i punti di contatto con la scienza.
Poiché per noi cattolici sono concetti poco
frequentati ne accenno in breve.
“Tao” significa “via”, “metodo”.
Quale via? Quella dell’Universo!
Il Tao non può essere visto, non può essere
enunciato (e troviamo in questo concordanze con il cristianesimo sul concetto
di Dio). Il Tao è la “madre di quel ch’è sotto il Cielo”. Ma il concetto
taoista è anche di un Vuoto-pieno all’origine di tutto, di un Non-essere che
genera l’Essere e presenta incredibili somiglianze con la cosmologia moderna.
Non solo, il Vuoto tende alla pienezza, quindi è
alla radice della “Via”. L’antica pittura cinese, d’ispirazione taoista, è una
riprova di questo assunto: non mira a produrre un oggetto estetico ma ha come
obiettivo la rivelazione stessa del mistero dell’Universo. Nel libro un dipinto
taoista che, nel raffigurare valli e montagne, mostra l’interazione tra Vuoto e
Pieno. Il taoismo spesso paragona il Vuoto ad una valle, infossata tra i monti
ma che nel fondo contiene alberi, corsi d’acqua ecc.
I Ching
o Libro
dei mutamenti, del primo millennio a.C., considerato uno dei testi più
importanti del pensiero universale, contiene 64 segni che si basano sul
simbolismo dello Yin e dello Yang, cioè del Pieno e del Vuoto. Tali segni si
mutano di continuo gli uni negli altri, come i fenomeni evolvono da una forma
all’altra. Dai pianeti alle stelle, dalle galassie agli ammassi di galassie
nulla è permanente. I cicli di vita e di morte delle stelle, però, non si
misurano in termini di un secolo, ma di miliardi di anni. E in campo scientifico superata la rigidità
di Newton, il tempo e lo spazio di Einstein sono diventati dinamici, elastici,
con comportamenti sempre complementari.
Il Buddismo ha riflettuto a sua
volta sulla nozione di vuoto.
Siddharta Gautama, il Buddha (il “risvegliato”, in
sanscrito) visse nel V o VI secolo a. C., periodo straordinario nella storia
umana che vide altri uomini eccezionali come Confucio e Lao-tzu in Cina, Platone e Democrito in Grecia. Si è
interessato alla natura del mondo come fa la scienza perché riteneva che
l’ignoranza fosse fonte di sofferenza. C’insegna che dobbiamo imparare a
distinguere la realtà apparente dalla realtà ultima (il modo in cui le cose
sono davvero). C’insegna -e questa è interconnessione- che la nostra felicità
dipende da quella degli altri: “risveglio” non è
solo uno stato di conoscenza illimitata, ma anche di compassione infinita.
Il buddismo rifiuta l’idea di un universo che passa
dalla non esistenza all’esistenza e ci ricorda in maniera sorprendente il
vuoto-pieno dei fisici. Poiché però non accetta l’idea di un inizio
dell’universo in cui tempo e spazio siano simultanei, viene a proporci un
Universo ciclico. Il Big Bang non sarebbe quindi un’esplosione primordiale
unica, ma l’inizio di un ciclo specifico di una successione infinita di cicli,
estesi all’infinito, sia verso il passato che verso il futuro.
Il primo scienziato che elaborò il modello di
Universo ciclico è stato il russo Aleksander Aleksandrovič Fridman
(188-1925) e lo fece con sorprendente sintonia con l’Universo ciclico della mitologia induista. Per essa il dio Brama
creò il mondo nel sonno, mentre dormiva e sognava ed ogni ciclo cosmico
corrisponde ad uno dei suoi respiri. Ciascun respiro corrisponde a circa 8,6
miliardi di anni, un lasso di tempo vicino all’età moderna valutata intorno ai
13,8 miliardi di anni.
Però le osservazioni attuali escludono un Universo
ciclico per lo meno all’interno del modello standard del Big Bang di cui però
esistono altre versioni. Oggi, l’evoluzione cosmica, guidata dalle leggi della
fisica e della biologia ricorda sotto
molti profili la creazione ex nihilo dell’Universo evocata dalla tradizione
giudaico-cristiana.
Una lettura affascinante questo libro al punto che
ricercherò un altro testo di Trinh: Lo scienziato e
l’infinito- Numeri, uomini e universi. Voglio approfondire.
Gianpaolo Benincasa
Einstein e il Sasso
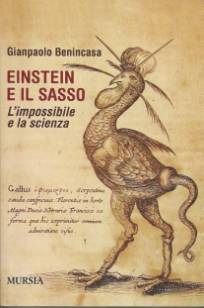
Sondo mio marito per capire perché questi due libri
gli siano piaciuti. Risposta: pur partendo da presupposti diversi arrivano alla
stessa conclusione. Cioè: “L’uomo è così perché esiste”.
In sintesi:
-
ogni uomo è quello che è e crede in ciò in cui
crede perché...
-
il bagaglio genetico
-
il bagaglio somatico
-
il bagaglio culturale
-
il bagaglio sociale
-
il bagaglio cromosomico dei genitori.
Seleziono dal libro alcuni concetti che valgono più
di una mia recensione.
“Ogni uomo nasce con un bagaglio genetico che
dipende in gran parte dal patrimonio cromosomico della nostra razza, ma più
specificamente da quello dei suoi genitori.
“Sono così ereditari certi tratti somatici e del
carattere, certe predisposizioni artistiche i sportive, e purtroppo anche la
predisposizione a certi tipi di malattie.
“A questo patrimonio di partenza se ne aggiunge un
secondo, non meno importante, fornito con l'interazione don l'ambiente durante
il periodo di sviluppo dalla nascita in poi. Patrimonio importante per la
formazione del carattere e delle cartatteristiche che formano il bagaglio
ideologico, sociale e politico di ogni uomo.
Ogni uomo è quello che è e crede
in ciò in cui crede perché così è nato e così si è formato.
Le interpretazioni dei fatti dipendono appunto in
gran parte dal bagaglio genetico-ambientale della persona che interpreta.
Nessuno di noi è esente da questa regola: la
perfetta obiettività non esiste, è solo un mito.
Può accadere che un giudice con delle idee
politiche ben definite, per quanto imparziale ed onesto, mostri spesso maggior
empatia ed indulgenza verso quelle più vicine alle sue idee e le cui azioni
quindi si prestano, dal suo punto di vista, a qualche giustificazione.
Anche nel campo della scienza, le interpretazioni
di fatti certi sono spesso guidate dalle credenze e dal solito bagaglio
personale degli scienziati che interpretano tali fatti".
Benincasa cita la Sindone che la Chiesa non ha mai
ammesso sia il vero sudario del Cristo deposto dalla croce, ma la tradizione
popolare non ha avuto bisogno di questo imprimatur per considerarla tale..
Ora inizia la mia recensione dopo aver premesso chi
sia Benincasa, l’autore.
Inizio con un Ah, ah, ah, cioè una grassa risata
che si collega a quanto da lui detto sulla Sindone.
Ma prima sull’autore: Gianpaolo Benincasa,
palermitano, si è laureato in Ingegneria Nucleare e dal 1967 ha lavorato al
CERN di Ginevra per realizzare sistemi di controllo e sicurezza dei più grandi
acceleratori di particelle del mondo. Benincasa scrive questo libro per sfatare
alcune delle più false credenze riguardo il formarsi dell’universo e la nostra
storia, parte dal Big Bang (15 miliardi di anni fa), dalla comparsa di quello
che si può considerare il nostro antenato (100mila anni fa) per venire alla
nostra storia negli ultimo 10mila o 20mila anni. Stupisce che il libro sia
stato edito da Mursia, casa editrice di divulgazione perché per le tante
equazioni, ecc. meglio figurerebbe come pubblicazione accademica.
Perché la mia risata? L’Autore sostiene che bastava l’inequivocabile test del carbonio 14 per escludere che la Sindone appartenga al tempo di Cristo, ma gli è sfuggito del tutto il significato della devozione popolare. L’uomo del sudario parla così ai tantissimi fedeli: “Guardate cosa mi avete fatto. E io sono ancora qui nel vostro ricordo per insegnarvi il perdono quello che non avete usato con me”. Grandeggia l’Uomo-Cristo e la gente accorre.
Così tutti i capitoli di Benincasa nati da un profondo sapere scientifico sono dimostrazione che sì forse un giorno l’uomo ne saprà di più ma mai e poi mai si potrà accontentare della scienza in se stessa. Confuta i miracoli e forse un poco, ma solo un poco si arrende davanti al sole roteante a Fatima che però cataloga come una possibile illusione ottica collettiva. Non sa dire “credo quia absurdum” né come Sant’Ignazio di Loyola “gettati a terra e prega e ti verrà la fede”. Crede solo nella scienza che per ora gli dà risposte limitate, crede negli Ufo perché crede negli Universi paralleli. Qui merita proprio di riportare le sue parole Tra le più famose testimonianza quella antichissima di Plinio che parladi Clipeus ardens sui cieli di Roma, quella di Basilea nel 1566 quando durante tutta una giornata, dischi, sigari e altre sfere hanno volteggiato sul cielo della città e sono state riportate nelle cronache locali e quella del 1608 in Costa Azzurra quando si spararono perfino salve di cannone contro questi strani oggetti. In tempi più moderni una vera esplosione di avvistamenti dopo la seconda guerra mondiale…L'ipotesi più affascinante è di macchine volanti guidate da esseri intelligenti venuti da lontanissimi pianeti …E questi visitatori hanno una tecnologia di qualche migliaio di anni più progredita della nostra... Conclusione:essi sono coscienti di quale catastrofe si genererebbe da un eventuale contatto tra due civiltà così differenti. Così come quando noi scopriamo una qualche piccola tribù in una regione sperduta del nostro globo, rimasta isolata dalla nostra civiltà, facciamo enormemente attenzione a non creare questo catastrofico shock di civilizzazioni (come è purtroppo già accaduto). Quindi gli extraterrestri ci avrebbero risparmiato per non causarci ciò, però il progetto SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence): ricerca di intelligenze extraterrestri e che utilizza una serie di grandi telescopi per captare segnali dall'universo, finora non ha raggiunto risultati apprezzabili.
Forse con umiltà, pur
affascinati da questa ipotesi, dovremmo tornare a Shakespeare quando dice che
“fra cielo e terra ci sono più cose di quanto l’uomo non immagini". Forse
pur continuando sull'arduo cammino della scienza (e ricordando che le più
grandi scoperte sono spesso avvenute per motivi del tutto casuali) dovremo
accontentarci di sfangare e sfangare sulla strada del progresso e della
civiltà, ma forse potrebbe esserci più facile se accogliessimo con umiltà il
senso del mistero e allora forse quelle domande impervie: Perché esiste l’universo?
Chi siamo? Da dove veniamo? Perché ci siamo” che sono quelle dell'uomo da
sempre troveranno qualche piccola risposta.
Alan Lightman
L’universo accidentale
sette
riflessioni cosmologiche
sul mondo
che credevi di conoscere
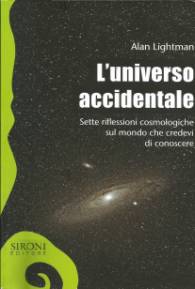
Nella
cover (in quarta) è riportato questo commento dal Columbus Dispatch: “Alan Lightman è
forse l’unico scrittore in grado di destreggiarsi attraverso non uno ma sette
universi in un libro poco più largo di una mano”. E in 140 agili pagine
l’autore fisico teorico, specializzato a Princeton e a Caltech, che per venti
anni ha svolto ricerca in astronomia e fisica, insegnandole ad Harvard e al MIT
(Institute of Technology del Massachusetts uno dei più importanti al mondo) è
come ci prendesse a bordo di una navicella spaziale. Ci porta così a capire un
po’ di più il mistero dell’Universo che ci circonda.
Lo
fa con
semplicità, chiarezza e maestria in quanto al MIT ricopriva due
incarichi:
insegnava Fisica al mattino e Scrittura creativa al pomeriggio. Non
avrebbe queste sue qualità, così importanti per chi legge e deve e vuole
capire, se non avesse imparato molto dal secondo incarico, affinando il suo
potenziale di scrittore. Se al mattino parlava di un mondo di “pura logica e
razionalità” al pomeriggio invece analizzava con gli studenti la natura caotica delle vicende umane e i
percorsi poco chiari della mente. Partiva da un presupposto inconfutabile: “le persone reali
non sono prevedibili”. “Un personaggio che agisce sempre in modo
razionale è fasullo, un personaggio che puoi capire al cento per cento è come
morto”. Anzi gli studenti che scrivevano storie con personaggi privi di
contraddizioni erano sonoramente rimproverati per aver creato solo “robaccia
scadente e senza vita”.
Cosa
c’insegna Alan?
Parte
da una premessa: “come scienziato credo fermamente che gli atomi e le molecole
siano reali (anche se consistono soprattutto di spazio vuoto) e che esistano in
modo autonomo dalla mente di chiunque”. “Noi sappiamo – continua – che le
istruzioni per ‘costruire’ un essere umano – o meglio qualsiasi forma di vita –
sono codificate in una molecola a forma di doppia elica (Dna) che si trova in
ogni minuscola cellula del nostro corpo”. Prosegue così: “nel primo saggio di
questo libro, L’universo
accidentale, parlerò della possibilità che esistano Universi multipli,
molteplici ‘continuum’ di spazio-tempo, alcuni dei quali con più di tre
dimensioni. Mentre nel concetto antico e proprio secondo etimologia
Universo deriva dal latino ‘unus’ (uno
solo, unico) combinato con il participio del verbo ‘vertere’, che significa
‘volgere’. Quindi secondo i latini l’universo
sarebbe ciò che è avvolto in un tutt’uno”. E’ chiaro che il discorso fisico
e cosmologico ha una lunghissima storia e se nel V secolo a. C. il filosofo
Democrito concepì gli atomi, nel XIX gli scienziati scoprirono che le proprietà
chimiche degli atomi si ripetevano periodicamente tanto da poterne trarre una tavola periodica degli elementi. Precisa Alan: “la storia della scienza
può essere vista come rielaborazione di fenomeni prima accettati come dati di fatto
in fenomeni che vanno compresi in termini di cause e principi fondamentali”. Conclude questo primo assunto con
l’osservazione che “l’impetuoso sviluppo delle ricerche cosmologiche ha portato
ad ipotizzare che il nostro universo
sia solo uno tra un enorme numero di altri e che alcuni dei più basilari
parametri del nostro particolare universo sarebbero puri accidenti: un tiro casuale di dadi cosmici”.
I
fisici chiamano la totalità degli universi Multiverso. E oggi due teorie
fisiche – note come inflazione cosmica (teoria del Big Bang) e teoria delle
stringhe (che vuole conciliare la meccanica quantistica con la
relatività generale) – ci indicano che gli stessi principi fondamentali da cui
derivano le leggi di natura da noi
conosciute possono condurre a molti diversi universi con molte
differenti proprietà. Perciò noi viviamo in un universo accidentale. Per capire meglio: il quanto dal latino (dove significa quantità) indica la quantità
elementare di una certa grandezza e per
estensione il termine diventa sinonimo di particella elementare associata ad un
campo di forze. La teoria quantistica dei campi sviluppa la meccanica
quantistica applicandola al concetto di campo per cui la particella prende il
significato di “stato eccitato del campo”. Ma qui arriva anche il tocco
magistrale dello scrittore perché ci spiega al riguardo che è come entrare in
un negozio di scarpe e poter calzare il 38, 42 o 45 con uguale comodità.
A
questo punto Alan non può esimersi da una digressione sul principio antropico per cui se
nell’universo i parametri fossero appena diversi da ciò che sono, la nostra
esistenza risulterebbe impossibile e anche la vita in sé in ogni sua forma e
rispetto al grande ventaglio di possibili universi la frazione di quelli che
possono contenere la vita è senza dubbio piccola. Subentra quindi il grande
problema del Creatore per cui Alan si appoggia ad un concetto dello scienziato
Steven Weinberg: “sono ormai molti secoli che la scienza ha indebolito la presa
della religione e non perché abbia confutato l’esistenza di Dio ma perché ha
falsificato gli argomenti a suo favore, basati su ciò che è osservabile nel
mondo naturale”. Ne nasce tutta una discussione sul “disegno intelligente”, sul
Creatore, sulla fede.
Alan
si dichiara ateo però anche lui ha una
fede fortissima ed è nella natura.
Soprattutto
ci stupisce con tanta umanità come quando assiste al matrimonio della figlia (e
siamo già nel II dei VII capitoli: L’universo
provvisorio). Ci racconta che la figlia
è venuta a prendergli il braccio per farsi accompagnare lungo il
vialetto e lui ha desiderato con tutto se stesso di riaverla all’età di dieci
anni mentre ora ne ha già trenta. Tale accostamento personale lo porta ad
introdurci “la
freccia del tempo”, che i fisici chiamano secondo principio della termodinamica.
In grande sintesi la constatazione è di un universo che implacabilmente si
sgretola, si consuma mentre un tempo i continenti erano uniti
insieme e l’atmosfera era fatta di ammoniaca e metano, mentre ora è di ossigeno
e azoto.
E lo scrittore si sovrappone allo scienziato per
ricordarci la lunga ricerca umana sull’elisir di
lunga vita. Anzi il primo imperatore della Cina Qin Shi Huangdi
ormai vecchio spedì centinaia di servi a cercarlo e poiché tornarono a mani
vuote il suo medico gli prescrisse pillole di mercurio per renderlo immortale
con il risultato di avvelenarlo. Commenta: “oggi siamo risposti a spendere per
parrucchini, addominoplastiche, lifting e trattamenti con il botox e avendo
fatto una ricerca su Google sui “prodotti per restare giovani” ha trovato ben
37.200.000 risultati. Commenta ancora: “però nel mondo un po’ dappertutto si
conservano monarchie ultradatate e nella Chiesa cattolica la norma sul celibato
dei preti è intatta dal Concilio di Trento del 1563…” Alan si addentra in una
digressione in base a ricerche di altri scienziati per
mostraci la sua fede in fenomeni dell’universo, compresa la nostra esistenza
che si possono derivare completamente dalle leggi di natura e da processi casuali
senza necessità di alcun Disegnatore intelligente. Conclude che “la
scienza non arriverà mai a sapere cosa abbia originato il nostro universo” e ci
ricorda come la fede e la passione per il
trascendente che spesso l’accompagna abbiano originato molte splendide
creazioni del genere umano. Ne cita alcune come i versi del Gitanjali,
l’oratorio Messiah, la moschea dell’Alambra, gli affreschi sulla volta della
Sistina. Ci chiede: “dobbiamo rimproverare Tagore o Hendel o il sultano Yusuf o Michelangelo di essere
irrazionali?” “La fede – ci spiega - è qualcosa di più che credere in Dio o non
curarsi delle prove scientifiche. La fede, a volte, è disponibilità ad
affidarsi a cose che non comprendiamo completamente, è credere in qualcosa di
più grande di noi”. Ci offre anche la riflessione scontata che in nome della
Religione gli esseri umani hanno inflitto sofferenze e morte, ma, paragonandola
alla Scienza anche questa ha partorito armi di distruzione, specie nel XX
secolo. Conclude che per lui Scienza e Religione
hanno il senso dello stupore (il nostro modo di entrare in sintonia
con la natura di fondersi con essa) e tutte le Religioni contemplano l’idea
dell’immortalità. Però ci ricorda anche lo sbocciare del fiore del cactus che
dura una sola notte, “delicato e fugace come una vita nell’universo” e come
quel fiore è anche la nostra vita: un battito di ciglia su questa terra.
Però da questa meraviglia della natura e dallo
stupore che ne consegue, passa ad introdurci l’episodio
dei falchi pescatori che hanno fatto il nido vicino alla sua casa di vacanza
nel Maine. Con la moglie registravano tutti i particolari della loro
vita su un quadernetto ed erano certi ed orgogliosi di aver documentato con
precisione una piccola porzione di universo. Ma un pomeriggio d’agosto i due
falchetti che spiccavano il primo volo, puntarono dritto su di lui che li aveva
osservati così a lungo come se pure lui fosse in un nido. Gli volarono contro a
grande velocità e lui pensò che con i loro potenti artigli potevano ferirlo ma
rimase fermo e per mezzo secondo gli capitò d’incrociare gli occhi dei
falchetti. “Le parole non riescono a tradurre ciò che è passato tra noi in
quell’istante – ci precisa- era uno sguardo di mutuo rispetto, il
riconoscimento che spartivamo uno stesso luogo”.
Continuando nella sua analisi serrata sulla natura
che ci circonda, si chiede perché siano così tante
le simmetrie in natura proprio come nell’alveare di api. Spiega
molto bene che dipende dal principio di economia.
Né dimentica il mistero e ce lo riporta
con parole di Einstein: “la più bella esperienza
che possiamo fare è il mistero. E’ l’emozione fondamentale che sta accanto alla
culla della vera arte e della vera scienza”.
Per continuare però il discorso più propriamente
scientifico ci ricorda che la stima fatta da Newton sulle posizione delle
stelle più vicine superava qualsiasi altra distanza mai concepita prima nella
storia. Queste distanze vengono poi soverchiate dalle misurazioni effettuate
all’inizio del XX secolo da Henrietta Leavitt, un’astronoma dell’Harvard
College Observatory. Nel 1912 ideò un metodo completamente nuovo per
determinare la distanza degli astri più lontani. Alcune stelle, chiamate variabili cefeidi, sono note per l’oscillazione
della loro brillantezza.
Leawitt scoprì che il
periodo di tali stelle è correlato alla loro luminosità. Sono
disseminate in tutto l’universo: funzionano come
segnaletica per la distanza cosmica nell’autostrada spaziale.
(Bellissima immagine partorita dal genio dello scrittore!).
La scienza ha esteso
largamente la scala del nostro universo. Nel marzo
2009 la NASA ha lanciato un telescopio spaziale chiamato Kepler con la missione
di cercare pianeti orbitanti nelle zone abitabili di altre stelle.
Si definisce zona abitabile una regione in cui la temperatura risulti
non tanto fredda da ghiacciare l’acqua né tanto calda da farla bollire. Biologi
e chimici ritengono sia necessaria la presenza di acqua allo stato liquido
perché la vita possa emergere. Sono già state individuate dozzine di pianeti candidati ad
avere tale caratteristica. “Se la vita è emersa da un processo
casuale - pensa Alan che è ateo –
enormi quantità di materia inerte sono state necessarie per ciascuna particella
vivente e questi risultati non possono non influire sulla domanda circa il
significato della nostra esistenza nell’universo”.
Appare
basilare nel suo discorso alla ricerca delle nostre origini un importante
congresso scientifico europeo del 1930 e la lettera che scrisse allora ai
colleghi il geniale fisico austriaco Wolfgang Pauli: “ho escogitato un metodo per salvare la legge di
conservazione dell’energia: quando un atomo
radioattivo emette una particella beta, emette anche un altro genere di
particella…” Era quella che allora era ignota e che poi fu chiamata neutrino.
Scrisse l’austriaco: “la somma delle energie di neutrino e di particelle
beta eguaglia correttamente la differenza nel saldo energetico dell’atomo” e
quindi era comprovato che la legge di conservazione dell’energia restasse un
principio inoppugnabile. Chiudo l’articolato discorso del fisico Alan,
imperniato, pur ripercorrendo la storia delle scoperte, su quanto sarà ancora
possibile scoprire e che non finirà mai di sorprenderci. Pur se non arriveremo
mai a capire del tutto il perché del Big Bang o il perché dell’origine della nostra
vita (se casuale o voluta dal Creatore) non cesseremo di sorprenderci per altre
scoperte future.
Poiché però uno dei tratti più emozionanti di
questo scienziato è il saper darci piccoli “flash” della sua vita che
appartengono anche a noi, mi piace concludere con il suo ricordo di una cena
con una figlia venticinquenne e con le sue amiche. “Molte tenevano i loro
iPhone sul tavolo, accanto al piatto –commenta- come
bombole di ossigeno in miniatura per malati di enfisema, da portarsi sempre
dietro. Ogni paio di minuti gettavano un’occhiata al telefono per
controllare l’arrivo di un nuovo messaggio. Una ha mostrato la foto digitale
del suo cane, un’altra ha fatto ascoltare la musica dal suo iPod. Commenta
ancora: “l’esistenza incorporea è la loro realtà”.
Ricorda pure quando gli capita di passeggiare nel suo parco del Massachusetts e
d’incontrare altri che parlano al telefono ed è come cercassero di essere
contemporaneamente in più parti come
onde quantistiche. Ci ha spiegato poco prima che la
particella ha una sola posizione, mentre l’onda può avere più posizioni
simultaneamente. La sua riflessione è che queste persone in realtà non siano da
nessuna parte. Conclude (ed è proprio la pagina finale): “i più di noi si
adatteranno a questo genere di vita, proprio come le persone si sono abituate
ai cellulari e a Skype. Sarà il modo naturale e normale di stare al mondo.
“Ma qua e là piccoli gruppi di persone si
ribelleranno e fonderanno comunità separate, dove le tecnologie più recenti
saranno lasciate fuori dalla porta; allo stesso modo in cui oggi alcuni
insistono a scrivere lettere a mano o fanno lunghe passeggiate senza portarsi
il cellulare.
“Loro avranno la sensazione di preservare qualcosa
di prezioso, di vivere un’esistenza senza mediazioni. Ma d’altra parte saranno
disconnessi da quel più vasto mondo chiuso fuori dalla loro porta, che resterà
invisibile alle loro abitudini”.
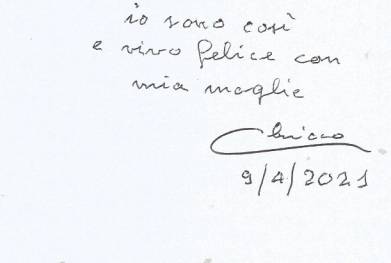
E
non potevo non riportare queste parole vergate da mio marito alla fine del
libro (gli è piaciuto molto) e che dopo 57 anni di matrimonio non possono non
farmi piacere pur se sul nostro calendario, appeso in cucina per ricordarci le
date di rilievo, ha anche scritto per questo nostro anniversario: “57 anni di lavori
forzati”.
Proprio
come ha scritto Alan “le persone non sono mai prevedibili”.