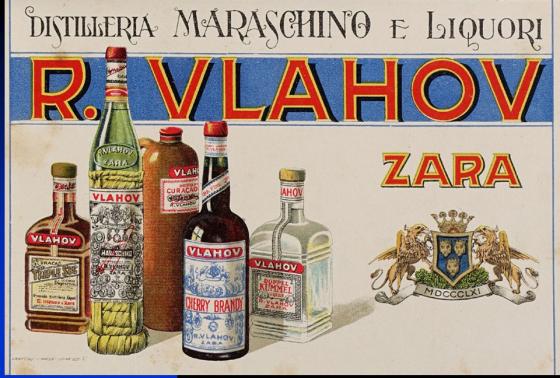INDICE
1)
Invito a
presentare al Lyceum
2)
I 90 anni del
Lyceum a Genova
3)
Locandina
Circolo Ufficiali per presentazione
4)
Power point
con 29 diapositive
5)
Spiegazione di
alcune diapositive
Per la presentazione di Genova, su invito del Lyceum e presso il
Circolo Ufficiali, ho pensato di proiettare qualche immagine di Trieste, Zara e
della mia famiglia (le eccellenze, diciamo così).
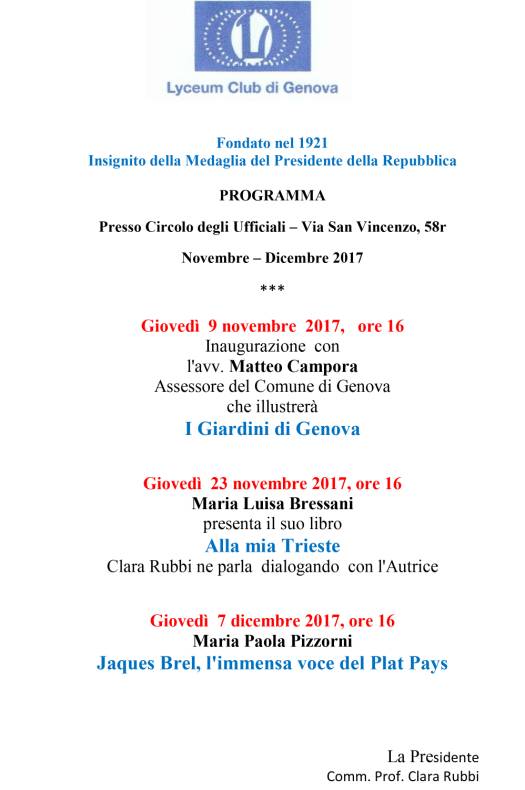
E per presentare il Lyceum del cui invito mi sono sentita molto
onorata tanto più che Vincenzo Longo, marito della attuale presidente Clara
Rubbi, fu mio correlatore alla mia tesi di laurea con il prof. Enrico Turolla,
allego un piccolo articolo per i suoi 90 anni a Genova, scritto per il
Settimanale diocesano.
I 90 del Lyceum a Genova
Festa grande per
i 90 anni del Lyceum genovese. Sarà presente l'olandese Eltje T. Brill-Meijer,
presidente internazionale. Clara Rubbi che dal '97 presiede il Club di
Genova ricorda
con humour una frase di Cerofolini: "Regni sono per la durata le vostre
presidenze!"
Il primo Lyceum
nacque, con carattere apolitico e internazionale, a Londra nel 1903 ad opera
della scrittrice-giornalista Constance Smedeley. Il nome si riferisce al greco
Lykaion, luogo del tempio di Apollo ad Atene riservato alla conoscenza delle
Arti: Letteratura, Pittura. Musica. Oggi i Club italiani sono a Firenze,
Cremona, Napoli, Catania, cui si può aggiungere Lugano, in quanto italofono.
Nel mondo sono
arrivati anche a più di una cinquantina.
A Genova il Lyceum
fu inaugurato, sotto il patronato di Mafalda di Savoia, il 28 febbraio 1921 nel
Salone della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche con un discorso di
Lauretta Renzi, consorte del noto filosofo.
Prima presidente
Bice Scribanti Ravizza fino al 1952, poi Jole Ghersi già presidente
ell'Istituto Laura Di Negro Spinola, quindi per vent'anni Minnie Alzona.
La scrittrice
era orgogliosa di questa sua attività "creativa" di pubbliche
relazioni e tra i conferenzieri per i 50 anni del Lyceum ricordò: Bassani,
Berto, Bevilacqua, Bo (Carlo), Crovi, Falqui, Gervaso, Goldoni (Luca), Longo
(Giuseppe), Montanelli, Piovene, Prisco, Streheler, Vigorelli, Sgorlon; donne
scrittrici come Lalla Romano, Camilla Salvago Raggi, Beatrice Solinas Donghi,
Elena Bono, Piera Bruno...
"Allora le
socie iscritte erano trecento, alta la quota d'iscrizione per cui potevamo
offrire il viaggio, la cena e l'albergo. Ora le socie sono una sessantina,
tanti gli altri luoghi d'incontro: Berio, Ducale, Fnac, Borsa, però nostro
'blasone' - commenta Rubbi - nessun magistrato o medico o scienziato invitato
mi ha detto no, anzi è lunga la lista
d'attesa".
Ricorda un
momento alto della sua presidenza quando Giovanni Meriana, assessore alla
cultura in Comune, finanziò un Concorso tra Associazioni femminili per
iniziative per la donna. Il Lyceum propose tavole rotonde su "Diritti e
doveri, arte e piaceri". Sul primo tema parlarono Dimitri, Pighetti,
Profumo; Millu sulle donne nella tradizione ebraica, Tassinari nella tradizione
Tuareg, Galeppini su "famiglia e religione". Ci furono conferenze su
"donne e musica" con Marco
Jacovello relatore sulle poche compositrici, su "donne e pittura" con
Anna Merlotti. E il piacere?
Come gusto della
moda portò al Lyceum le ragazze del Deledda e i loro abiti". Per questo
anniversario il Lyceum genovese ha ricevuto da Napolitano una medaglia e il
patrocinio della Regione Liguria.
Tra le sezioni
splendidamente attiva la musicale; dal 1972 Edda Magnaterra guida la filantropia, che ogni
anno organizza una giornata di beneficenza per situazioni di vero disagio.
Dell'affascinante
conoscenza delle Letterature straniere si occupa Silvana Canevelli,
vice-presidente a Genova ed anche presidente nazionale; le mansioni di
segreteria sono affidate al bel nome di Rosa Elisa Giangoia.
Lunga vita
dunque al Lyceum: non è mai stato sopravvivenza di un'arcadia ma ampia e vitale
circolazione d'idee.
Purtroppo alla presentazione di Alla mia Trieste
essendo mancata il giorno prima la carissima amica Edda Magnaterra il Lyceum
sospese l’incontro che tenni lo stesso non potendo annullare gli inviti e il
Power Point opera del mio nipotino Stefano mi aiutò grandemente in quel momento
tristissimo.
Riuscii a tenere la presentazione grazie alla
disponibilità del T.Colonnello Marco Chiacchierini che dirige il Circolo
Ufficiali dove ora il Lyceum di Genova tiene le sue presentazioni.
Ecco le immagini che presentai in quell’occasione che
riguardano Trieste, Zara ed alcune “eccellenze” della mia famiglia d’origine.
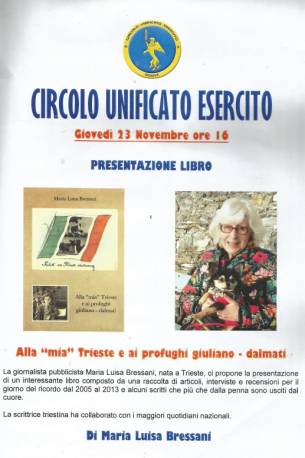

Per aprire il
power point clicca sopra.
Delle
29 diapositive ne voglio illustrare alcune.
Sulla prima diapositiva occorrono due parole di spiegazione: è una delle tre cartoline che acquistai in quei pochi giorni a Trieste, la mia città natale, dove mio padre il 26 ottobre 1954 per il ritorno all’Italia ci aveva portato per quell’occasione di festa di popolo e grande festa italiana. (Nella cartolina, l’unica che ho conservato avendo regalato le altre due quando mi capitò di sentir parlare di Trieste a Genova e in modo che mi entusiasmò ma è cosa che non succede spesso, si vedono il Castello di Miramare e il Monumento dei Caduti presso la Cattedrale di S. Giusto).
La n. 2 che riguarda l’arrivo delle navi a Trieste al Molo Audace, il 26 ottobre 1954, come già era avvenuto nel 1918: folla straripante, io ragazzina di 12 anni c’ero e fu una grandissima emozione.
Il Castello di Miramare è citato in una leggenda trentina da Il Regno dei Fanes di C.F. Wolff “La fanciulla di Giralba” che riguarda origine e leggenda del Lago di Misurina. L’inizio della leggenda riporta una credenza popolare: quando una madre, che partorisce, muore nel giorno in cui dà alla luce la sua creatura, ha modo di sapere cosa le accadrà. Vede infatti un pesce che regge in bocca una pergamena e su questa, che srotolandosi racconta la vita del nascituro, campeggia il Castello di Miramare: è un senjal partenop (un segno di malaugurio). D’altra parte chi abitò quel Castello da Massimiliano d’Asburgo, che lo fece costruire e morì in Messico, al Duca d’Aosta non ebbe buona sorte.

La n.3 –bellissima!- dove alla partenza delle truppe alleate in treno l’americano James solleva fino all’altezza del finestrino la triestina Graziella: si sposarono qualche mese dopo e anni dopo furono intervistati per Gente di Edilio Rusconi.

Queste due foto sono tratte
da Trieste 1954 del reporter triestino Ugo Borsatti che ha regalato
il suo Archivio di foto alla città di Trieste. Il libro è stato pubblicato nel
2004 con Lint, ma nel 2001 sempre con Lint è di Borsatti il secondo volume
della Collana Il Filo: Croazia 1944. Borsatti,
giornalista pubblicista dal 1965, vi narra delle sue vicende di 17enne: dal
lavoro coatto sotto i tedeschi, alla cattura da parte degli Jugoslavi, alla
deportazione a Delnice, i lavori forzati, le fughe, le sevizie…
La Collana che prende il
nome da una frase di Flaubert: “…le perle non fanno la collana, è il filo…”
inizia con il libro Trieste, ah, Trieste di Fulvio Anzellotti (nipote di Italo Svevo ed imprenditore di
una fabbrica di vernici) che consegnò il manoscritto a Valerio Fiandra,
direttore editoriale della Lint quando ormai sapeva di dover morire (libro
quindi tutto incentrato sulla verità della vita e sul piacere degli ultimi atti
o piaceri di questa come anche il fumare una sigaretta). Di Borsatti è il
secondo titolo e poi come quinto arrivano Le lettere d’amore e di guerra
(che ho tratto dall’epistolario dei miei genitori. Dal 1934 al 45 1000 lettere che ho donato all’Archivio di
Pieve Santo Stefano dove il manoscritto risultò tra i finalisti nel 2002,
epistolario che è stato utilizzato per alcune tesi universitarie). Le Lettere
ebbero due edizioni, nel 2003 e nel 2006.


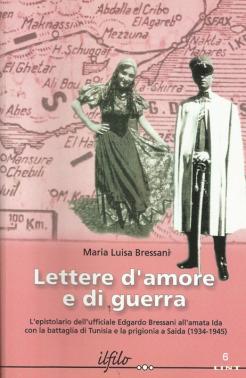
Guido Bressani medaglia
d’oro
(1940 Canale di Caso)

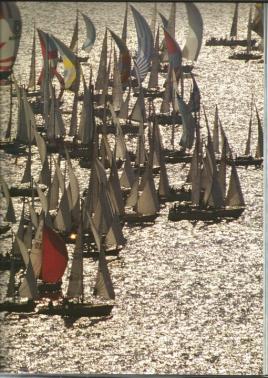
La n.4,5,6,7 riguardano i Bressani, mia famiglia d’origine, in
alcune “eccellenze”. C’è la foto del 1934 dei miei nonni, molto distinti.
Gisella e Luigi, cavaliere del Regno, con i tre figli Gero (Ruggero, il più
piccolo) bersagliere in guerra, poi alle Assicurazioni Generali di Trieste. Lo
zio giovane morì d’infarto il giorno del mio matrimonio a Nervi di Genova nel
1964 e grazie alla delicatezza di sua moglie, zia Bruna, lo seppi solo al
ritorno dal viaggio di nozze.
Gigi (Luigi) il figlio
maggiore, laureato in legge ma, avendo vinto un concorso, professore di Storia
e Filosofia per 50 anni prima al Dante di Trieste e poi al Fermi, Edi (Edgardo,
mio padre, il secondogenito) che capitano di artiglieria in guerra è stato
Direttore alle Imposte Dirette di Genova e promosso a Direttore generale a
Trieste, incarico che però non rivestì mai perché allora si dimise.
Quindi la foto di Guido
Bressani, ufficiale osservatore, medaglia d’oro, che s’inabissò con il primo
Mas nel Canale di Caso nel 1944. Mio cugino Andrea, ingegnere ed appassionato
di musica grazie all’educazione della madre, della famiglia sarda dei marchesi
Cao, direttrice al Conservatorio di Bologna, non ha mai conosciuto il padre
perché è nato dopo.
Quindi un altro giovane
Bressani, ardente e sportivo, Lorenzo nipote di zio Gero, che vinse la
Barcolana nel 2002.
La
n. 10 è una foto suggestiva di Piazza dell’Unità dove ha sede il Comune
e mi è stata inviata dal sindaco Roberto Dipiazza, all’uscita del libro Alla
‘mia’ Trieste che gli inviai dato che è sulla barca del sindaco che mio nipote
Lorenzo vinse la Barcolana.
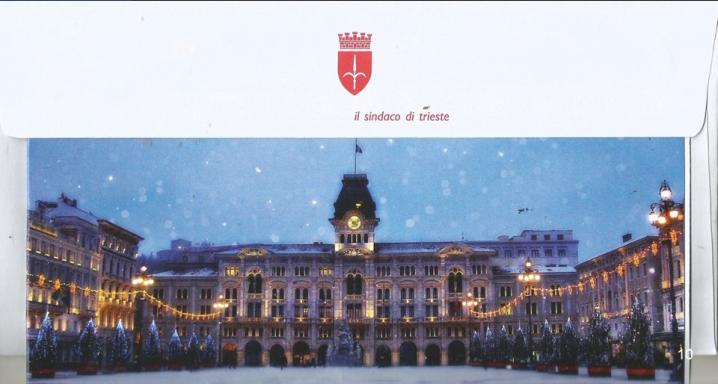
La
n. 16 è una cartolina di Enrico Halupca che impaginò per Lint il libro
delle Lettere dei miei genitori e che è autore di pubblicazioni con splendide
foto come Le Meraviglie del Carso (durante l’impaginazione mi corresse
un errore e gliene sono grata in quanto in fondo io poco conosco Trieste
avendovi vissuto solo due anni, 1946/48, quando a metà della mia prima
elementare ci trasferimmo a Genova). In questa cartolina campeggia il Castello
di San Giusto coperto dalla vite vergine rossa che poi fu tagliata e non più
lasciata ricrescere per far respirare le pareti e quindi per una miglior conservazione.
Però così è stata distrutta una delle immagini più suggestive di Trieste.
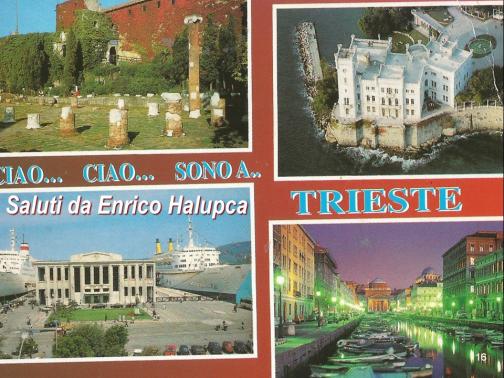
La
n. 19 riguarda la tomba Stuparich (entrambi i fratelli medaglie d’oro e
Giani fu insegnante di Laura Boschian in quanto ritornò vivo dalla guerra).


La
n. 23 è una drammatica foto di Zara bombardata
La n. 24 è la tomba Vlahov a Zara con il
dolente angelo della pietà. Dato che una cugina prima di mio padre aveva
sposato Roberto, il secondo dei tre fratelli Vlahov e ne ho sempre sentito
parlare in casa, ho poi rintracciato per intervistarlo per il Giorno del
Ricordo 2005 Riccardo Vlahov, figlio di Ramiro, il fratello più giovane.
Riccardo con Maria Luisa Masetti ha pubblicato nel 1987 per conto dell’Istituto
per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna La Fotografia. Tecniche di conservazione e
problemi di restauro, libro considerato pietra miliare nella
ricerca, su basi scientifiche, della conservazione e restauro di foto d’arte. 
Mi ha mandato le foto n.25, 26, 27 della Distilleria Zara di cui era ben
noto l’Amaro e nella 26 si ammira anche lo stemma. La Distilleria fu famosa per
la produzione dell’Amaro Zara.